CAFFARO S.P.A. Torviscosa (UD)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

RIEPILOGO REGIONALE Regione Provincia Comune Codice Ministero Ragione Sociale Attività
RIEPILOGO REGIONALE Regione Provincia Comune Codice Ministero Ragione Sociale Attività FRIULI VENEZIA GIULIA D.Lgs. 105/2015 Soglia Inferiore Gorizia Monfalcone NG046 NORD COMPOSITES Italia S.r.l. (23) Produzione di sostanze chimiche organiche di base Pordenone Maniago NG032 L’ Autogas Orobica s.p.a. (14) Stoccaggio di GPL Trieste Trieste DG011 LINDE GAS ITALIA s.r.l. - Stabilimento di (38) Fabbricazione di sostanze chimiche Trieste (non specificate altrimenti nell’elenco) Udine Carlino DG016 Società Italiana Acetilene & Derivati (22) Impianti chimici SIAD S.p.A. Udine Colloredo di Monte Albano DG004 DIGAS s.r.l. (14) Stoccaggio di GPL Udine Mereto di Tomba DG005 Dipharma Francis s.r.l. (19) Produzione di prodotti farmaceutici Udine Osoppo DG002 Air Liquide Italia Produzione S.r.l. - (39) Altra attività (non specificata altrimenti Stabilimento di Osoppo nell'elenco). Produzione e stoccaggio Ossigeno Udine Pavia di Udine NG035 Cromo Friuli s.r.l. (07) Trattamento di metalli mediante processi elettrolitici o chimici RIEPILOGO REGIONALE Regione Provincia Comune Codice Ministero Ragione Sociale Attività FRIULI VENEZIA GIULIA D.Lgs. 105/2015 Soglia Inferiore Udine Pozzuolo del Friuli DG001 ABS ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU SPA (05) Lavorazione metalli ferrosi (fonderie, fusione ecc.) Udine Pozzuolo del Friuli NG017 Air Liquide Italia Produzione S.r.l. - (39) Altra attività (non specificata altrimenti Stabilimento di Cargnacco nell'elenco). Produzione e stoccaggio Ossigeno Udine Tavagnacco NG031 Tuttogas Spa (13) Produzione, imbottigliamento e distribuzione all'ingrosso di gas di petrolio liquefatto (GPL) Udine Torviscosa NG045 Spin S.p.A. - Torviscosa (19) Produzione di prodotti farmaceutici di base RIEPILOGO REGIONALE Regione Provincia Comune Codice Ministero Ragione Sociale Attività FRIULI VENEZIA GIULIA D.Lgs. -

7E Elenco Delle Ditte
c o n s o r z i o d i b o n i f i c a P I A N U R A F R I U L A N A PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA Decreto della Protezione Civile della Regione n. DCR/703/PC/2015 dd. 31.07.2015 INTERVENTO URGENTE DI PROTEZIONE CIVILE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA A SALVAGUARDIA DEI CENTRI ABITATI E DELLA VIABILITA' DAGLI ALLAGAMENTI ORIGINATI DAL "SISTEMA LAVIE" NEI COMUNI DI BASILIANO, FAGAGNA, MERETO DI TOMBA E SAN VITO DI FAGAGNA. 7e - PIANO PARTICELLARE D'ESPROPRIO Elenco delle ditte IL PROGETTISTA 298 Ing. Massimo Canali Redazione a cura Servizio tecnico consorziale 3 2 1 EMISSIONE 06/06/2018 AB CN MC REV.N° DESCRIZIONE DATA REDATTO CONTROLLATO APPROVATO A TERMINE DI LEGGE IL CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA CONSIDERA QUESTO DOCUMENTO RISERVATO CON DIVIETO PER CHIUNQUE DI RIPRODURLO E/O RENDERLO NOTO A TERZI, IN TUTTO O IN PARTE, SENZA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE SCRITTA servitù di servitù di occupazione transito foglio particella esproprio mq stima VAM importo 1/12 stima importo transito stima importo 1/5 stima importo temporanea mq manutenzione continuo mq mq BACINO B11 COMUNE DI FAGAGNA 30 19 382 € 2,80 € 2,80 € 2.139,20 797 € 0,23 € 185,97 415 € 2,80 € 1.162,00 € 0,56 € 0,00 30 18 280 € 2,80 € 2,80 € 1.568,00 699 € 0,23 € 163,10 € 2,80 € 0,00 419 € 0,56 € 234,64 30 20 241 € 2,80 € 2,80 € 1.349,60 567 € 0,23 € 132,30 € 2,80 € 0,00 326 € 0,56 € 182,56 30 174 35 € 2,80 € 2,80 € 196,00 350 € 0,23 € 81,67 315 € 2,80 € 882,00 € 0,56 € 0,00 30 21 145 € 2,80 € 2,80 € 812,00 310 € 0,23 € 72,33 51 € 2,80 € 142,80 114 € 0,56 € 63,84 30 23 -

Monitoraggio Della Qualità Dell'aria Nella
MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA NELLA ZONA INDUSTRIALE DI CIVIDALE - MOIMACCO (Materiale particolato PM 10 ) *** aggiornamento al 31/12/2018 *** * * * * * * * * SOMMARIO 1. IL MONITORAGGIO DEL MATERIALE PARTICOLATO PM 10 NELLA ZONA INDUSTRIALE DI CIVIDALE – MOIMACCO ................................................................................... Pag. 1 2. IL SITO DI MONITORAGGIO ................................................................................................................... » 1 3. MATERIALE PARTICOLATO PM 10 : dati anno 2018 e confronto con gli anni precedenti ........................................................................................................................................................... » 6 3.1 Materiale Particolato PM 10 : dati anno 2018 ............................................................................................... » 7 3.2 Materiale Particolato PM 10 : confronto dei dati dell’anno 2018 con quelli del periodo 2010-2017...................................................................................................................................................................... » 10 4. VALUTAZIONI CONCLUSIVE .................................................................................................................. » 13 Indice tabelle TAB. 1 Catasto emissioni INEMAR: emissioni di PM 10 (t/anno) per macrosettore ................................ Pag. 6 TAB. 2 PM 10 : principali parametri statistici anno 2018 ......................................................................................... -

Occurrence of the Non-Native Species Ophraella Communa on Ambrosia
Bulletin of Insectology Supplemental Material Title: Occurrence of the non-native species Ophraella communa on Ambrosia artemisiifolia in north-eastern Italy, with records from Slovenia and Croatia Authors: Pietro ZANDIGIACOMO, Francesco BOSCUTTI, Filippo Michele BUIAN, Alberto VILLANI, Patrik WIEDEMEIER, Elena CARGNUS Bulletin of Insectology, Volume 73 June 2020 pages 87-94 Table S1. Occurrence of Ophraella communa in 2017 at 79 sites from north-eastern Italy, western Slovenia and north-western Croatia. Seventy-seven sites with or without the presence of O. communa on Ambrosia artemisiifolia are listed. At two of these sites, each marked with one asterisk (*), O. communa was found on both A. artemisiifolia and Xanthium orientale italicum. In addition, at two sites, each marked with two asterisks (**), O. communa was found on Helianthus annuus and Erigeron canadensis alone, respectively. Localities, dates of observation, habitats and presence/absence of different stages of O. communa are given. Stages of O. communa observed: A: adult; E: egg; L: larva; P: pupa in the cocoon. No beetles: no O. communa eggs or specimens at any development stage present on the host plant. Damage levels to host plant: 0, no trace of feeding damage but adults or eggs of the beetle present; 1, light feeding damage on a few leaves; 2, feeding damage on some leaves; 3, many leaves with feeding damage; 4, defoliation, plants partially dried; 5, complete defoliation and reproductive structures injured. Population levels of O. communa observed per site: very low, less than 5-10 individuals or rare egg clusters; low, less than 20 individuals active, some egg clusters; middle, more than 20 individuals active, several egg clusters; high, massive presence of any of the development stages. -

Monitoraggio Della Qualità Dell'aria Nella Zona
MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA NELLA ZONA INDUSTRIALE DI CIVIDALE - MOIMACCO (Materiale particolato PM 10 ) *** aggiornamento al 31/12/2019 *** * * * * * * * * Sommario 1. IL MONITORAGGIO DEL MATERIALE PARTICOLATO PM10 NELLA ZONA INDUSTRIALE DI CIVIDALE - MOIMACCO ................................................................................................................. 1 2. IL SITO DI MONITORAGGIO ........................................................................................................... 1 3. MATERIALE PARTICOLATO PM10: dati anno 2019 e confronto con gli anni precedenti. .................. 6 3.1. Materiale Particolato PM10: dati anno 2019 ................................................................................... 7 3.2. MATERIALE PARTICOLATO PM10: confronto dei dati dell’anno 2019 con quelli del periodo 2010 – 2018 ................................................................................................................................. 12 4. VALUTAZIONI CONCLUSIVE ......................................................................................................... 15 Indice delle Tabelle Tabella 1: Catasto emissioni INEMAR - emissioni di PM 10 (t/anno) per macrosettore. ........................................ 6 Tabella 2: PM 10 - principali parametri statistici anno 2019. ................................................................................................ 7 Tabella 3: PM 10 – Confronto fra i dati di PM 10 registrati presso la Zona Industriale di Cividale – Moimacco e presso -

Second Report Submitted by Italy Pursuant to Article 25, Paragraph 1 of the Framework Convention for the Protection of National Minorities
Strasbourg, 14 May 2004 ACFC/SR/II(2004)006 SECOND REPORT SUBMITTED BY ITALY PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES (received on 14 May 2004) MINISTRY OF THE INTERIOR DEPARTMENT FOR CIVIL LIBERTIES AND IMMIGRATION CENTRAL DIRECTORATE FOR CIVIL RIGHTS, CITIZENSHIP AND MINORITIES HISTORICAL AND NEW MINORITIES UNIT FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES II IMPLEMENTATION REPORT - Rome, February 2004 – 2 Table of contents Foreword p.4 Introduction – Part I p.6 Sections referring to the specific requests p.8 - Part II p.9 - Questionnaire - Part III p.10 Projects originating from Law No. 482/99 p.12 Monitoring p.14 Appropriately identified territorial areas p.16 List of conferences and seminars p.18 The communities of Roma, Sinti and Travellers p.20 Publications and promotional activities p.28 European Charter for Regional or Minority Languages p.30 Regional laws p.32 Initiatives in the education sector p.34 Law No. 38/2001 on the Slovenian minority p.40 Judicial procedures and minorities p.42 Database p.44 Appendix I p.49 - Appropriately identified territorial areas p.49 3 FOREWORD 4 Foreword Data and information set out in this second Report testify to the considerable effort made by Italy as regards the protection of minorities. The text is supplemented with fuller and greater details in the Appendix. The Report has been prepared by the Ministry of the Interior – Department for Civil Liberties and Immigration - Central Directorate for Civil Rights, Citizenship and Minorities – Historical and new minorities Unit When the Report was drawn up it was also considered appropriate to seek the opinion of CONFEMILI (National Federative Committee of Linguistic Minorities in Italy). -

Spatial Distribution and Biomonitoring of Atmospheric Mercury Concentrations Over a Contaminated Coastal Lagoon (Northern Adriatic, Italy)
Atmosphere 2020, 11 S1 for S1 Spatial Distribution and Biomonitoring of Atmospheric Mercury Concentrations over a Contaminated Coastal Lagoon (Northern Adriatic, Italy) Federico Floreani 1,2, Nicolò Barago 1, Alessandro Acquavita 3,*, Stefano Covelli 1, Nicola Skert 3 and Pablo Higueras 4 1 Department of Mathematics & Geoscience, University of Trieste, Via Weiss 2, 34128 Trieste, Italy; [email protected] (F.F.); [email protected] (N.B.); [email protected] (S.C.) 2 Department of Life Sciences, University of Trieste, Via Giorgieri 5, 34127 Trieste, Italy 3 ARPA FVG Regional Agency for Environmental Protection of Friuli Venezia Giulia, Via Cairoli 14, Palmanova, 33057 Udine, Italy; [email protected] 4 Institute of Applied Geology, Heavy Metals Biogeochemistry Laboratory, University of Castilla-La Mancha, Plaza Manuel Meca, 13400 Almaden, Spain; [email protected] * Correspondence: [email protected]; Tel.: +39-0432-191-8230 Table S1. Basic univariate statistic of gaseous elemental mercury (GEM) dataset and wind and air temperature data during sampling periods. Meteorological data are given as hourly averages. Siap/MICROS: OSMER-ARPA FVG meteorological network, CAE: Protezione Civile Italiana monitoring network. GEM DATA METEOROLOGICAL DATA (ng m-3) WGS84 Meteorological (°C) (km h-1) (°) Meteorological WGS84 Name Site Timedate Mean SD Min Max N° data Lat. Lon. station name Temperature Windmean Dirwindmean network Lat meteo Lon meteo 1 LGM1 Grado Pineta 2013/1/23 11:00 2.68 0.19 2.20 3.10 78 45.678160 -

Pedemontana Colline Pianura
Schede climatiche del Friuli Venezia Giulia SCHEDA CLIMATICA N. 22 osservabile: vento zona: COLLINE, PEDEMONTANA E PIANURA comuni di: Arba, Aviano *, Budoia *, Caneva di Sacile*, Cavasso Nuovo, Fanna, Maniago *, Montereale val Cellina *, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo*, Sequals, Vajont, Arzene, Azzano Decimo, Brugnera, Chions, Cordenons, Cordovado, Fiume Veneto, Fontanafredda, Morsano al Tagliamento, Pasiano di Pordenone, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Pravisdomini, Roveredo in Piano, Sacile, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Quirino, San Vito al Tagliamento, Sesto al Reghena, Spilimbergo, Valvasone, Vivaro, Zoppola (PN); Aiello, Aquileia, Artegna, Attimis *, Bagnaria Arsa, Basiliano, Bertiolo, Bicinicco, Buia, Buttrio, Camino al Tagliamento, Campoformido, Campolongo Tapogliano, Carlino, Cassacco, Castions di Strada, Cervignano, Chiopris, Cividale del Friuli, Codroipo, Colloredo di Montalbano, Corno di Rosazzo, Coseano, Dignano, Faedis *, Fagagna, Fiumicello**, Flaibano, Gonars, Latisana, Lestizza, Magnano, Majano, Manzano, Martignacco, Mereto di Tomba, Moimacco, Mortegliano, Moruzzo, Muzzana, Nimis*, Osoppo, Pagnacco, Palazzolo dello Stella, Palmanova, Pasian di Prato, Pocenia, Porcia di Udine, Porpetto, Povoletto, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Precenicco, Premariacco, Prepotto *, Ragogna, Reana del Roiale, Remanzacco, Rive d'Arcano, Rivignano Teor, Ronchis, Ruda, San Daniele del Friuli, San Giorgio di Nogaro, San Giovanni al Natisone, San Vito al Torre, San Vito di Fagagna, Santa Maria la Longa, Sedegliano, Talmassons, Tarcento *, Tavagnacco, Terzo d'Aquileia, Torreano *, Torviscosa, Treppo Grande, Tricesimo, Trivignano Udinese, Udine, Varmo, Villa Vicentina, Visco (UD); Capriva, Cormons, Dolegna del Collio, Farra d'Isonzo, Fogliano, Gorizia, Gradisca, Mariano, Medea, Moraro, Mossa, Romans, Ronchi dei Legionari, San Canzian d'Isonzo, San Lorenzo Isontino, San Pier d'Isonzo, Savogna d'Isonzo, San Floriano del Collio, Staranzano**, Turriaco, Villesse (GO). -
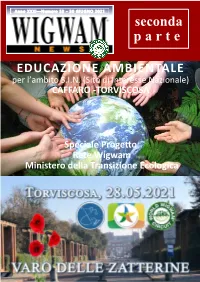
Seconda Parte
Anno XXXI—Numero 53 - 30 GIUGNO 2021 seconda p a r t e EDUCAZIONE AMBIENTALE per l’ambito S.I.N. (Sito di Interesse Nazionale) CAFFARO -TORVISCOSA Speciale Progetto Rete Wigwam Ministero della Transizione Ecologica SOMMARIO SECONDA PARTE 1 - Passato e presente con uno sguardo al futuro di Chiara Pitaccolo 2 - L’Università Castrene nasce dalla medicina sul campo di Darius Sarbu 3 - Vi presento il mio paese, Porpetto nei ricordi e oggi di Alice Pascut 4 - Buongiorno sono Samuel e vi presento Torviscosa di Samuel Collavin 5 - Paparot, panada e brovada, piatti della nonna a Torviscosa di Gabriele Simionato 6 - A San Giorgio di Nogaro c’è l’orto di nonno Firmino di Camilla Fumolo 7 - A San Giorgio di Nogaro era il coprifuoco ma di guerra di Paolo Spadaro 8 - L’agricoltura a Torviscosa, dalla palude al satellitare di Giulio Furlan 9 - A San Giorgio di Nogaro, un po’ di storia e di cultura di Ilaria Drì 10 - Torviscosa, dalle paludi la città industriale del XX sec di Flavio Canciani A cura di: Roberto Cerruti Federica Andrian - Stefano Burgnich Tenente di Vascello Alessia Buso - Lara Clementi Comandante Ufficio Gaetano Marino - Corinne Monte - Circondariale Marittimo Maurizio Scolz - Aldo Tocci di Porto Nogaro Manuela Verona - Chiara Vicentini - Guardia Costiera - Insegnanti dell’Istituto Comprensivo Franco Dario “Università Castrense” dei Comuni di Già insegnante Porpetto, San Giorgio di Nogaro di scuola in vari ordini e grado e Torviscosa (UD) Istituto Wigwam di Studi e Ricerche Con il contributo di: ù Matteo Burattin E gli alunni delle Scuole Secondarie di Dirigente Scolastico Istituto Comprensi- Primo Grado di Porpetto, San Giorgio vo “Università Castrense” di Nogaro e Torviscosa (Ud) Rete Wigwam © Riproduzione riservata Anno XXXI—Numero 34 - 9 MAGGIO 2021 COSTRUIRE COMUNITA ’ CONSAPEVOLI Progetto Ministero della Transizione Ecologica con Rete Wigwam - EDUCAZIONE AMBIENTALE per ambiti S.I.N. -

Comune Di PALAZZOLO DELLO STELLA
Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015 Comune di PALAZZOLO DELLO STELLA Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016 Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015 INDICE Pagina Introduzione 1 1 Sezione 1 - Caratteristiche generali della Popolazione, del territorio, dell'economia insediata e 6 dei servizi dell'Ente: 1.1 Popolazione 7 1.2 Territorio 9 1.3 Servizi 10 1.3.1 Personale 10 1.3.2 Strutture 11 1.3.3 Organismi gestionali 12 1.3.4 Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata 15 1.3.5 Funzioni esercitate su delega 16 1.4 Economia Insediata 17 2 18 2.1 Fonti di finanziamento 19 2.2 Analisi delle risorse 20 2.2.1 Entrate tributarie 20 2.2.2 Contributi e trasferimenti correnti 22 2.2.3 Proventi extratributari 24 2.2.4 Contributi e trasferimenti in conto capitale 27 2.2.5 Proventi ed oneri di urbanizzazione 29 2.2.6 Accensione di prestiti 30 2.2.7 Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa 31 3 Sezione 3 - Programmi e progetti 32 3.1 Considerazioni generali e dimostrazione delle variazioni rispetto all'anno precedente 33 3.2 Obbiettivi degli organismi gestionali dell'ente 33 3.3 Quadro generale degli impieghi per programma 34 3.4 Programmi 35 Relazione Programma 01 39 Relazione Programma 02 42 Relazione Programma 03 43 Relazione Programma 04 46 Relazione Programma 05 47 Relazione Programma 06 49 Relazione Programma 07 50 Prospetto elenco investimenti anno 2014 51 Prospetto elenco investimenti anno 2015 52 Prospetto elenco investimenti anno 2016 53 3.5 Risorse correnti ed in conto capitale per -

Ministero Dell'istruzione, Dell'università E Della
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia Ufficio VI - Ambito territoriale per la Provincia di Udine Via A. Diaz, 60 33100 Udine - tel.: 0432 516111 - C.F. 80003960301 e-mail: [email protected] - pec: [email protected] - web: www.istruzione.udine.it Prot. n. 4277/P/C.03a Udine, 13 giugno 2016 Coord. Infanzia e Primo Ciclo d’Istruzione IL DIRIGENTE VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2016/17, sottoscritto il 8.04.2016; VISTA l’O.M. prot. n. 241, del giorno 8.04.2016 concernente le norme applicative delle disposizioni del contratto sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2016/17; ESAMINATE e valutate le domande di mobilità territoriale e professionale prodotte dai docenti; VISTE le sedi disponibili relative alle scuole Secondaria di I gr. per l’a.s. 2016/17; VISTI gli elenchi dei movimenti per la scuola Secondaria di I gr., a.s. 2016/17, elaborato dal Sistema Informativo del M.I.U.R.; VISTE le disposizioni del M.I.U.R. con le quali si precisa che devono essere pubblicati i bollettini in cui risultano protetti i dati sensibili dei docenti che hanno ottenuto il trasferimento, D E C R E T A i docenti a tempo indeterminato compresi negli elenchi allegati, che fanno parte integrante del presente decreto, vengono trasferiti alla sede di scuola Secondaria di I grado a fianco di ciascuno indicata, con decorrenza dall’anno scolastico 2016/17. -

Udmm000vp6 Provincia Di Udine Udmm001zq2 Distretto
UDMM000VP6 PROVINCIA DI UDINE UDMM000XP4 DOTAZIONE ORGANICA PROVINCIALE (NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO) UDMM001ZQ2 DISTRETTO 001 UDCT70200L CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA TOLMEZZO - (NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) CON SEDE AMMINISTRATIVA IN TOLMEZZO : UDIS014006 DISTRETTI DI COMPETENZA : 001 CON SEDI CARCERARIE : UDMM70201X - TOLMEZZO UDMMA267Q3 COMUNE DI AMPEZZO UDMM82302V M. DAVANZO - AMPEZZO (AS. IST. COM. UDIC82300R/TOT. T. PROL. ) VIA DELLA MAINA N. 29 AMPEZZO UDIC82300R ISTITUTO COMPRENSIVO VAL TAGLIAMENTO - AMPEZZO AMPEZZO - VIA DELLA MAINA N. 29 (NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) CON SEZIONI ASSOCIATE : UDAA82300L - AMPEZZO, UDAA82301N - FORNI DI SOPRA, UDAA82302P - FORNI DI SOTTO, UDAA82303Q - SAURIS, UDAA82304R - SOCCHIEVE, UDAA82305T - ENEMONZO, UDAA82306V - LAUCO, UDEE82301V - AMPEZZO, UDEE82302X - FORNI DI SOPRA, UDEE823031 - FORNI DI SOTTO, UDEE823042 - SAURIS, UDEE823053 - SOCCHIEVE, UDEE823064 - VILLA SANTINA, UDEE823075 - ENEMONZO, UDEE823086 - LAUCO, UDMM82301T - FORNI DI SOPRA, UDMM82302V - AMPEZZO, UDMM82303X - VILLA SANTINA UDMMA447Q0 COMUNE DI ARTA TERME UDMM814024 VIA ROMA - ARTA TERME (ASSOC. ALL'IST. COMPR. UDIC814002) VIA ROMA 14 ARTA TERME (SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) UDMMC918S1 COMUNE DI COMEGLIANS UDMM80901G M. GORTANI - COMEGLIANS (AS. IST. COM. UDIC80900E/TOT. T. PROL. ) VIA ROMA 49/A COMEGLIANS (SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) UDIC80900E ISTITUTO COMPRENSIVO M. GORTANI - COMEGLIANS COMEGLIANS - VIA ROMA 49/A (NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) CON SEZIONI ASSOCIATE : UDAA80900A - COMEGLIANS, UDAA80901B - COMEGLIANS, UDAA80902C - FORNI AVOLTRI, UDAA80903D - OVARO, UDAA80904E - PRATO CARNICO, UDEE80901L - FORNI AVOLTRI, UDEE80902N - OVARO, UDEE80903P - PRATO CARNICO, UDEE80906T - COMEGLIANS, UDMM80901G - COMEGLIANS, UDMM80902L - FORNI AVOLTRI, UDMM80903N - OVARO UDMMD718T2 COMUNE DI FORNI AVOLTRI UDMM80902L RICCARDO ROMANIN (ASSOC.