Caramitti Buon-Ladrone 2017.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Mafia Carini Capaci Isola Delle Femmine E Dintorni
Mafia Carini Capaci Isola delle Femmine e dintorni Comuni sciolti per mafia 25 09 09 Uploaded by isolapulita . - News videos from around the world. Figura 1 Cipriano Santo Inzerillo Gianni SIINO dichiara: DI MAGGIO Salvatore Emanuele Io l’ho conosciuto all’interno della fattoria di Bellolampo intorno alla fine degli anni ’70. I DI MAGGIO hanno avuto varie vicissitudini in negativo all’interno dell’organizzazione mafiosa, perché messi da parte. L’ho rivisto insieme ad un DI MAGGIO detto “u’ figghiu da za’ lena” che mi venne indicato come capo della famiglia di Torretta. I due vennero a raccomandare un imprenditore di Torretta al quale ho fatto aggiudicare, perché loro me lo avevano chiesto, la scuola media di Isola delle Femmine. (Ordinanza di Custodia cautelare Operazione Oldbridge N. 11059/06 R. mod. 21 D.D.A.) Copacabana Di Trapani Isola delle Femmine ............. 1 Copacabana Di Trapani Isola delle Femmine ............. …… Ed è un dato ormai processualmente acquisito che, fino a quando il suo capo indiscusso, Gaetano BADALAMENTI, non fu espulso da Cosa Nostra, la famiglia di Cinisi costituiva uno dei più importanti mandamenti della provincia di Palermo, ricomprendendo, oltre al circondario di Cinisi e Terrasini , anche i territori di Balestrate, Carini, Capaci e Isola delle Femmine (cfr. BUSCETTA, MARINO MANNOIA e MUTOLO, nonché DI MATTEO Mario Santo). Successivamente, il mandamento venne sciolto e la famiglia aggregata al mandamento di Partinico, mentre i territori che ne avevano fatto parte furono divisi tra lo stesso mandamento di Partinico e (dopo il 1982) il neo- mandamento di San Lorenzo , dopo la ristrutturazione seguita alla conclusione della sanguinosa guerra di mafia dei primi anni ’80. -

Ius Novum 3-08.Indd
Ius Novum 3 2008 ISSN 1897-5577 WARSZAWA 2008 KOLEGIUM REDAKCYJNE Marek Chmaj, Teresa Gardocka (przewodnicząca), Bogudar Kordasiewicz, Maria Kruk-Jarosz, Franciszek Longchamps de Bérier, Andrzej Marek, Jerzy Menkes, Henryk Olszewski, Jacek Sobczak (zastępca przewodniczącego) REDAKCJA Ryszard A. Stefański (redaktor naczelny), Andrzej Szlęzak (zastępca redaktora naczelnego), Jacek Kosonoga (sekretarz redakcji) Copyright © by Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie Warszawa 2008 ISSN 1897-5577 Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego 02-662 Warszawa, ul. Świeradowska 43 tel. 0-22 54 35 450, 0-22 54 35 410 www.lazarski.pl [email protected] Opracowanie komputerowe, druk i oprawa: Dom Wydawniczy ELIPSA ul. Infl ancka 15/198, 00-189 Warszawa tel./fax 0-22 635 03 01, 0-22 635 17 85, e-mail: [email protected], www.elipsa.pl SPIS TREŚCI ARTYKUŁ Y Dr Zbigniew Ję drzejewski, UW System i topika w nauce o przestępstwie . 5 Dr Ryszard Szał owski, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Zakres przedmiotowy tajemnicy państwowej . 22 Mgr Adrianna Mię kina, Zabójstwo w środowisku mafijnym . 38 Dr hab. R yszard Stefań s k i, prof. WSHiP Zasady bezpieczeństwa w ruchu w doktrynie i orzecznictwie. Część II. 53 Dr Maria Sobczak, UAM Wolność sumienia i wyznania, jej gwarancje w systemie prawnym Rady Europy oraz w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu . 87 Mgr Aleksandra Gliszczyń s k a, Instytut Nauk Prawnych PAN Zalecenia Europejskiej Komisji przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji w zakresie walki z antysemityzmem oraz ich realizacja przez Polskę . 117 Dr Przemysł aw Szustakiewicz, adiunkt WSHiP Najwyższa Izba Kontroli – czwarta władza czy organ Sejmu . -

Società E Cultura 65
Società e Cultura Collana promossa dalla Fondazione di studi storici “Filippo Turati” diretta da Maurizio Degl’Innocenti 65 1 Manica.indd 1 19-11-2010 12:16:48 2 Manica.indd 2 19-11-2010 12:16:48 Giustina Manica 3 Manica.indd 3 19-11-2010 12:16:53 Questo volume è stato pubblicato grazie al contributo di fondi di ricerca del Dipartimento di studi sullo stato dell’Università de- gli Studi di Firenze. © Piero Lacaita Editore - Manduria-Bari-Roma - 2010 Sede legale: Manduria - Vico degli Albanesi, 4 - Tel.-Fax 099/9711124 www.lacaita.com - [email protected] 4 Manica.indd 4 19-11-2010 12:16:54 La mafia non è affatto invincibile; è un fatto uma- no e come tutti i fatti umani ha un inizio e avrà anche una fine. Piuttosto, bisogna rendersi conto che è un fe- nomeno terribilmente serio e molto grave; e che si può vincere non pretendendo l’eroismo da inermi cittadini, ma impegnando in questa battaglia tutte le forze mi- gliori delle istituzioni. Giovanni Falcone La lotta alla mafia deve essere innanzitutto un mo- vimento culturale che abitui tutti a sentire la bellezza del fresco profumo della libertà che si oppone al puzzo del compromesso, dell’indifferenza, della contiguità e quindi della complicità… Paolo Borsellino 5 Manica.indd 5 19-11-2010 12:16:54 6 Manica.indd 6 19-11-2010 12:16:54 Alla mia famiglia 7 Manica.indd 7 19-11-2010 12:16:54 Leggenda Archivio centrale dello stato: Acs Archivio di stato di Palermo: Asp Public record office, Foreign office: Pro, Fo Gabinetto prefettura: Gab. -

Nomi E Storie Delle Vittime Innocenti Delle Mafie
Nomi e storie delle vittime innocenti delle mafie a cura di Marcello Scaglione e dei ragazzi del Presidio “Francesca Morvillo” di Libera Genova Realizzato in occasione della mostra “900 Nomi vittime di mafia dal 1893 ad oggi” inaugurata ad Imperia il 21 Marzo 2016 in occasione della XXI Giornata della memoria e dell’impegno - ”Ponti di memoria, luoghi di impegno”. I nomi presenti nella mostra sono quelli accertati fino all'anno 2015, ed in particolare quelli letti a Bologna durante la XX Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie (21 marzo 2015). Il lavoro di ricerca, inizialmente limitato a quell'elenco, è stato poi implementato e aggiornato, comprendendo quindi le storie delle vittime innocenti i cui nomi sono stati letti durante la XXI Giornata della Memoria e dell'Impegno (21 marzo 2016). Sarà nostro impegno e cura eseguire successivamente gli aggiornamenti necessari. Siamo inoltre disponibili a intervenire sulle singole storie, laddove dovessero essere ravvisati errori e/o imprecisioni. EMANUELE NOTABARTOLO, 01/02/1893 Nato in una famiglia aristocratica palermitana, presto rimane orfano di entrambi i genitori. Cresciuto in Sicilia, nel 1857 si trasferisce prima a Parigi, poi in Inghilterra, dove conosce Michele Amari e Mariano Stabile, due esuli siciliani che lo influenzeranno molto. Avvicinatosi all'economia e alla storia, diventa sostenitore del liberalismo conservatore (quindi vicino alla Destra storica). Dal 1862 Emanuele Notarbartolo diventa prima reggente, poi titolare, del Banco di Sicilia, al quale si dedica a tempo pieno a partire dal 1876, salvandolo dal fallimento in seguito all'Unità d'Italia. Il suo lavoro al Banco di Sicilia inizia a inimicargli molta gente. -

“FINE PENA: ORA” DI ELVIO FASSONE Di Davide Galliani
Rivista di Studi e Ricerche sulla Criminalità Organizzata Cross Vol.2 N°1 (2016) ISSN 2421-5635 Rivista di Studi e Ricerche sulla criminalità organizzata INDICE Presentazione QUESTO NUMERO di N.d.C ....................................................................................................................................................................... 1 Recensione/dibattito 1 RIFLESSIONI SPARSE SUL DELITTO DI ASSOCIAZIONE MAFIOSA. A PARTIRE DALLA TERZA EDIZIONE DEL LIBRO DI GIULIANO TURONE di Fabio Basile ......................................................................................................................................................... 3 Recensione/dibattito 2 UNA QUESTIONE DI LIMITI. A PROPOSITO DI “FINE PENA: ORA” DI ELVIO FASSONE di Davide Galliani ................................................................................................................................................ 13 Dibattito LA MOBILITASION ANTIMAFIA DE 1992 di Charlotte Moge ................................................................................................................................................ 32 La ricerca 1 TRA NARCOS E STATO. LE FORME DELLA RESISTENZA CIVILE IN MESSICO di Thomas Aureliani ........................................................................................................................................... 61 La ricerca 2 A PROPOSITO DI MAFIA CAPITALE. SPUNTI PER TIPIZZARE IL FENOMENO MAFIOSO NEI SISTEMI DI COMMON LAW di Anna Sergi ........................................................................................................................................................ -

Liberarci Dalle Spine.Indd
LIBERARCI DALLE SPINE I campi di lavoro antimafia dei giovani toscani nell’agosto siciliano www.regione.toscana.it LIBERARCI DALLE SPINE I campi di lavoro antimafia dei giovani toscani nell’agosto siciliano I campi di lavoro antimafia dei giovani toscani nell’agosto siciliano LIBERARCI DALLE SPINE I campi di lavoro antimafia dei giovani toscani nell’agosto siciliano Regione Toscana Assessorato alla Cultura Direzione Generale Organizzazione e Sistema Informativo Centro documentazione cultura legalità democratica Testi di Francesca Balestri Da anni faccio parte di ARCI Nuova Associazione dove mi interesso di “Nuovi Diritti Sociali”: essere educati alla legalità è secondo noi uno dei diritti dei giovani cittadini, un diritto per noi “nuovo” di cui vari soggetti associativi e non si occupano ormai da anni attraverso metodi più o meno tradizionali come progetti e in- contri nelle scuole. L’Arci invece ha deciso di realizzare questo percorso di “educazione alla cittadinanza” attraverso l’inedito strumento dei campi di lavoro estivi, per far “toccare con mano” ai ragazzi e alle ragazze la realtà della quale si sta parlando, facendo loro conoscere una pagina importante della storia e della cultura del nostro paese e dando loro nel contempo l’opportunità di fare qualcosa di concreto e di farsi un’opinione sul delicato argomento della criminalità organizzata. Il diario racconta questi campi e i suoi tanti momenti solenni e di vita quotidiana intrecciati insieme attraver- so i miei occhi e il mio punto di vista che è certamente, per sua natura, parziale, ma che è anche il risultato di tanti scambi di opinione, battuta e attimi vissuti insieme a tutti ragazzi e alle ragazze che sono stati i diretti protagonisti di questa appassionante esperienza. -
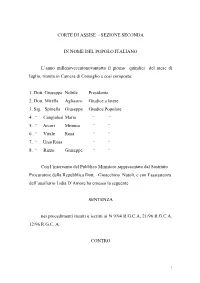
Processo Lima
CORTE DI ASSISE - SEZIONE SECONDA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO L’anno millenovecentonovantotto il giorno quindici del mese di luglio, riunita in Camera di Consiglio e così composta: 1. Dott. Giuseppe Nobile Presidente 2. Dott. Mirella Agliastro Giudice a latere 3. Sig. Spinella Giuseppe Giudice Popolare 4. “ Cangialosi Maria “ “ 5. “ Arceri Mimma “ “ 6. “ Vitale Rosa “ “ 7. “ Urso Rosa “ “ 8. “ Rizzo Giuseppe “ “ Con l’intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Sostituto Procuratore della Repubblica Dott. Gioacchino Natoli, e con l’assisstenza dell’ausiliario Lidia D’Amore ha emesso la seguente SENTENZA nei procedimenti riuniti e iscritti ai N 9/94 R.G.C.A, 21/96 R.G.C.A. 12/96 R.G.C. A. CONTRO 1 1) RIINA Salvatore n. Corleone il 16.11.1930 Arrestato il 18.01.1993 - Scarcerato il 05.05.1997 LIBERO- Detenuto per altro - Assente per rinunzia Assistito e difeso Avv. Cristoforo Fileccia Avv. Mario Grillo 2) MADONIA Francesco n. Palermo il 31.03.1924 Arrestato il 21.04.1995 - Scarcerato il 05.05.1997 LIBERO - Detenuto per altro - Assente per Rinunzia Assistito e difeso Avv. Giovanni Anania Avv. Nicolò Amato del foro di Roma 3) BRUSCA Bernardo n. San Giuseppe Jato il 09.09.1929 Arrestato il 21.10.1992 - Scarcerato il 05.05.1997 LIBERO - Detenuto per altro - Assente per Rinunzia Assistito e difeso Avv. Ernesto D’Angelo 4) BRUSCA Giovanni n. San Giuseppe Jato il 20.02.1957 Arrestato il 23.05.1996 - Scarcerato il 10.04.1998 LIBERO - Detenuto per altro - Assente per Rinunzia Assistito e difeso Avv. Luigi Li Gotti del foro di Roma Avv. -

LUCIANO VIOLANTE INDICE Pag
<pre> Pag. 1219 AUDIZIONE DEL COLLABORATORE DI GIUSTIZIA GASPARE MUTOLO PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LUCIANO VIOLANTE INDICE pag. Audizione del collaboratore di giustizia Gaspare Mutolo: Violante Luciano, Presidente .................... 1221, 1222 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326 Acciaro Giovanni Carlo ................................ 1316 Bargone Antonio ................................. 1316, 1325 Biondi Alfredo .......... 1250, 1292, 1297, 1303, 1311, 1315 1325 Borghezio Mario ................................. 1315, 1316 Pag. 1220 Boso Erminio Enzo ..................................... 1315 Brutti Massimo .................................. 1315, 1316 Buttitta Antonino ..................................... 1317 Folena Pietro ................................... 1316, 1317 Galasso Alfredo ....................................... 1316 Imposimato Ferdinando ................................. 1325 Matteoli Altero ......... 1226, 1242, 1303, 1314, 1315, 1326 Mutolo Gaspare ......... -

Processo Omicidio Francese
CORTE DI ASSISE DI APPELLO PALERMO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO L’anno duemiladue il giorno 13 del mese di dicembre N° 61/2002 Sent. LA CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI PALERMO N° 30/2002 R.G. SEZIONE SECONDA N° 1314/96 N.R. composta dai Sigg.ri : D.D.A. PA 1. Dott.1 Vincenzo OLIVERI Presidente Art. ______________ 2. Dott.2 Gianfranco GAROFALO Consigliere Camp. Penale 3. Sig.3 Giovanni INCANDELA Giud. Popolare Art.______________ 4. Sig.4 Giovanni GAROFALO “ “ Campione Civile 5. Sig.5 Isabella ZUMMO “ “ 6. Sig.6 Nicola TURRISI “ “ Compilata scheda per il Casellario e per 7. Sig.7 Antonio RIGGIO “ “ l’elettorato Addì______________ 8. Sig.8 Giuseppa GIAMMARINARO “ “ Depositata in con l’intervento del Sostituto Procuratore Generale Dott. Cancelleria Antonino GATTO e con l’assistenza del cancelliere B3 Sig. Addì_______________ Aurelio DI CRISTINA ha pronunziato la seguente Irrevocabile il _________________ S E N T E N Z A nei confronti di : 1) RIINA SALVATORE, fu Giovanni e Rizzo Maria Concetta, nato a Corleone il 16.11.1930 ed ivi residente in via La Rua del Piano n. 13. Detenuto in forza di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 12.11.1998 dal G.I.P. presso il Tribunale di Palermo, notificata in carcere il 17.11.1998, in atto presso la Casa Circ.le di Ascoli Piceno. ASSENTE PER RINUNZIA Difensori: Avv. Cristoforo Fileccia del Foro di Palermo Avv. Domenico La Blasca “ “ 1 2) MADONIA FRANCESCO, fu Antonino e fu Trapani Rosa, nato a Palermo il 31.3.1924 ed ivi residente via Patti n. -

LA MAFIA PALERMITANA Fazioni, Risorse, Violenza (1943-1993)
EDIZIONI LA MAFIA PALERMITANA Fazioni, risorse, violenza (1943-1993) di Vittorio Coco Coco, Vittorio <1980-> La mafia palermitana / Vittorio Coco – Palermo : Centro di studi ed iniziative culturali Pio La Torre, 2010. (Collana studio e ricerca) 1. Mafia - Palermo - 1943-1993. 364.10609458231 CDD-21 SBN Pal0224465 CIP – Biblioteca centrale della Regione siciliana “Alberto Bombace” Comitato Scientifico: Prof. Guido Corso, Prof. Alessandra Dino e Prof. Salvatore Lupo. 5 Nota editoriale di Vito Lo Monaco, Presidente Centro Pio La Torre 7 Prefazione di Salvatore Lupo, storico 9 Introduzione 11 Il contesto La Piana dei Colli e lo sviluppo urbano di Palermo dal secondo dopoguerra Parte Prima Tra gli anni Cinquanta e Sessanta. Al centro della ripresa postbellica 23 Mafia ed edilizia: il costruttore Francesco Vassallo 31 L’ascesa di Angelo La Barbera 39 Da una guerra all’altra Parte Seconda Tra gli anni Settanta e Ottanta. Ai margini dopo l’antimafia 45 La perdita della centralità 51 Al fianco dei corleonesi 55 Dal maxi-processo alla riconquista dell’autonomia 61 Indice dei nomi 65 Indice dei luoghi di Vito Lo Monaco La ricerca di Vittorio Coco, a seguito di un bando pubblico del Centro Studi Pio La Torre che ha impegnato parte del contributo finanziario della Regione Sicilia, fa parte di un insieme di studi in via di pubblicazione. Per un anno tra il 2008 e il 2009 sei giovani ricercatori, guidati volontariamente da rispettivi comitati scientifici e tutor di alto profilo, hanno lavorato con tanto profitto da convincere il Centro a proseguire la ricerca nel 2010. L’idea generale della ricerca riguarda l’esplorazione della complessità del fenomeno ma- fioso tramite l’osservazione della storia e del rapporto col territorio di “famiglie” le cui relazioni interne ed esterne circoscrivono la natura specifica dell’organizzazione mafiosa e il suo rapporto organico con le classi dirigenti. -

900-Criminale-2.0.Pdf
A cura dell’Associazione Lapsus 2 INDICE Prefazione 6. I riti della Mafia 1. Introduzione alla mostra 7. Gli anni settanta 7.1 POLITICA, CONFLITTI E MASSONERIA: LA 2. Italia liberale ‘NDRANGHETA SI ESPANDE 2.1 LE ORIGINI DELLA ‘NDRANGHETA: LA 7.2 L’ASCESA DELLA NUOVA CAMORRA PICCIOTTERIA CALABRESE ORGANIZZATA 2.2 LA BELLA SOCIETÀ RIFORMATA 7.3 LA CONQUISTA MAFIOSA DEL NARCOTRAFFICO 2.3 LA GENESI DELLA MAFIA: UN “CRIMINOSO 7.4 LEONARDO VITALE: IL PENTITO SODALIZIO” 2.4 UN OMICIDIO ECCELLENTE IL DELITTO 8. Pentitismo e Omertà NOTARBARTOLO 9. Gli anni ottanta 2.5 LA FINE DELLA BELLA CAMORRA 9.1 IL CONSOLIDAMENTO DEL POTERE 3. Il ventennio fascista ‘NDRANGHETISTA 3.1 ‘NDRANGHETA E FASCISMO: CONFLITTO E 9.2 IL CONFLITTO TRA NUOVA FAMIGLIA E NCO INTEGRAZIONE 9.3 L’ESCALATION DELLA VIOLENZA: LA SECONDA 3.2 IL “MAGGIORE DI FERRO” GUERRA DI MAFIA 3.3 LA MAFIA AI FERRI CORTI 9.4 IL TERREMOTO DEL 1980 IN CAMPANIA E IL 3.4 SBARCO ALLEATO SISTEMA DEGLI APPALTI 9.5 GIANCARLO SIANI 4. Il dopoguerra 4.1 L’ITALIA SCOPRE LA “‘NDRANGHITA” 10. Gli anni novanta 4.2 TRA CONTRABBANDO E AGGIOTAGGIO: LA 10.1 DA SAN LUCA A DUISBURG UN PRIMATO RINASCITA DELLA CAMORRA MONDIALE 4.3 TRA CITTÀ E CAMPAGNA: IL RIASSETTO DELLA 10.2 I NUOVI EQUILIBRI IN TERRA DI CAMORRA: MAFIA L’ASCESA DEI CASALESI 4.4 LA STRAGE DI PORTELLA DELLA GINESTRA 10.3 LE STRAGI DI MAFIA E L’AVVENTO DELLA 4.5 LA MAFIA “BUONA” SECONDA REPUBBLICA 10.4 IL MAXIPROCESSO 5. -

RPG Phd Thesis
Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/85513 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Peña González R. Title: Order and Crime: Criminal Groups ́ Political Legitimacy in Michoacán and Sicily Issue Date: 2020-02-20 Chapter 5. Cosa Nostra: Tracking Sicilian Mafia’s Political Legitimacy At 2012, El Komander, popular Mexican "narco-singer", released his new single entitled "La mafia se sienta en la mesa" (Mafia Takes a Sit on the Table). El Komander, the artistic name of Alfredo Ríos, as well as other performers of the so-called narcocorridos (or, as it was later named, movimiento alterado) were forbidden to perform public concerts in Mexico. That was also the case in Michoacán, where a local public officer argued that Komander's ban was due to the lyric´s songs, which touch "very sensitive topics" (Velázquez, 2018). Certainly, most of his songs are dedicated to assert Mexican "narcos" as stylish and brave popular heroes. However, the lyrics of "La mafia se sienta a la mesa" were slightly different. Instead of glorifying exclusively Mexican “narcos”, this song did “[…] a twentieth-century history seen from the mafia’s point of view” (Ravveduto, 2014), in which “someone” in Sicily did start “everything”: “En un pueblito en Sicilia, un hombre empezó las cosas. Fue el padrino en la familia y fundó la Cosa Nostra. Desde Italia a Nueva York, traficó vino y tabaco. La mafia lo bautizó, fue el primer capo de capos” (In a small town in Sicily, a man started everything. He was the godfather in the family, and founded the Cosa Nostra.