Valutazione Ambientale Del PIUSS
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Successe in Valdichiana
Successe in Valdichiana Copyright - © - 2010 - Thesan & Turan S.r.l. Via San Donato, 12 - 53045 Montepulciano (Si) www.thesaneturan.it ISBN 9 Alessandro Angiolini SUCCESSE IN VALDICHIANA Storie, luoghi e personaggi THESAN & TURAN EDITORE Prefazione dell’autore Ho raccolto in questo libro quasi un decennio di scritti nati dalla passione per la storia della mia terra, la Valdichiana. Una ela- borazione di una parte dei testi pubblicati negli anni su giornali e periodici toscani ai quali ancora oggi collaboro, o meglio, una dovuta rielaborazione con aggiunte di notizie e approfondimenti descrittivi resi possibili dalla libertà di battute che ti può concede- re una pubblicazione. Forse non leggerete nulla di nuovo di quello che è già stato scritto su questa terra da autori illustri negli anni e nei secoli pas- sati, ma nonostante questo credo di essere riuscito, senza lode e senza infamia, in modo scorrevole e semplice, a descrivere una serie di avvenimenti con una visione diversa dal solito raccontare, con qualche piccola ed inedita scoperta e con la consapevolezza che la storia, a volte, è anche intuizione. In queste pagine ho riversato il mio amore per la storia studiata in centinaia di libri e documenti, vecchi e nuovi, validi e meno validi, intonsi e strappati, appunti scarabocchiati da chissà chi, magari alcuni rarissimi recuperati per volontà del destino dall’oblio della spazzatura della carta straccia. E i protagonisti che troverete nei trentadue capitoli di questo libro saranno i nomi di vecchie strade e i loro millenari percorsi, i toponimi dimenticati che indicano ancora il passaggio di perdute vie etrusche e romane, le vicende di antichi luoghi abitati e oggi sconosciuti, le pionieristiche ferrovie con le loro stazioni nate e abbandonate, sognate o mai realizzate. -

MONTEPULCIANO's PALAZZO COMUNALE, 1440 – C.1465: RETHINKING CASTELLATED CIVIC PALACES in FLORENTINE ARCHITECTURAL and POLITI
MONTEPULCIANO’S PALAZZO COMUNALE, 1440 – c.1465: RETHINKING CASTELLATED CIVIC PALACES IN FLORENTINE ARCHITECTURAL AND POLITICAL CONTEXTS Two Volumes Volume I Koching Chao Ph.D. University of York History of Art September 2019 ABSTRACT This thesis argues for the significance of castellated civic palaces in shaping and consolidating Florence’s territorial hegemony during the fifteenth century. Although fortress-like civic palaces were a predominant architectural type in Tuscan communes from the twelfth century onwards, it is an understudied field. In the literature of Italian Renaissance civic and military architecture, the castellated motifs of civic palaces have either been marginalised as an outdated and anti-classical form opposing Quattrocento all’antica taste, or have been oversimplified as a redundant object lacking defensive functionality. By analysing Michelozzo’s Palazzo Comunale in Montepulciano, a fifteenth-century castellated palace resembling Florence’s thirteenth-century Palazzo dei Priori, this thesis seeks to address the ways in which castellated forms substantially legitimised Florence’s political, military and cultural supremacy. Chapter One examines textual and pictorial representations of Florence’s castellation civic palaces and fortifications in order to capture Florentine perceptions of castellation. This investigation offers a conceptual framework, interpreting the profile of castellated civic palaces as an effective architectural affirmation of the contemporary idea of a powerful city-republic rather than being a symbol of despotism as it has been previously understood. Chapters Two and Three examine Montepulciano’s renovation project for the Palazzo Comunale within local and central administrative, socio-political, and military contexts during the first half of the fifteenth century, highlighting the Florentine features of Montepulciano’s town hall despite the town’s peripheral location within the Florentine dominion. -
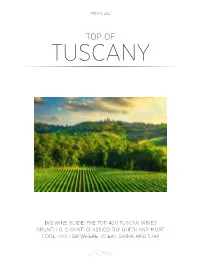
Top of Tuscany
SPECIAL 2021 TOP OF TUSCANY BIG WINE GUIDE: THE TOP 400 TUSCAN WINES BRUNELLO, CHIANTI CLASSICO, BOLGHERI AND MORE COOL TIPS FOR WHERE TO EAT, DRINK AND STAY Contents 05 Trends & facts 2020/2021 08 The three tenors Legends that have made history 14 The magnificent seven Talents of the year 19 Top 5 white wines The best white wines of the year 20 Top 10 red wines Editorial The best red wines of the year 22 Best buys 2020 10 wines offering top value for money ow that our lives are centred primarily on our own gardens and our own wine cellars (where time and finances allow), we have much more leisure 24 Vernaccia San Gimignano to do what we wish. COVID-19 has affected many things, including our N 28 Maremma view of ourselves as wine connoisseurs and quasi-globetrotters. The majority of our tours of Italy and Tuscany planned for spring and summer 32 Morellino die Scansano DOCG 2020 were limited to the works of Fruttero & Lucentini (especially their ’The Pal- io of Dead Riders’, the best Siena book of all) and to exploring the depths of var- 35 Montecucco ious bottles of mature Brunello, Chianti Classico, Vino Nobile or Bolgheri Supe- 38 Brunello di Montalcino riore. However, things will eventually change, and if you should find the time to flick through this edition of Top of Tuscany as you rekindle your wanderlust with 46 Vino Nobile die Montepulciano a glass of Tignanello or Masseto, we would be delighted. The following pages offer a colourful mix of wine stories, and above all a wealth 50 Chianti Classico DOCG of bottles tasted: we have selected more than 400 from all over Tuscany, with 145 granted the ’Top of Tuscany’ accolade. -

Abbadia Ardenga Il Poggio Via Romana, 139 SIENA (SI
Abbadia Ardenga Il Poggio Antinori Chianti Classico Via Romana, 139 Via Cassia per Siena, 133 SIENA (SI) SAN CASCIANO VAL DI PESA (FI) 0577834150 0552359700 [email protected] [email protected] Agricola Tamburini Argiano S.p.a. Soc. Agricola via Catignano n. 106 Loc. Sant' Angelo in Colle GAMBASSI TERME (FI) MONTALCINO (SI) 0571680235 0577844037 [email protected] [email protected] Agricoltori Del Chianti Geografico Azienda Agricola Marini Giuseppe Loc. Mulinaccio 10 Via Bartolomeo Sestini 274 GAIOLE IN CHIANTI (SI PISTOIA (PT) 0577749489 0573452096 [email protected] [email protected] Antinori Agricola Fattoria La Braccesca Baldetti Alfonso Via Stella Di Valiano 10 Località Pietraia, 71 MONTEPULCIANO (SI) CORTONA (AR) 0578724252 057567077 [email protected] [email protected] Barone Ricasoli Spa Carpineto Loc. Madonna a Brolio Loc. Dudda 17/B GAIOLE IN CHIANTI (SI) GREVE IN CHIANTI (FI) 0577730220 0558549062 [email protected] [email protected] Bindella Casa Vinicola Triacca Via delle Tre Berte, 10/A Strada per Pienza, 39 MONTEPULCIANO (SI) MONTEPULCIANO (SI) 0578767777 0578757774 [email protected] [email protected] Biondi Santi - Tenuta Greppo Casato Prime Donne Villa Greppo 183 Loc. Casato, 17 MONTALCINO (SI) MONTALCINO (SI) 0577848087 0577849421 [email protected] [email protected] Borgo Santinovo Castellare di Castellina (Nettuno SARL) Località Santinovo Loc. Castellare COLLE DI VAL D'ELSA (SI) CASTELLINA IN CHIANTI (SI) 0577971048 0577742903 [email protected] -

Pagina 1 Realizzazione Di Nuove Reti in Fibra Ottica Per La Connettività In
Realizzazione di nuove reti in fibra ottica per la connettività in Banda Larga – Modello A Stato Avanzamento Lavori al 17 Agosto 2018 Data prevista per Stato lavori Fibra Ottica n. Provincia Comune Località l'attivazione del servizio (a cura della Regione Toscana) (a cura dell'Operatore) 1 Arezzo Cavriglia Cavriglia connessa attivata 2 Arezzo Pian di Sco Faella connessa attivata 3 Arezzo Pian di Sco Pian Di Sco connessa attivata 4 Arezzo Poppi Moggiona connessa attivata 5 Arezzo Arezzo Frassineto connessa attivata 6 Arezzo Bibbiena Serravalle connessa attivata 7 Arezzo Bucine Pietraviva connessa attivata 8 Arezzo Capolona Castelluccio connessa attivata 9 Arezzo Castiglion Fiorentino Manciano connessa attivata 10 Arezzo Castiglion Fiorentino Montecchio connessa attivata 11 Arezzo Castiglion Fiorentino S. Cristina connessa attivata 12 Arezzo Cavriglia S. Barbara connessa attivata 13 Arezzo Chitignano Chitignano connessa attivata 14 Arezzo Chiusi della Verna Chiusi della Verna connessa attivata 15 Arezzo Chiusi della Verna Rimbocchi connessa attivata 16 Arezzo Civitella in Val di Chiana Ciggiano connessa attivata 17 Arezzo Cortona Pergo connessa attivata 18 Arezzo Cortona Tavarnelle connessa attivata 19 Arezzo Loro Ciuffenna Persignano connessa attivata 20 Arezzo Montevarchi Mercatale connessa attivata 21 Arezzo Ortignano Raggiolo Ortignano connessa attivata 22 Arezzo Poppi Badia Prataglia connessa attivata 23 Firenze Bagno a Ripoli S.Donato In Collina connessa attivata 24 Firenze Barberino Val d'Elsa Marcialla connessa attivata Pagina 1 -

WINES and SPIRITS CATALOG September - December 2019
WINES AND SPIRITS CATALOG September - December 2019 Customer Service: 844.824.0422 epic-winesandspirits.com [email protected] EXECUTIVE TEAM Justin Sternberg President [email protected] Ryan Norton Executive Vice President, Trade and Business Development [email protected] Bill Young Executive Vice President, Sales [email protected] Tiffany Miller Vice President, Purchasing & Administration [email protected] NORTHERN CALIFORNIA Bryan Lewis Vice President General Market Northern California 707.293.4980 [email protected] John Arata Area Manager - Central Valley 916.217.6252 [email protected] James Peterson Area Manager – North Bay 970.331.2003 [email protected] Kevin Finkas Area Manager – San Francisco / East Bay 707.334.4868 [email protected] Stacey Nolan Area Manager – Santa Cruz & Monterey 831.419.8640 [email protected] SOUTHERN CALIFORNIA Marc Chaiet Vice President General Market Southern California 310.995.7896 [email protected] Cameron Russell Area Manager – West LA 310.795.1461 [email protected] Naureen Zaim Area Manager – Downtown LA/ Hollywood 310.592.9038 [email protected] David Brodowsky Area Manager – Santa Barbara & Central Coast 805.421.7649 [email protected] Mike King Area Manager – San Diego & Desert Cities 805.709.3565 [email protected] Michael Clayton Area Manager – Orange Co., Inland Empire & Long Beach -

La Via LAURETANA Strada Di Artisti E Pellegrini
in ricordo di Felice Panichi PREFAZIONE Un affresco, una via di pellegrinaggio Sono particolarmente lieto di vedere pronta per la divulgazione, qui ad Asciano, con un libro ed una mostra, una ricca documentazione storica e artistica raccolta con entusiasmo e competenza, in questi ultimi mesi di intenso lavoro, da un gruppo di studiosi del luogo, con i quali ho avuto il piacere di collaborare sin dal principio di questa iniziativa, mettendo a disposizione tutto quanto delle mie ricerche, cominciate nel lontano 1984, poteva loro servire. Si apre così ad Asciano, al grande pubblico, a chi vorrà leggere la pubblicazione, vedere la mostra e percorrere gli itinerari proposti, un mondo, un territorio, tutto da riscoprire, che si rivela modellato nei secoli da avvenimenti storici, da realizzazioni artistiche, da espressioni di devozione e di fede. E’ la Via Lauretana, che dopo un lungo periodo di dimenticanza, viene riscoperta, pubblicamente, per quello che in effetti è stata per secoli, una importante e frequentata via di pellegrinaggio, che convogliava pellegrini della Francigena e del territorio toscano verso la Santa Casa di Loreto. Con questa nuova consapevolezza, tutto apparirà più chiaro, ai residenti come ai visitatori, agli storici come agli amanti dell’arte, agli studiosi delle vie di pellegrinaggio di ieri come di quelle di oggi; e saranno chiaramente più leggibili il tracciato della strada, che punta da Siena attraverso le Crete, verso Loreto, le immagine sacre, i tabernacoli, le edicole viarie, le cappelle che la impreziosiscono, il numero e la ricchezza delle chiese, delle sedi di confraternite, di conventi, spedali, luoghi di accoglienza, taverne, fonti di acqua che vi si trovano. -

Orario Degli Autobus Urbani Di Siena
Linea 001 /A VIA TOZZI - VIA GALLORI - V.TOZZI ID.Corsa 7414 7841 7369 7842 7370 7371 7393 7372 7373 7394 7374 7375 7395 7376 7377 7396 Subconcessionario BY BUS TRA.IN. BY BUS TRA.IN. TRA.IN. TRA.IN. TRA.IN. TRA.IN. TRA.IN. TRA.IN. TRA.IN. TRA.IN. TRA.IN. TRA.IN. TRA.IN. TRA.IN. Concessionario BY BUS TRA.IN. BY BUS TRA.IN. TRA.IN. TRA.IN. TRA.IN. TRA.IN. TRA.IN. TRA.IN. TRA.IN. TRA.IN. TRA.IN. TRA.IN. TRA.IN. TRA.IN. Validità/Frequenza ! " ! " ! ! " ! ! " ! ! " ! ! " SIENA PIAZZA GRAMSCI 6:20 6:20 SIENA VIA TOZZI 6:40 6:40 7:10 7:40 7:45 8:10 8:40 8:45 9:10 9:40 9:45 10:10 10:40 10:45 SIENA V.LE XXIV MAGGIO 6:23 6:23 SIENA VIALE VITTORIO VENETO 6:42 6:42 7:12 7:42 7:47 8:12 8:42 8:47 9:12 9:42 9:47 10:12 10:42 10:47 SIENA V.N.SAURO 6:43 6:43 7:13 7:43 7:48 8:13 8:43 8:48 9:13 9:43 9:48 10:13 10:43 10:48 SIENA V.PESCAIA 6:26 6:26 6:44 6:44 7:14 7:44 7:49 8:14 8:44 8:49 9:14 9:44 9:49 10:14 10:44 10:49 SIENA V. DI COLLINELLA 6:28 6:28 6:48 6:48 7:18 7:48 7:53 8:18 8:48 8:53 9:18 9:48 9:53 10:18 10:48 10:53 SIENA POGGIO AL VENTO 6:29 6:29 6:48 6:48 7:18 7:48 7:53 8:18 8:48 8:53 9:18 9:48 9:53 10:18 10:48 10:53 SIENA ST.CAPPUCCINI 6:31 6:31 6:51 6:51 7:21 7:51 7:56 8:21 8:51 8:56 9:21 9:51 9:56 10:21 10:51 10:56 SIENA V.STROZZI 6:55 6:55 7:25 7:55 8:00 8:25 8:55 9:00 9:25 9:55 10:00 10:25 10:55 11:00 SIENA P.DIAVOLI 6:34 6:34 6:57 6:57 7:27 7:57 8:02 8:27 8:57 9:02 9:27 9:57 10:02 10:27 10:57 11:02 SIENA V.LE CAVOUR 6:36 6:36 6:59 6:59 7:29 7:59 8:04 8:29 8:59 9:04 9:29 9:59 10:04 10:29 10:59 11:04 SIENA PORTA CAMOLLIA 6:37 6:37 7:00 7:00 7:30 8:00 8:05 8:30 9:00 9:05 9:30 10:00 10:05 10:30 11:00 11:05 SIENA V LE V.VENETO SIENA V.LE XXIV MAGGIO SIENA V.LE CADORNA. -

TAPPE VIA LAURETANA Da SIENA a CORTONA
TAPPE VIA LAURETANA da SIENA a CORTONA SIENA – VESCONA Difficoltà lunghezza totale tempo di percorrenza E 19,6 KM 4 h 45 min. dislivello positivo dislivello negativo quota massima 430 m - 395 m 365 mslm DESCRIZIONE Lasciata la meravigliosa Piazza del Campo si prende per via del Pantaneto e la si segue fino ad incrociare sulla sinistra via dei Pispini che ci condurrà direttamente ad una delle porte più antiche della città, ovvero Porta Pispini. Oltrepassata la porta e attraversata la strada, si prende per via Sant’Eugenia che, scendendo, ci riporterà su via Aretina e di lì, seguendo la banchina segnalata per pedoni, si arriva nei pressi della rotonda sulla ss 73 in loc. Due Ponti. Mantenendo la destra si segue prima il marciapiede e poi una comoda ciclo pedonale fino all’attraversamento della ss 73 Senese-Aretina. Da qui si segue la strada per Ruffolo stando sempre attenti a mantenersi sul marciapiede (sono presenti appositi attraversamenti). Arrivati al circolo ricreativo e davanti al ristorante Ruffolo avremmo fatti circa 5 km; da qui si prosegue inizialmente su banchina pedonale e poi su marciapiede fino all’abitato di Taverne d’Arbia. Superato l’abitato di Taverne d’Arbia, dove possiamo trovare ogni genere di servizio, si passa il ponte sul fiume Arbia (prestare attenzione al traffico in quanto il ponte è stretto). Al di là del Ponte si segue un comodo marciapiede fino all’abitato di Arbia in cui è presente l’omonima stazione ferroviaria e un punto informazioni del Comune di Asciano. Usciti da Arbia si segue la provinciale Lauretana (SP 438) fino ad imboccare la strada sterrata sulla destra per Loc. -

MODULO Richiesta Autorizzazione CORVIDI In
ATC 8 SIENA SUD Viale Dante, 23 – 53042 Chianciano Terme (SI) Tel. 057861259 Email. [email protected] DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE CACCIA CORVIDI IN ZRV ANNO 2021 N.B. SI PREGA DI SCRIVERE CHIARO ED IN STAMPATELLO. TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI Cognome: _____________________________________ cod. Cacciatore: _________ Nome: ________________________________C.F.___________________________ Indirizzo: _____________________________________ Comune: _____________________________________ CAP: _____________________________________ PR: ____ Regione: ________________________ Telefono: _____________________________________ Email: _____________________________________ Ai sensi della Delibera di Giunta n. 1693 del 29/12/20 Chiede di essere autorizzato al prelievo di gazza e cornacchia grigia nella (riportare il nome esatto della ZRV come da schema sottostante) ZRV ________________________________ Con la presente ATC 8 Siena Sud, comunica che i dati personali ed ogni altro elemento necessario per l’adesione alla battuta di caccia alla volpe, saranno soggetti a vincolo di segretezza come previsto dal Regolamento UE 679/2016, inoltre, saranno trattati dal personale ATC 8 Siena Sud esclusivamente per il fine richiesto ed il loro periodo di conservazione sarà quello previsto dalle norme di legge. Tutto sarà svolto nel rispetto della riservatezza e dei diritti della persona, tramite l’applicazione sistematica di apposite misure di tutela e garanzia predisposte sia per il trattamento cartaceo che elettronico inerenti alla specificità del dato stesso. L’interessato ha diritto ad esercitare i diritti previsti dagli art. dal 15 al 22 del Regolamento UE 679/2016, ed essendo i dati trattati solo per i fini previsti il diritto potrà essere esercitato solo alla conclusione del periodo di conservazione previsto per legge, inviando una mail all’indirizzo: [email protected] Titolare del trattamento dei dati, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 679/2016, è ATC 8 Siena Sud – C.F. -

Create Your Own Self Guided Tour
Overview Bicycle Tours in Italy: Create Your Own Self Guided Tour OVERVIEW Create your own Self Guided Tour! We have tons of rides and destinations to suggest you. Like a snake that goes through the diversity of Italy this itineary is just an example of what we can offer you. Pick up the section you like better, join your favourite destinations and we'll help you building the tour of your dreams! HIGHLIGHTS Venetian, Lagoon Florence, Ferrara,, Ravenna, Ceramics of Faenza Chianti, Region Siena, Montalcino,, the Orcia Valley, Pienza and Montepulciano Cortona, Assisi, Bevagna, Spoleto, Todi and Orvieto TOUR FACTS Tour Style : Learn more about our tours at https://www.experienceplus.com/tours/bike-tour-styles/-tours 3-4 star accomodations with all breakfasts, use of high quality titanium racing or hybrid bicycle; Includes bike delivery and collection; use of GPS with preloaded tracks; detailed route descriptions; map; suggestions for dinners and lunches; luggage transfers Countries Italy Begin/End Venezia / Orvieto Arrive/Depart Venice Marco Polo Airport (VCE) / Rome Fiumicino Airport (FCO) Total Distance Up to you ! Avg. Daily Distance Approx 50 km per riding day Tour Level We work hard to maintain consistency across all of our tours, but some trips have unique Keep in Mind differences. Here are some things to keep in mind about this tour. The best rides in Italy of the level of challenge you choose! Please Note: We may have small itinerary changes to this trip after you download this PDF document. If you have booked this trip and there are major changes, including changes to towns or activities, we'll email you directly. -

Via Lauretana in Bici Tra Siena E Cortona
Via Lauretana in bici tra Siena e Cortona A passo lento, per assaporare le infinite bellezze che si susseguono lungo questo meraviglioso percorso, un antico itinerario punteggiato di luoghi senza tempo e paesaggi mozzafiato La Via Lauretana La Via Lauretana insiste su una direttice etrusco-romana, divenuta in seguito un’importante via di pellegrinaggio in direzione della Santa Casa di Loreto. La strada, molto transitata fino ai secoli XV, XVI e XVII, da Siena si staccava dalla Via Francigena per giungere fino a Camucia, ai piedi di Cortona, per poi dirigersi verso l’Umbria e, valicando gli Appennini, arrivare a Loreto, nelle Marche. Nel tratto che congiunge Siena a Cortona, la Lauretana attraversa paesaggi di rara bellezza e luoghi ricchi di storia: percorrerla in bicicletta regala sorprese ed emozioni. 3 Usciti da Siena ci si trova nel mare d’argilla delle Crete senesi, dove si pedala in un orizzonte di colline dai colori mutanti secondo le stagioni, e si incontrano sorprendenti e suggestive installazioni moderne, antiche fortezze e monasteri. Si entra, poi, in Val di Chiana, sfiorando la Val d’Orcia, per trovarsi immersi tra oasi naturali e opere ingegneristiche che hanno cambiato paesaggio ed economia di queste terre, il cui potenziale era già conosciuto da un popolo affascinante e misterioso come gli Etruschi, di cui il percorso incontra spesso le tracce. Pedalare sulla Lauretana, attraversando Siena, Asciano, Rapolano Terme, Sinalunga, Torrita di Siena, Montepulciano e Cortona, sarà un viaggio emozionante, pieno di scoperte, sempre