Palazzo Pallastrelli
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Fa Pr PC 12Lu 2018 Corretto.Pdf
Provincia Piacenza Comuni Pop.resid. 1/1/2018 Sup. in Km2 Abitanti per Km2 Agazzano 2.060 36,15 56,99 Alseno 4.696 55,27 84,96 Besenzone 959 23,95 40,05 Bettola 2.756 122,37 22,52 Bobbio 3.588 106,53 33,68 Borgonovo Val Tidone 7.943 51,22 155,08 Cadeo 6.108 38,48 158,73 Calendasco 2.465 36,94 66,73 Caorso 4.733 40,98 115,49 Carpaneto Piacentino 7.742 63,08 122,74 Castell'Arquato 4.637 52,75 87,91 Castel San Giovanni 13.784 44,04 312,95 Castelvetro Piacentino 5.356 35,06 152,79 Cerignale 123 30,82 3,99 Coli 873 71,69 12,18 Corte Brugnatella 580 46,31 12,52 Cortemaggiore 4.677 36,47 128,23 Farini 1.201 112,36 10,69 Ferriere 1.237 178,5 6,93 Fiorenzuola d'Arda 15.299 59,77 255,96 Gazzola 2.068 44,48 46,5 Gossolengo 5.655 31,1 181,83 Gragnano Trebbiense 4.620 34,61 133,48 Gropparello 2.267 56,33 40,24 Lugagnano Val d'Arda 3.988 54,4 73,31 Monticelli d'Ongina 5.295 46,33 114,28 Morfasso 985 83,93 11,74 Ottone 495 98,96 5 Piacenza 103.262 118,24 873,36 Pianello Val Tidone 2.232 36,29 61,51 Piozzano 623 43,61 14,29 Podenzano 9.163 44,34 206,67 Ponte dell'Olio 4.720 43,92 107,48 Pontenure 6.509 33,85 192,3 Rivergaro 7.105 43,83 162,1 Rottofreno 12.243 35,17 348,13 San Giorgio Piacentino 5.685 49,19 115,56 San Pietro in Cerro 837 27,35 30,61 Sarmato 2.862 27,26 105 Travo 2.131 81,01 26,3 Vernasca 2.083 72,57 28,7 Vigolzone 4.308 42,04 102,48 Villanova sull'Arda 1.751 36,57 47,88 Zerba 77 24,13 3,19 Ziano Piacentino 2.534 32,78 77,31 Alta Val Tidone 3.060 100,87 30,34 Totale 287.375 2.585,86 111,13 Quadro riepilogativo degli ambiti territoriali e delle Unioni di Comuni Distretti sociosanitari Ambiti territoriali Unioni di Comuni Evoluzione delle Unioni di Comuni Popolazione Sup. -

Olimpyawin 3.0 – Gestione Gare Sportive Scolastiche Ragazzi
Atletica UFFICIO EDUCAZIONE FISICA Leggera ATLETICA RAGAZZI/E 21/05/2013 Luogo : PIACENZA Impianto : Stadio Dordoni Olimpyawin Cronometraggio : Manuale Giudice Arbitro : Sig. Giuseppe Ognissanti CATEGORIA RAGAZZE > Classifica Finale 60 mt. Piani Categoria Ragazze - Cl. Nome Atleta Data n. Scuola e Comune di Appartenenza Pv Ris. Punti -- 1 BERZIOLI ISOTTA 2001 S.M. ALSENO ALSENO (PC) 09"3 1 -- 2 MOLINELLI REBECCA 2001 S.M. SARMATO SARMATO (PC) 09"5 2 -- 3 CHERBAL CHAIMAA 2001 DANTE CARD. PIACENZA (PC) 09"5 3 -- 4 STRAZZULLI ILARIA 2001 DANTE CARD. PIACENZA (PC) 09"6 4 -- 5 PASSERA EMMA 2001 IC FIORENZUOLA FIORENZUOLA (PC) 09"7 5 -- 6 VIOLA MARIA GRAZIA 2001 DANTE CARD. PIACENZA (PC) 09"8 6 -- 7 TORDO CATERINA 2001 IC MAZZINI CASTEL SAN GIOVANNI (PC) 09"9 7 -- 7 OBERTELLI GIULIA 2001 IC CAGNONI CASTELL'ARQUATO (PC) 09"9 8 -- 9 MORSIA ANNA 2001 IC FIORENZUOLA FIORENZUOLA (PC) 09"9 9 -- 10 MONTEFIORI CHIARA 2001 IC MAZZINI CASTEL SAN GIOVANNI (PC) 10"3 10 -- 11 ODDI GINEVRA 2001 IC CARELLA PIANELLO (PC) 10"3 11 -- 12 MITO EVIANA 2001 IC CARELLA PIANELLO (PC) 10"6 12 -- 13 GORRA CECILIA 2001 IC CAGNONI CASTELL'ARQUATO (PC) 10"7 13 -- 13 DALLACOSTA CHIARA 2001 IC PASCOLI BORGONOVO (PC) 10"7 14 -- 15 SPOTTI NICOLE 2001 S.M. ALSENO ALSENO (PC) 10"8 15 -- 16 IBRA ANXHELA 1999 S.M. SARMATO SARMATO (PC) 11"4 Ind. -- 17 TASSI GLORIA 2001 IC PASCOLI BORGONOVO (PC) 12"8 16 > Classifica Finale 600 metri Categoria Ragazze - Cl. Nome Atleta Data n. Scuola e Comune di Appartenenza Pv Ris. -

ELENCO TECNICI COMPETENTI in ACUSTICA AMBIENTALE L. 447/95 - PROVINCIA DI PIACENZA Aggiornato Al 31/05/2013
DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA ELENCO TECNICI COMPETENTI IN ACUSTICA AMBIENTALE L. 447/95 - PROVINCIA DI PIACENZA Aggiornato al 31/05/2013 COGNOME NOME RESIDENZA /RECAPITO ESTREMI PROVVEDIMENTO ALBERTAZZI ANDREA Via Marzioli, 67 DD n. 1630 Piacenza Del 11/08/2006 AILI FAUSTO Via Castello Chiapponi, 6/E DD Reg.le n. 3822 Rottofreno (PC) del 17/05/1999 ARMELLONI ENRICO Via Sidoli, 23 DD n. 1947 Piacenza del 28/11/2001 ASTORRI FABIO Via Scalabrini, 119 DD n. 436 Piacenza del 06/03/2012 BACCIOCCHI VINCENZO Via Venturini, 6 DD n. 1786 Piacenza del 30/08/2012 BALDINI ELIO Via Salvoni, 25 DD n. 1892 Loc. Quarto - Piacenza del 16/09/2002 BALLANI SIMONA Loc. Canneto Sopra n. 29 DD n. 2424 Gazzola (PC) del 24/11/2006 BARBIERI CINZIA Via Dante Alighieri, 118 DD n. 1215 Piacenza del 02/08/2001 BARBIERI FILIPPO Via Draghi, 7 DD n. 392 Fiorenzuola d’Arda (PC) del 29/02/2012 BASSI ROBERTO Via Vaiarini, 57 DD n. 2328 Piacenza del 25/11/2008 BENEDUSI LEONARDO Via Modigliani, 2 DD n. 1 Monticelli D’Ongina (PC) del 03/01/2007 BERGAMASCHI RICCARDO Via Baciocchi, 2 DD n. 437 Fiorenzuola d’Arda (PC) del 06/03/2012 BERTE' ELENA Via Degani, 20 DD Reg.le n. 11394 Piacenza del 09/11/1998 BETTONI SONIA Via Parigi, 10 DD n. 1590 Castelvetro Piacentino (PC) del 20/08/2008 BIASINI PAOLO Via Napoli, 49 DD n. 2108 San Giorgio Piacentino (PC) del 19/10/2006 BONETTI GROPPI STEFANO Via IV Novembre, 18 DD n. -

QC-C.01.1/C.01.2, I Punti Di Rinvenimenti Archeolgicidi Cui Al Repertorio Del Gruppo Archeologico Val Nure Ed Approvato Dalla Soprintendenza Stessa
MODIFICATO maggio 2012 PSC Ponte dell’Olio - QUADRO CONOSCITIVO VOL.C IL SISTEMA TERRITORIALE 1 INDICE: C1 SISTEMA TERRITORIALE. Pag. 3 C1.1 SISTEMA INSEDIATIVO TERRITORIALE E DEI TERRITORI URBANIZZATI. Pag. 3 C1.2 IL SISTEMA INSEDIATIVO STORICO URBANO E RURALE.. Pag. 11 C1.2.1 Aree ed elementi d’interesse archeologico. Pag. 11 C1.2.2 Zone urbane storiche. Pag. 12 C1.2.3 Strutture insediative storiche non urbane. Pag. 17 C1.2.4 Ambiti ed elementi d’interesse storico architettonico e testimoniale. Pag. 20 C1.2.5 La Viabilità Storica Pag. 20 C1.3 IL SISTEMA DEI TERRITORI URBANIZZATI. Pag. 21 C1.3.1 Il Capoluogo. Pag. 21 C1.3.2 Principali problematiche e criticità – Capoluogo. Pag. 23 C1.4 SISTEMA DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI: QUALITA’ URBANA. Pag. 27 C1.4.1 Le reti fognarie. Pag. 29 C1.4.2 Le reti idriche. Pag. 35 C1.4.3 I gasdotti. Pag. 45 C1.4.4 Sistema energetico: impianti di produzione e Autoproduzione (Ditte) e fonti rinnovabili. Pag. 45 C1.4.5 Rete per la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica. Pag. 46 C1.4.6 Impianti di telefonia mobile e di emittenza radio televisiva Pag. 47 C1.4.7 Raccolta e gestioni rifiuti. Pag. 47 C1.4.8 Servizi ed attrezzature pubbliche. Pag. 52 C1.5.1 INCIDENZA DEL SISTEMA INSEDIATIVO SULL’AMBIENTE NATURALE. Pag. 57 C1.5.2 GRADO DI SALUBRITA’ DEL SISTEMA URBANO: RUMORE. Pag. 59 C1.5.3 GRADO DI SALUBRITA’ DEL SISTEMA URBANO: ARIA. Pag. 59 C1.5.4 INQUINAMENTO LUMINOSO. Pag. 62 C1.5.5 CAMPI ELETTROMAGNETICI Pag. -
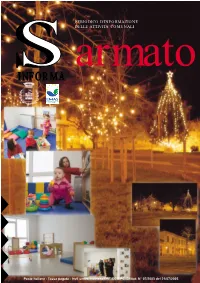
Sarmato Dic.06
PERIODICO D’INFORMAZIONE DELLE ATTIVITA’ COMUNALI SSarmato INFORMA Poste Italiane - Tassa pagata - Invii senza indirizzo/DRT/DCB/PC/ISI/Aut. N° 07/2003 del 21/07/2003 SSarmato INFORMA 2 Il saluto del Sindaco Gentili cittadine e cittadini, in questo periodo l’Amministrazione Comunale sta definendo gli obiettivi prioritari per il prossimo anno con i relativi programmi d’intervento nei differenti settori che riguardano il paese. I temi da svi- luppare sono decisamente numerosi e la maggiore difficoltà è quella di riuscire a rispondere alle prin- cipali esigenze emerse nel corso del 2006 attraverso progetti efficaci ed incisivi. Un punto saldo della nostra programmazione rimane l’attenzione nei confronti del bisogno sociale, per il quale si è appena conclusa una prima fase d’indagine condotta dall’ufficio competente e che ha messo in luce delle fragilità vecchie e nuove da affrontare. Pertanto nel prossimo anno l’Amministrazione intende promuovere politiche di sostegno e di tutela nei confronti delle famiglie, degli anziani, delle persone non autosufficienti e degli stranieri che vivono nel nostro territorio. Numerosi saranno i progetti: ampliamento del servizio micro-nido, avvio sperimentale del telesoccor- so per anziani e adulti in difficoltà e di uno sportello informativo per gli immigrati, potenziamento de- gli spazi di aggregazione e ricreativi per i giovani. Un medesimo impegno sarà riservato all’adozione di strategie per la tutela ed il risanamento dell’am- biente mediante il monitoraggio delle condizioni della qualità dell’aria, l’applicazioni di programmi sovracomunali per la riduzione delle emissioni e l’introduzione di sistemi che favoriscono il risparmio energetico. Uno dei progetti maggiormente qualificanti sarà infatti l’installazione di pannelli fotovol- taici (la cui spesa è finanziata per il 70% dalla Regione) sui tetti della palestra, pannelli che consenti- ranno di rendere completamente autonomo il polo scolastico per l’approvvigionamento di energia. -

Aprile 2018 (Estratto)
CONFERENZA TERRITORIALE SOCIALE e SANITARIA DELLA PROVINCIA di PIACENZA VERBALE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA DELLA CONFERENZA TERRITORIALE SOCIALE E SANITARIA DELLA PROVINCIA DI PIACENZA SEDUTA DELL’ 11 APRILE 2018 (ESTRATTO) Il giorno mercoledì, 11 aprile 2018, alle ore 11.00, presso la Sala Garibaldi della Provincia di Piacenza messa cortesemente a disposizione dal Presidente della Provincia, a seguito di regolare convocazione (tramite Nota del Presidente della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria della Provincia di Piacenza Prot. n° 05 bis/2018 trasmessa via e-mail ai Componenti e agli Invitati in data 27 marzo 2018) si è riunito l'Ufficio di Presidenza della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria della Provincia di Piacenza (d’ora in avanti UdP CTSS PC) per la trattazione dei seguenti argomenti all’Ordine del Giorno: 1. Monitoraggio e confronto sullo stato di attuazione del “PIANO DI RIORDINO DEI SERVIZI ALLA SALUTE - RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA E DELLA SANITÀ TERRITORIALE PIACENTINE” approvato dalla CTSS PC nella seduta del 31 marzo 2017. Aggiornamento sui dati di contesto e di scenario e chiarimenti dell’AUSL PC in risposta alle osservazioni dei Comuni di Bobbio, Castel San Giovanni, Fiorenzuola d'Arda, Piacenza e Villanova sull'Arda sedi di Presidio Ospedaliero 2. Proposta di estensione dell’accordo DGR 1102/2014 (prestazioni integrate bisogni complessi area Minori allontanati o a rischio allontanamento). Approvazione da parte del livello sovra - distrettuale UdP CTSS 3. Varie ed Eventuali Sono presenti: -

Provincia Di Piacenza Appartenenza Comuni Alle Macroaree Climatiche
STRATEGIA PER LA MITIGAZIONE E L’ADATTAMENTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA- SCENARI CLIMATICI LOCALI PROVINCIA DI PIACENZA APPARTENENZA COMUNI ALLE MACROAREE CLIMATICHE LEGENDA: AREA OMOGENEA - Pianura OVEST AREA OMOGENEA - Pianura EST AREA OMOGENEA - Collina OVEST AREA OMOGENEA - Collina EST AREA OMOGENEA - Crinale OVEST AREA OMOGENEA - Crinale EST AREA OMOGENEA - Costa NORD AREA OMOGENEA - Costa SUD AREA URBANA - Piacenza AREA URBANA - Parma AREA URBANA - Reggio Emilia AREA URBANA - Modena AREA URBANA - Ferrara AREA URBANA - Bologna AREA URBANA - Ravenna AREA URBANA - Forlì AREA URBANA - Cesena AREA URBANA - Rimini STRATEGIA PER LA MITIGAZIONE E L’ADATTAMENTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA- SCENARI CLIMATICI LOCALI PROVINCIA DI PIACENZA COMUNE AREA OMOGENEA AREA OMOGENEA SCHEDA CLIMATICA DI SCHEDA CLIMATICA DI PERTINENZA PERTINENZA PIANURA OVEST COLLINA OVEST Agazzano PIANURA OVEST Alseno COLLINA OVEST CRINALE OVEST Alta Val Tidone PIANURA OVEST Besenzone COLLINA OVEST CRINALE OVEST Bettola CRINALE OVEST COLLINA OVEST Bobbio PIANURA OVEST COLLINA OVEST Borgonovo Val Tidone PIANURA OVEST Cadeo PIANURA OVEST Calendasco PIANURA OVEST Caorso PIANURA OVEST COLLINA OVEST Carpaneto Piacentino PIANURA OVEST Castel San Giovanni PIANURA OVEST COLLINA OVEST Castell'Arquato PIANURA OVEST Castelvetro Piacentino STRATEGIA PER LA MITIGAZIONE E L’ADATTAMENTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA- SCENARI CLIMATICI LOCALI CRINALE OVEST Cerignale CRINALE OVEST COLLINA OVEST Coli CRINALE OVEST Corte Brugnatella PIANURA OVEST Cortemaggiore CRINALE OVEST COLLINA OVEST -

Tariffe E Tasse Locali Nei Comuni Della Provincia Di Piacenza
18 giugno 2015 3° Rapporto Tariffe e Tasse locali nei comuni della Provincia di Piacenza 18 Giugno 2015 Sala G. Piana Università Cattolica del Sacro Cuore Sede di Piacenza A cura di Davide Gatti 3° Rapporto sulle Tariffe e le Tasse locali nei comuni della Provincia di Piacenza Pag. 1 18 giugno 2015 SOMMARIO PREFAZIONE ............................................................................................................................................. 3 INTRODUZIONE ........................................................................................................................................ 5 ANALISI DEI DATI ...................................................................................................................................... 6 1 - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ................................................................................................. 6 2 - TASI prima casa ................................................................................................................................. 14 3 – IMU e TASI seconda Casa (Immobili a disposizione) ........................................................................ 21 4 – TARI (servizio smaltimento rifiuti) ................................................................................................... 26 5 – SERVIZIO IDRICO ............................................................................................................................... 28 6 – Trasporto Pubblico Locale ............................................................................................................... -

Provincia Di Piacenza Comune Di ALSENO Comune Di ALSENO
REGIONE EMILIA-ROMAGNA Direzione Generale Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa - Servizio Parchi e Risorse forestali RETE NATURA 2000 - Indagine catastale: SIC e ZPS ricadenti nei singoli Fogli catastali (Det. n. 5188/07) __________________________________________________________________________________________________________ Provincia di Piacenza Comune di ALSENO Comune di ALSENO Codici Siti Foglio intero/parte ricadenti nel foglio Denominazioni Siti __________________________________________________________________________________________________________ 49 parte IT4020003 SIC Torrente Stirone __________________________________________________________________________________________________________ 50 parte IT4020003 SIC Torrente Stirone __________________________________________________________________________________________________________ 51 parte IT4020003 SIC Torrente Stirone __________________________________________________________________________________________________________ 52 parte IT4020003 SIC Torrente Stirone 1 REGIONE EMILIA-ROMAGNA Direzione Generale Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa - Servizio Parchi e Risorse forestali RETE NATURA 2000 - Indagine catastale: SIC e ZPS ricadenti nei singoli Fogli catastali (Det. n. 5188/07) __________________________________________________________________________________________________________ Provincia di Piacenza Comune di BETTOLA Comune di BETTOLA Codici Siti Foglio intero/parte ricadenti nel foglio Denominazioni Siti __________________________________________________________________________________________________________ -

Comune PEC Comune Di Agazzano [email protected]
Comune PEC Comune di Agazzano [email protected] Comune di Alseno [email protected] Comune di Besenzone [email protected] Comune di Bettola [email protected] Comune di Bobbio [email protected] Comune di Borgonovo [email protected] Comune di Cadeo [email protected] Comune di Calendasco [email protected] Comune di Caminata [email protected] Comune di Caorso [email protected] Comune di Carpaneto [email protected] Comune di Castell'Arquato [email protected] Comune di Castel San Giovanni [email protected] Comune di Castelvetro [email protected] Comune di Cerignale [email protected] Comune di Coli [email protected] Comune di Cortebrugnatella [email protected] Comune di Cortemaggiore [email protected] Comune di Farini [email protected] Comune di Ferriere [email protected] Comune di Fiorenzuola d'Arda [email protected] Comune di Gazzola [email protected] Comune di Gossolengo [email protected] Comune di Gragnano [email protected] Comune di Gropparello [email protected] Comune di Lugagnano [email protected] Comune di Monticelli -

Le Case Della Salute
pagina 1 LE CASE DELLA SALUTE pagina La normativa sulle Cure Primarie 2 Unione Europea – DG Sanco 2014 • risposta alla maggioranza dei problemi di salute della comunità • servizi universalmente accessibili, erogati da team di professionisti in partnership con i pazienti e i caregiver • ruolo centrale del coordinamento e della continuità dell’assistenza alle persone Italia – Legge 189/2012 e Patto per la Salute 2014-2016 Le Regioni hanno il compito di definire la organizzazione dei servizi di assistenza primaria promuovendo lo sviluppo di un modello multiprofessionale e interdisciplinare. Emilia Romagna La Casa della Salute (CdS) come traduzione ed espressione degli orientamenti europeo e nazionale. 1 pagina La CdS in RER: DGR 291/2010 3 DGR 291/2010 «[La Casa della Salute – CdS] è la sede di accesso e di erogazione dei servizi sanitari, sociosanitari e socio assistenziali rivolti alla popolazione dell’ambito territoriale di riferimento del NCP […] La CdS è un sistema integrato di servizi che si prende cura delle persone fin dal momento dell’accesso attraverso: l’accoglienza dei cittadini, la collaborazione tra i professionisti, la condivisione dei percorsi assistenziali, l’autonomia e la responsabilità professionale, la valorizzazione delle competenze. [E’ un sistema di] relazioni cliniche e organizzative strutturate che mettono in relazione i NCP (assistenza primaria) con gli altri nodi della rete (assistenza specialistica, ospedaliera, sanità pubblica, salute mentale).» «LaCasadellaSaluteèunpresidio del Distretto, la cui gestione complessiva è affidata al Dipartimento di Cure Primarie che cura le interfacce con gli altri dipartimenti.» pagina La CdS in RER: DGR 291/2010 4 TIPOLOGIE : - CdS Piccola: coincide con la sede del NCP (amb. -

Provincia Di Piacenza Manutenzione Strade1410852987.Pdf
PROVINCIA DI PIACENZA SERVIZIO EDILIZIA, PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE E GRANDI OPERE NUMERO SVILUPPO AMBITO SVILUPPO AMBITO TECNICO DENOMINAZIONE STRADA COMUNI ATTRAVERSATI STRADA KM MANUTENTIVO MANUTENTIVO RESPONSABILE SP4 BARDI 15,820 FIORENZUOLA ALSENO CASTELL'ARQUATO LUGAGNANO VERNASCA SP56 BORLA 16,175VERNASCA CASTELL'ARQUATO SP66 CASALI 2,700 MORFASSO SP72 CASTELLETTO 5,410 VERNASCA SP71 COLLERINO 13,915 LUGAGNANOVERNASCA MORFASSO SP12 GENOVA 7,670 CASTELL'ARQUATO VERNASCA SP15/bis MORFASSO 17,990 MORFASSO SP 359 R SALSOMAGGIORE E BARDI 6,000 MORFASSO VERNASCA SP64 TRABUCCHI 0,590 VERNASCA SP21 VAL D ARDA 18,535 LUGAGNANOVERNASCA MORFASSO BIASINI PAOLO SP4 BARDI (BIS) 9,000 LUGAGNANO VERNASCA 1 200,732 329 2103241 SP46 BESENZONE 10,765 BESENZONE FIORENZUOLA SP54 CHIARAVALLE 12,010 ALSENO BESENZONE SP30 CHIAVENNA 5,181CADEO CORTEMAGGIORE SP12 GENOVA (BIS) 9,300 ALSENOVERNASCA CASTELL'ARQUATO SP53 MURADOLO 5,181 PONTENURE SP31 SALSEDIANA 13,340 CASTELL'ARQUATO ALSENO SP38 SAN PROTASO9,475 CARPANETO FIORENZUOLA SP32 SANT AGATA6,350 S. GIORGIO P.NO PONTENURE SP 462 R VAL D ARDA 7,400 CORTEMAGGIORE FIORENZUOLA SP29 ZENA 7,925 CARPANETO CADEO SP1 TANGENZIALE SUD OVEST DI PIACENZA 6,750 GRAGNANO SP7 AGAZZANO 16,500 ROTTOFRENO GRAGNANO GAZZOLA AGAZZANO SP65 CALDAROLA 7,400 PIOZZANOPECORARA BOBBIO COLI SP13 CALENDASCO 9,745 ROTTOFRENO CALENDASCO SP33 CANTONE 9,740 AGAZZANO PIANELLO BORGONOVO SP48 CENTORA 6,800 ROTTOFRENO GRAGNANO BOGGIA ROBERTO 2 112,997 SP11 MOTTAZIANA 10,080 GRAGNANO BORGONOVO 329 6069907 SP 10 R OVEST PADANA INFERIORE