La Strategia Social Mediale Di Matteo Salvini
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Manzoni, Gli Untori E I Giudici Compiacenti Migranti, Paura
Giovedì 12 marzo 2020 · Anno 2° numero 51 · € 2,00 · www.ilriformista.it · Quotidiano · ISSN 2704-6885 Direttore Piero Sansonetti Appello congiunto di Camere Penali e del Riformista. Basta un decreto IL ECCO COME RISOLVERE IL COVID-19 È PANDEMIA Chiudo... non chiudo... Ci aspettiamo un aumento del numero ...Chiudo... non chiudo... IL PROBLEMA dei casi, delle morti e dei paesi coilpiti CARCERI Non siete soli. In Europa siamo IN DUE GIORNI tutti italiani, vi sosterremo Piero Sansonetti Unione Camere Penali e il Riformista hanno preparato un appello al governo, nel qua- le chiedono un decreto che risolva il problema del sovraffollamento delle carceri. È un decreto semplice e che proponiamo in forma molto dettagliata, che non richiede mag- L’ gioranze qualifi cate, che può essere scritto e approvato in poche ore e può diventare ese- cutivo in 48 ore. Le scarcerazioni non riguarderanno pericolosi assassini seriali o capimafi a, ma “il proletariato” del carcere, cioè i detenuti colpevoli di delitti di non grande entità e che hanno ri- cevuto piccole condanne (inferiori ai due anni) e tuttavia non godono della condizionale, o di de- tenuti che hanno ormai scontato quasi interamente la pena, o di ultrasettantenni. In tutto, circa 20mila persone. Ci aspettiamo dalla politica una risposta molto celere a questa proposta. A pagina 4 La petizione Inquadra il QR CODE o vai all’indirizzo http://bit.ly/DRAMMA_CARCERI e fi rma SEGUE A PAGINA 2 subito l’appello al Governo Manzoni, gli untori Migranti, paura contagio e i giudici compiacenti Ma frega a qualcuno? Walter Siti questo non signifi ca non poter giudicare gli er- Giulio Cavalli vano. -
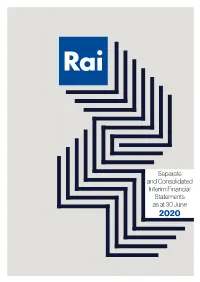
Separate and Consolidated Interim Financial Statements As at 30 June 2020
Separate and Consolidated Interim Financial Statements as at 30 June 2020 Separate and Consolidated Interim Financial Statements as at 30 June 2020 Contents 7 Introduction 17 Report on Operations 171 Interim Separate Financial Statements as at 30 June 2020 239 Interim Consolidated Financial Statements as at 30 June 2020 303 Corporate Directory 4 Contents Introduction 7 Corporate Officers 8 Organisational Structure 9 Introduction from the Chairman of the Board of Directors 11 Financial Highlights 12 Report on Operations 17 Mission 18 Market scenario 18 The Rai Group 24 Television 41 Radio 97 RaiPlay and Digital 107 Public broadcasting service function 116 TV production 119 Technological activities 120 Transmission and distribution activities 129 Sales activities 130 Other activities 135 Changes in the regulatory framework 143 Corporate governance 148 Corporate Governance Report - the Rai Control Governance Model and the Internal Control and Risk Management System (SCIGR) 150 Other information 155 Human Resources and Organisation 155 Safety & Security 159 Intercompany Relations 161 Significant events occurring after 30 June 2020 168 Outlook of operations 168 5 Interim Separate Financial Statements as at 30 June 2020 171 Analysis of the results and performance of operating results, financial position and cash flows for the first half of 2020 172 Financial Statements of Rai SpA 186 Notes to the Interim Separate Financial Statements as at 30 June 2020 191 Certification pursuant to article 154-bis of Italian Legislative Decree 58/98 235 Independent -

LA COSA E ALTRI RACCONTI. Chi Non Conosce Moravia, Pseudo
REALTÀ, MITO E FAVOLA NELLA RECENTE PUBBLICAZIONE DI ALBERTO MORAVIA: LA COSA E ALTRI RACCONTI. Carolina Massi Albanese Universidade Federal do Paraná RIASSUNTO Si analizza l'opera di Alberto Moravia, pubblicata nell'ottobre 1983: La cosa e altri racconti. In tutte il lavoro narrativomoraviano il mondo è bloccato, immo- bile, mentre nell'opera in studio l'ingrata realtà è traslata, ha il respi- ro della favola. Eros, in questi racconti, coprotagonista, diventa un mito e, per- tanto, un'entità parlante. L'erotismo, nelle opere precedenti, "etica- mente insignificante" e "scientificamente noto", si fa qui "poetica- mente valido". L'elemento emozionale, sia emotività dei sensi, che emozione dei sentimenti, occupa sempre lo spazio maggiore ed un certo con- flitto interiore trapela dall'inquietudine dei personaggi i quali, se si nutrono di stanchezza e abulia, non accettano del tutto passivamente il fastidio di esistere. Chi non conosce Moravia, pseudonimo di Alberto Pincherle, essen- zialmente un autodidatta, a causa della salute, che a soli ventidue anni pubblica, a sue spese, il romanzo Gli Indifferenti (1929) e fa enorme impressione sul pubblico e sulla critica? Moravia narratore, saggista, commediografo, per non dire dei film che sono stati ricavati dai suoi testi (Mario Soldati ha diretto La Provin- ciale: Luigi Zampa, La Romana; Vittorio de Sica, La Ciociara; France- sco Maselli, Gli Indifferenti; Jean-Luc Godard, Il disprezzo; Damiano Damiani, La Noia; Bernardo Bertolucci, Il Conformista, ed altri film 3 Letras. Curitiba (33) 3-14 - 1984 - UFPR tratti dai suoi racconti più brevi). Resta apertissimo il discorso sulla qualità delle produzioni mora- viane con l'incrociarsi di interpretazioni, di ipotesi e di indagini da parte della critica italiana e straniera. -

Appunti Leopardiani (18) 2, 2019
Appunti leopardiani (18) 2, 2019 http://www.appuntileopardiani.cce.ufsc.br ISSN: 2179-6106 DIREZIONE Andréia Guerini - Universidade Federal de Santa Catarina/CNPq/Brasile CONDIRETTORI Fabiana Cacciapuoti - Biblioteca Nazionale di Napoli/Italia Gisele Batista da Silva - Universidade Federal de Rio de Janeiro/Brasile Andrea Ragusa - Universidade Nova de Lisboa/Portogallo COMITATO SCIENTIFICO Guido Baldassarri - Università degli Studi di Padova Novella Bellucci - Università di Roma La Sapienza Roberto Bertoni - Trinity College Dublin Alfredo Bosi - Universidade de São Paulo Anna Dolfi - Università degli Studi di Firenze José Expedito Passos Lima - Universidade Estadual do Ceará Marco Lucchesi - Universidade Federal do Rio de Janeiro Loreta Marcon Rita Marnoto – Universidade de Coimbra Laura Melosi - Università degli Studi di Macerata Wander Melo Miranda - Universidade Federal de Minas Gerais Franco Musarra - Katholieke Universiteit Leuven Sebastian Neumeister - Freie Universität Berlin Luciano Parisi - University of Exeter Fabio Pierangeli - Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” Gaspare Polizzi – Università di Pisa Mariagrazia Russo - Università degli Studi Internazionale di Roma Lucia Strappini - Università per Stranieri di Siena Emanuela Tandello - University of Oxford Maria Maria Antonietta Terzoli - Universität Basel Jean-Charles Vegliante - Université Sorbonne Nouvelle, Paris 3 Pamela Williams - University of Hull CONSIGLIO EDITORIALE Alessandra Aloisi - Università degli Studi di Pisa Sandra Bagno - Università degli Studi di Padova -

2^ Edizionemag Gio 2021
2^ edizioneMag Seconda Edizione,gio 2021 maggio 2021 Ciao a tutti ragazzi e ragazze, siamo verso fine anno ormai e noi ci tenevamo a far uscire una seconda edizione del nostro “Marco Polo School Magazine”. Speriamo di avervi tenuto compagnia con l’edizione uscita ad aprile e che il nostro spicchio di informazioni possa esservi utile. Un saluto,la redazione del CCR 2021. A proposito di CCR…..I progetti di quest’anno! Anche quest’anno in quanto CCR ci stiamo dedicando all’ideazione di qualche progetto, che speriamo possa interessarvi! Gli altri progetti a cui stiamo lavorando, oltre a questo giornalino, sono due concorsi: uno di poesia, che coinvolge anche alcune classi delle primarie, e l’altro di fotografia, in collaborazione col gruppo ambiente che è aperto a tutti i ragazzi del comune di San Giorgio delle Pertiche. Tutti e due a tema naturalistico, adottando come soggetti ambiente e/o animali, il regolamento per entrambi i concorsi sarà a disposizione dei concorrenti e verranno premiati i primi tre classificati. La nostra speranza è che, tramite scatti e parole, chi decide di partecipare ai concorsi si accorga quanto è prezioso l’ambiente che ci circonda e quanto è importante prendersene cura. Il mondo è un bel posto e per esso vale la pena di lottare! -Albert Einstein Intervista ad un volontario della biblioteca “History Dictionary Library ” di Brindisi Salve a tutti lettori! Questa è un'intervista fatta dai ragazzi del CCR ad un volontario della Biblioteca digitale di Brindisi che è stato un ex allievo della nostra scuola media Marco Polo e persino un membro del Consiglio Comunale dei Ragazzi! - Come ti chiami? Parlaci un po’ di te! robot, che sono molto utili e fantastici, che danno una ventata di innovazione nella biblioteca e fanno Ciao a tutti! Mi chiamo Andrea Monopoli, sono da guida agli stranieri. -
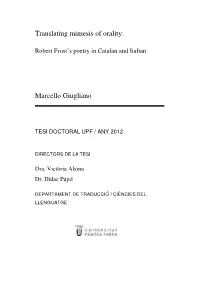
Translating Mimesis of Orality
Translating mimesis of orality: Robert Frost’s poetry in Catalan and Italian Marcello Giugliano TESI DOCTORAL UPF / ANY 2012 DIRECTORS DE LA TESI Dra. Victòria Alsina Dr. Dídac Pujol DEPARTAMENT DE TRADUCCIÓ I CIÈNCIES DEL LLENGUATGE Ai miei genitori Acknowledgements My first thank you goes to my supervisors, Dr. Victòria Alsina and Dr. Dídac Pujol. Their critical guidance, their insightful comments, their constant support and human understanding have provided me with the tools necessary to take on the numerous challenges of my research with enthusiasm. I would also like to thank Dr. Jenny Brumme for helping me to solve my many doubts on some theoretical issues during our long conversations, in which a smile and a humorous comment never failed. My special thanks are also for Dr. Luis Pegenaute, Dr. José Francisco Ruiz Casanova, and Dr. Patrick Zabalbeascoa for never hiding when they met me in the corridors of the faculty or never diverting their eyes in despair. Thank you for always being ready to give me recommendations and for patiently listening to my only subject of conversation during the last four years. During the project, I have had the privilege to make two research stays abroad. The first, in 2009, in Leuven, Belgium, at the Center for Translation Studies (CETRA), and the second in 2010 at the Translation Center of the University of Massachusetts at Amherst, USA. I would like to give a heartfelt thank you to my tutors there, Dr. Reine Meylaerts and Dr. Maria Tymoczko respectively, for their tutoring and for offering me the chance to attend classes and seminars during my stay there, converting that period into a fruitful and exciting experience. -

Tribuna 2020 L'unità Nazionale Alla Prova Della Pandemia
Tribuna 2020 L’unità nazionale alla prova della pandemia INDICE INTRODUZIONE ...................................................................................................................... 3 MASSIMO LUCIANI .................................................................................................................. 5 CESARE PINELLI ..................................................................................................................... 7 PAOLO RIDOLA ........................................................................................................................ 9 ORIANO GIOVANELLI .......................................................................................................... 15 ANNA FINOCCHIARO ........................................................................................................... 19 PAOLO COSTA ........................................................................................................................ 23 GIANCARLO MONTEDORO ................................................................................................... 27 PAOLO CIRINO POMICINO..................................................................................................... 29 BENEDETTA LIBERALI ......................................................................................................... 31 EUGENIO GAUDIO ................................................................................................................ 39 ALBERTO LUCARELLI E LUCA LONGHI ........................................................................... -

Feat (Fuori Dagli Spazi): Fuori Il Nuovo Album Di Francesca Michielin
VENERDì 5 MARZO 2021 Feat (Fuori dagli spazi) è il titolo del nuovo progetto di Francesca Michielin. Un disco che è cresciuto e si è arricchito per raccontare la bellezza Feat (Fuori dagli spazi): fuori il dell'incontro, attraverso l'unione di artisti e amici di generi diversi in un nuovo album di Francesca progetto collettivo, anticipato dalle collaborazioni con Vasco Michielin Brondi e Fedez, quest'ultimo al fianco di Francesca anche sul palco di Sanremo. Acquista il CD: https://amzn.to/3c4djdR Acquista il vinile: https://amzn.to/38fmiIa ANTONIO GALLUZZO "Da piccola non ho mai colorato dentro agli spazi. Usavo pennarelli di qualsiasi sfumatura, anche quelli che stavano finendo, perché davano un'idea "vissuta" all'insieme. A undici anni ho iniziato a disegnare manga, e un po' anche a sentirmi un manga, precisamente una ninja, era per me un modo per affrontare la realtà che spesso mi sembrava difficilissima. La forza me l'hanno data sempre la fantasia e gli incontri, incontri di [email protected] persone diversissime da me. Mi hanno ispirata a cercare dentro di me SPETTACOLINEWS.IT punti di contatto ma anche di scontro. Perché la diversità è sorpresa, è ricchezza, è confronto. E la diversità accende, appunto, la fantasia. Volevo celebrare la collettività, che è eterogenea per definizione, una collettività "fuori dagli spazi", perché ora che la musica sta riprendendo lentamente i suoi spazi sonori, questo titolo di unioni, di feat, vuole essere un augurio a uscire dalla comfort zone, dai muri di casa, a ritrovarci e abbracciarci presto" - commenta la cantautrice. Anche la cover del disco, realizzata da Corrado "Mecna" Grilli, contribuisce all'operazione di sconfinamento degli spazi, volta ad unire tutti gli artisti coinvolti nel progetto FEAT sotto un unico stile grafico. -

La Lettura Contemporanea Del Cosiddetto Dibattito Fra Hobbes E Hume
La lettura contemporanea del cosiddetto dibattito fra Hobbes e Hume Stefania Ravazzi Department of Public Policy and Public Choice “Polis” University of Eastern Piedmont “Amedeo Avogadro” Alessandria - Italy Phone: +39.0131.283.735 FAX: +39.0131.263.030 http://polis.unipmn.it Abstract: Il presente lavoro fornisce una panoramica e una lettura interpretativa delle principali correnti del pensiero economico che studiano il comportamento umano, e che prendono le mosse dal virtuale dibattito fra Hobbes e Hume circa l’uomo allo stato di natura. Nel dibattito contemporaneo si confrontano due visioni contrapposte : l’uomo come animale volto all’esclusiva soddisfazione del vantaggio personale e naturalmente teso alla sopraffazione e allo sfruttamento dei propri simili, e l’uomo come essere per natura cooperativo, che spontaneamente si accorda con gli altri per il raggiungimento degli obiettivi personali e collettivi, senza bisogno dell’intervento di alcuna autorità superiore. Al presente dibattito vengono poi affiancate le ultime ricerche compiute nel campo della sociobiologia, scienza neonata che studia le correlazioni fra mondo biologico e mondo culturale e comportamentale. Jel classicafication: D00 Tesi di laurea in Scienze Politiche (indirizzo politico-economico). Relatore: Prof. Guido Ortona Correlatori: Dott.ssa Gianna Lotito, Prof. Silvano Belligni Discussa il 23 marzo 2001 con votazione di 110 lode e dignità di stampa. Indice Introduzione pag. 3 Capitolo 1 - Hobbes e lo stato di natura " 5 1.1. Il contesto storico " 5 1.2. Hobbes " 7 Capitolo 2 - La lettura contemporanea del pensiero di Hobbes " 19 2.1. Buchanan " 19 2.2. Lo stato di natura hobbesiano nel dibattito contemporaneo " 26 2.3. -

Redalyc.La Visione Moderna Del Diritto E Dello Stato Da Hobbes E
Telos ISSN: 1317-0570 [email protected] Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín Venezuela Zavatta, Laura La visione moderna del diritto e dello Stato da Hobbes e Nietzsche alla sfida della mondialisation Telos, vol. 18, núm. 2, mayo-agosto, 2016, pp. 318-341 Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín Maracaibo, Venezuela Disponibile in: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=99345727010 Come citare l'articolo Numero completo Sistema d'Informazione Scientifica Altro articolo Rete di Riviste Scientifiche dell'America Latina, i Caraibi, la Spagna e il Portogallo Home di rivista in redalyc.org Progetto accademico senza scopo di lucro, sviluppato sotto l'open acces initiative TELOS. Revista de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Sociales Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín ISSN 1317-0570 ~ Depósito legal pp: 199702ZU31 Vol. 18 (2): 318 – 341. 2016 La visione moderna del diritto e dello Stato da Hobbes e Nietzsche alla sfida della mondialisation La visión moderna del derecho y del Estado de Hobbes y Nietzsche ante el desafío de la globalización The modern view of Hobbes and Nietzsche’s law and State before the challenge of globalization Laura Zavatta1 Resumen La teoría moderna del Estado se basa en la supervivencia como el objetivo principal del bien personal. Hobbes y Hume creen que la necesidad fundamental de “querer vivir” es la base de los conceptos sociales esenciales como el peligro y la salvación, el daño y el beneficio, la enfermedad y el cuidado. Hume confirma la tesis de que la naturaleza humana no podía escapar del peligro y la muerte sin la sociedad, que puede implementarse solo si todos respetan el imperio de la ley. -

Diction, Dialect, and Speech in Nineteenth-Century Lyric A
THE UNIVERSITY OF CHICAGO WHAT IS THE LANGUAGE OF POETRY? DICTION, DIALECT, AND SPEECH IN NINETEENTH-CENTURY LYRIC A DISSERTATION SUBMITTED TO THE FACULTY OF THE DIVISION OF HUMANITIES IN CANDIDACY FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY DEPARTMENT OF COMPARATIVE LITERATURE BY JOEL CALAHAN CHICAGO, ILLINOIS AUGUST 2016 Copyright © 2016 by Joel Calahan All rights reserved. To the memory of my father, Scott Calahan, whose folksy Nebraska idioms still resound in my ears and who always used to read the copyright date of books to me as a child Contents Abstract ............................................................................................................................................. vi Acknowledgments ........................................................................................................................... viii Introduction: How We Hear Speech When We Read Poetry ................................................... 1 Dialectology: The Forgotten Study of Speech ..................................................................... 8 Critical Approaches to Speech in Lyric ................................................................................ 13 Method and Chapter Descriptions ....................................................................................... 20 Chapter 1: Vulgar Philology: Speech, History, and Lyric ........................................................... 30 Locke’s Legacy: Condillac, Cesarotti, and the Questione della lingua ............................. 39 Glottologia: The New -

Ibn Tufayl E L'eredità Del Filosofo Autodidatta 167
IBN TUFAYL E L’EREDITÀ DEL FILOSOFO AUTODIDATTA Ibn Tufail and the autodidact philosopher’s heredity Sara Lenzi Università di Pisa RESUMEN Se expone aquí brevemente el contenido de la obra de Ibn Tufayl, El flósofo autodidacto, para pre- sentar a continuación una recapitulación de cómo contribuyó a inspirar a otros pensadores en la redacción de sus escritos, en especial en el caso de El Criticón de Baltasar Gracián y para señalar también la infuen- cia que dejó la imagen del autodidacta en el pensamiento flosófco posterior. Palabras clave: Ibn Tufayl, El filósofo autodidacto, Baltasar Gracián, El Criticón. ABSTRACT The essence of the work of the autodidact philosopher Ibn Tufail is briefy presented here, both to emphasize how it infuenced other thinkers in the way they edited their manuscripts —particularly how Baltasar Gracian edited his El Criticon— and to highlight his infuence on later philosophical thought. Key words: Ibn Tufayl, Hayy ibn Yaqdhan, also known as Philosophus Autodidactus, Baltazar Gracian, Criticon. La storia a volte si dimentica di grandi pensatori, di menti che hanno contribuito allo sviluppo del pensiero filosofico dell’uomo. Colpisce il fatto che in luoghi, quali per esempio l’Italia, dove arrivarono tali pensieri, si sia quasi totalmente perduto il loro ricordo. Parliamo del filosofo andaluso Ibn Tufayl,1 conosciuto anche come Abubacer o, semplicemente, ricor- dato per esser stato il maestro di Averroè, e della sua opera sul filosofo autodidatta. XII secolo, Spagna araba. Ibn Tufayl e la sua Epistola di Hayy b.