Autorappresentazione Di Un'identità in Cambiamento. Il Popolo
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Download Download
Nisan / The Levantine Review Volume 4 Number 2 (Winter 2015) Identity and Peoples in History Speculating on Ancient Mediterranean Mysteries Mordechai Nisan* We are familiar with a philo-Semitic disposition characterizing a number of communities, including Phoenicians/Lebanese, Kabyles/Berbers, and Ismailis/Druze, raising the question of a historical foundation binding them all together. The ethnic threads began in the Galilee and Mount Lebanon and later conceivably wound themselves back there in the persona of Al-Muwahiddun [Unitarian] Druze. While DNA testing is a fascinating methodology to verify the similarity or identity of a shared gene pool among ostensibly disparate peoples, we will primarily pursue our inquiry using conventional historical materials, without however—at the end—avoiding the clues offered by modern science. Our thesis seeks to substantiate an intuition, a reading of the contours of tales emanating from the eastern Mediterranean basin, the Levantine area, to Africa and Egypt, and returning to Israel and Lebanon. The story unfolds with ancient biblical tribes of Israel in the north of their country mixing with, or becoming Lebanese Phoenicians, travelling to North Africa—Tunisia, Algeria, and Libya in particular— assimilating among Kabyle Berbers, later fusing with Shi’a Ismailis in the Maghreb, who would then migrate to Egypt, and during the Fatimid period evolve as the Druze. The latter would later flee Egypt and return to Lebanon—the place where their (biological) ancestors had once dwelt. The original core group was composed of Hebrews/Jews, toward whom various communities evince affinity and identity today with the Jewish people and the state of Israel. -

La Patronymie Dans Les Dairas De Timezrit, Sidi-Aich Et Chemini
République Algérienne Démocratique et Populaire Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique UNIVERSITE MOULOUD MAMMERI, TIZI OUZOU FACULTE DES LETTRES ET DES LANGUES DEPARTEMENT DE LANGUE ET CULTURE AMAZIGHES THESE DE DOCTORAT Spécialité : Langue et Culture Amazighes Option : Linguistique THEME LA PATRONYMIE DANS LES DAIRAS DE TIMEZRIT, SIDI-AICH ET CHEMINI Etude morphologique et sémantique Présentée par Mustapha TIDJET Devant le jury Haddadou Mohand Akli (Professeur, U. de Tizi-Ouzou) ..................................Président Cheriguen Foudil (Professeur, U. de Bejaïa) ..............................................................Rapporteur Nait Zerrad Kamal (Professeur, INALCO) ..................................................................... Co-Rapporteur Ahmed-Zaid Chertouk Malika (Professeur, U. de Tizi-Ouzou) .....................Examinatrice Benramdane Farid (MC « A », U. de Mostaganem) .............................................Examinateur Imarazen Moussa (MC « A », U. de Tizi-Ouzou) .....................................................Examinateur Tizi-Ouzou, janvier 2013 Résumé : Malgré son intérêt évident, l’onomastique est le parent pauvre des études berbères. Dans cette thèse on trouvera une ébauche à l’étude des patronymes algériens à travers une analyse d’un corpus, d’environs 3300 unités, constitué dans trois daïras de la vallée de la Soummam. On y trouvera notamment les catégories sémantiques et les catégories syntaxiques qui sont pourvoyeuses des patronymes. D’un autre côté, l’étude formelle nous a permis de recenser, en plus des différentes formes possibles (simples, dérivées et complexes), les plus importants schèmes constitutifs des patronymes. Agzul : Ɣas akken tezmer ad d-awi lfayda meqqren, tasnisemt d taneggarut des uḥric ussnan n tmaziɣt. Tazrawt-a d anekcum ɣer uzraw n tnekwiwin n Lezzayer. Ayen ara neg s uslaḍ n yiwen n uɣbalu, yuddsen s wazal n 3300 n tayunin, i d-negmer seg krad n yiwinasen n temnaṭ n Ssumam. -

Look Back Through the Millennia and You'll Find Women in Power Even in Humanity's Earliest Days. Here's a Look at Seven Po
LHOSSINE/CREATIVE COMMONS NATIONAL PALACE MUSEUM / PUBLIC DOMAIN CREATIVE COMMONS GUSTAVO JERONIMO/CREATIVE COMMONS GEVORK NAZARYAN/CREATIVE COMMONS INDIA POST Look back through the millennia and you’ll find women Women in power even in humanity’s earliest days. Here’s a look at seven powerful queens and in their accomplishments. PUBLIC DOMAIN History WOMEN IN HISTORY | AFRICAN LEGEND Dihya, Berber Warrior Queen Dihya was born into the Jarawa Zenata tribe in the 7th century and eventually ruled a free Berber state in north Africa that stretched from the Aures Mountains to the oasis of Gadames. She is usually described as very tall with a lot of hair, which may mean she wore her hair long and in dread- locks. The Ancient History Encyclopedia says she was a black, African queen who dressed as royals of ancient Numidia in a loose tunic or robe, sometimes belted, with sandals. FIGHTING THE ARABS Dihya was also referred to in Arabic sources as al Kahina, meaning the soothsayer, because of her alleged ability to foresee the future. She fought off the armies of the Umayyad Dynasty, led by Hasan bin al-Nu’man, who marched from Egypt and met her near Meskiana in 698 (modern day Algeria). It’s said she beat him so badly that he fled to Libya for five years. However, Hasan eventually returned and, helped by a captured officer, defeated Dihya near Tabarka in modern Tunisia near the Algerian border. History dis- agrees on whether she died a warrior’s death in battle or took poison to prevent capture, but it likely occurred in the late 690s or early 700s. -
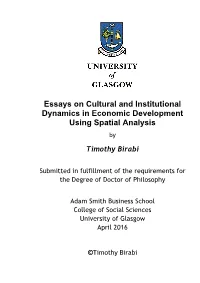
Essays on Cultural and Institutional Dynamics in Economic Development Using Spatial Analysis
Essays on Cultural and Institutional Dynamics in Economic Development Using Spatial Analysis by Timothy Birabi Submitted in fulfillment of the requirements for the Degree of Doctor of Philosophy Adam Smith Business School College of Social Sciences University of Glasgow April 2016 ©Timothy Birabi i Abstract This thesis seeks to research patterns of economic growth and development from a number of perspectives often resonated in the growth literature. By addressing themes about history, geography, institutions and culture the thesis is able to bring to bear a wide range of inter-related literatures and methodologies within a single content. Additionally, by targeting different administrative levels in its research design and approach, this thesis is also able to provide a comprehensive treatment of the economic growth dilemma from both cross- national and sub-national perspectives. The three chapters herein discuss economic development from two broad dimensions. The first of these chapters takes on the economic growth inquiry by attempting to incorporate cultural geography within a cross-country formal spatial econometric growth framework. By introducing the global cultural dynamics of languages and ethnic groups as spatial network mechanisms, this chapter is able to distinguish economic growth effects accruing from own-country productive efforts from those accruing from interconnections within a global productive network chain. From this, discussions and deductions about the implications for both developed and developing countries are made as regards potentials for gains and losses from such types and levels of productive integration. The second and third chapters take a different spin to the economic development inquiry. They both focus on economic activity in Africa, tackling the relevant issues from a geo-intersected dimension involving historic regional tribal homelands and modern national and subnational administrative territories. -

Rites Et Construction De L'identité Berbère. Les Rites Funéraires Dans
École des Hautes Études en Sciences Sociales École doctorale de l’EHESS Anthropologie Sociale et Ethnologie Thèse en co-tutelle - UNIOR Ferraro Rosa Rites et construction de l'identité berbère. Rituels funéraires et évolution des formes traditionnelles du rite au Maroc Thèse dirigée par: Yacine Tassadit et Di Tolla Anna Maria Date de soutenance : le 16-01-2017 Jury 1 Anna Maria Di Tolla – UNIOR 2 Tassadit Yacine – EHESS 3 Gianfranca Ranisio – UNINA 4 Enric Porquères – EHESS SYNTHÈSE DE LA THÈSE EN FRANÇAIS Remerciements D'abord, je veux remercier mes précieux, ponctuels et attentifs Tutor de ces années d'étude, le professeur Yacine Tassadit et le professeur Anna Maria Di Tolla. Elles m'ont conduit à travers les étapes délicates de la recherche, mais surtout m'ont transmis l'amour et le dévouement pour le monde et la culture berbère. Un grand merci aux trois Professeurs Saa Fouad, Abdelmounïm El Azouzi et Bassau Hamri, leurs suggestions et leur contribution ont été très précieux pour la réalisation du projet. Je voudrais aussi remercier mes médiateurs, interprètes et surtout mes amies Samira et Talia qui m'ont suivi, m'ont aidé et m'ont soutenu pendant toute la phase de recherche sur le terrain au Maroc. — 3 — Résumé et mots clés Résumé Ce travail est le résultat d'une recherche croisée entre l'Italie et le Maroc, limité à un restreinte environnement géographique, à savoir, la ville de Maddaloni dans la région Campanie, et les deux provinces du Maroc, Beni Mellal et Khouribga, lieux d'où vient la plupart des migrants marocains qui vit dans le sud de l'Italie. -

Uhm Phd 4580 R.Pdf
4550 UNIVERSiTY OF Hj~W/\n LIBRARY DIALECT LEVELING, MAINTENANCE AND URBAN IDENTITY IN MOROCCO FESSI IMMIGRANTS IN CASABLANCA A DISSERTATION SUBMITTED TO THE GRADUATE DIVISION OF THE UNIVERSITY OF HAWAI'I IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY IN LINGUISTICS MAY 2005 By Atiqa Hachimi Dissertation Committee: Michael L. Fonnan, Co-Chairperson Miriam Meyerhoff, Co-Chairperson Patricia J. Donegan Ibrahim G. Aoude Robert J. Littman ACKNOWLEDGMENTS I would like to extend my deepest and sincere thanks to both my supervisors: Professors Michael L. Forman and Miriam Meyerhoff. Professor Michael L. Forman has been there from the very beginning and has supported me in all my endeavors. His guidance and intellectual stimulation have been instrumental in developing my understanding of sociolinguistics. I am grateful to him for introducing me to linguistic anthropology and to advising me to explore the richness of language. His kindness and sense of humor have kept me going for all these years. I am particularly indebted to my advisor and chair, Professor Miriam Meyerhoff, who has constantly been pushing me to go beyond my limits. She has always had faith in me when I believed I had already given my best. I am grateful to her for introducing me to variationist linguistics and for her brilliant insights. She gave me invaluable advice, guidance and critiqued my work, and materially improved my understanding of my own work. I am deeply humbled by her generosity and big heart. She invited me to Edinburgh to help me with my work and she was a gracious host. -

TILIMSAN=TLEMCEN=TREMISSEN EMIRATO 736-1236 Dinastia
TILIMSAN (Algeria) TILIMSAN=TLEMCEN=TREMISSEN EMIRATO 736-1236 Dinastia Zenata Gufrita=Ifrenidi=Ifrinidi=Ifranidi= Ifranid=Ifrenid=Ifrinid=Banu Ifren=Banu Ifran=Banu Ifrin=Ifran=Ifren=Ifrin=Afran=Iforen=Fren=Wafren= Yefren=Yafren=Yafran=Beni Ifren=Beni Ifran=Beni Ifrin 736-790 ABU QURRAH=QURRA=CORRA … … 873-947 ABU YAZID … … ABD ALLAH IBN BEKKAR 950-958 YALA IBN MOHAMMAD (a Mascara) 958-993 YEDDOU (a Fez) 993-1029 HABBOUS (a Fez) 1029-1035 TEMIM IBN ZIRI (a Salé) 1036-1054 ABOU’L-KEMAL (a Salé) 1055-1056 YUCUF 1056-1066 HAMMAD 1066 MOHAMMED … … REGNO 1236-1550 Dinastia Abdalvaditi=Abdalwadit 1236-1283 ABU YAHYA I BON ZAYYAN 1283-1303 ABU SAID UTHMAN I (figlio di Yahya I) 1303-1308 ABU ZAYYAN I (figlio di Uthman I) 1308-1318 ABU HAMMU I (fratello di Zayyan I) 1318-1337 ABU TASHUFIN I (figlio di Hammu I) A MAROCCO 1337-1348 1348-1352 ABU SAID UTHMAN II (figlio di Tashufin I) 1348-1352 ABU THABID I (fratello di Uthman II) A MAROCCO 1352-1359 1359-1389 ABU HAMMU II (fratello di Uthman II) 1389-1393 ABU TASHUFIN II (figlio di Hammu II) Pagina 1 di 2 TILIMSAN (Algeria) 1393 ABU THABID II (figlio di Tashufin II) 1393-1394 ABU HADJDJADJ I (fratello di Thabid II) 1394-1399 ABU ZAYYAN II (fratello di Thabid II) 1399-1401 ABU MUH I (fratello di Thabid II) 1401-1411 ABU ABDALLAH I (fratello di Thabid II) 1411 ABD ER-RAHMAN I BIN ABU MUH (figlio di Muh I) 1411 SAID I BIN ABU TASHUFIN (fratello di Muh I) 1411-1423 ABU MALEK I (fratello di Said I) 1423-1427 ABU ABDALLAH II (1°)(figlio di Abd er-Rahman I) 1427-1429 … 1429-1430 ABU ABDALLAH II (2°) 1430-1461 -

300+ Retailers
V 2021 .2 LEASING BROCHURE A Destination Like No Other 300+ Retailers Entertainment Zone, F&B Hall, Cinemas, Fashion, IKEA and more.. INTRODUCINGINTRODUCING ZENATAZENTA MALL MALL 3 2 ZENATA MALL I LEASING BROCHURE INTRODUCING INTRODUCING ZENATA MALL ZENATA ZENTA MALL ZENTA Welcome to Zenata Mall in vibrant Casablanca! It is with great pride that we bring to retailers and value-minded consumers of the region, a diverse, locally relevant and dynamic version of a retailtainment shopping centre. Zenata Mall will be the largest in North Africa, offering a wide range of products and brands (both national and international) and a differentiated Food Hall. Classic design and contemporary interiors, an evolutive size with key and exciting winning approach of Zenata Mall. Over the past year, the teams at Al Futtaim, Marjane Holding, Sonae Sierra and Société d’Aménagement Zenata (SAZ) have collaborated to develop an innovative retail, marketing and branding strategy to position Zenata Mall as Morocco’s largest and most attractive shopping, fooding, family and leisure destination. and dining destination for the rapidly growing Zenata area and neighbouring districts. Combining all these factors, Zenata Mall presents a highly attractive proposition for retailers and consumers in the economic and business centre of Morocco and beyond. 4 5 INTRODUCINGINTRODUCING ZENATAZENTA MALL MALL 7 6 ZENATA MALL I LEASING BROCHURE INTRODUCING INTRODUCING ZENATA MALL ZENATA Introducing Shopping MALL ZENTA Zenata Mall Precincts A CLASSIC MALL WITH AN EVOLUTIVE SIZE -

Les Langues Dans Le Monde…1
i Les langues dans le monde…1 Plus de 6000 langues sont actuellement parlées dans le monde, des dialectes régionaux chinois jusqu’aux grandes familles comme l’indo-européen ou le sino-tibétain. Les grandes familles sont : Familles des langues eurasiennes Famille des langues américaines INDO-EUROPEN ESKIMO-ALÉOUTE OURALIQUE NA-DÉNÉ ALTAÏQUE AUTRES LANGUES AMERINDIENNES TCHOUKTCHE-KAMTCHADALE CAUCASIEN (3 familles) Famille des langues africaines Famille des langues du sud-est asiatique AFRO-ASIATIQUE DRAVIDIEN NILO-SAHARIEN SINO-TIBÉTAIN NIGER-CONGO AUSTRIQUE (AUSTRONÉSIEN, AUSTRO-ASIATIQUE, KHOISAN THAI, MIAO-YAO) LANGUES PAPOUES LANGUES ABORIGÈNES D’AUSTRALIE 1 Extraits de : B. COMRIE, S. MATTHEWS, M. POLINSKY (Dir.), Atlas des langues. L’origine et le développement des langues dans le monde. Paris, Editions Acropole, 2004 Les langues indo-européennes, actuellement parlées par la moitié de la population du globe, dominent à la fois les pays occidentaux et leur vision du langage. En termes de nombre de locuteurs natifs, douze des vingt premières langues appartiennent à la famille indo-européenne, beaucoup ayant été propagées par l’expansion coloniale, comme l’anglais, l’espagnol et le portugais. Le chinois est cependant la langue la plus largement utilisée dans le monde, avec environ un milliard de locuteurs natifs. La diversité linguistique en Chine reste cependant l’une des plus importantes au monde. On estime que la moitié de la population mondiale est bilingue ou multilingue. La langue ne correspond pas forcément à l’ethnie ou à la religion. Par exemple, les Juifs disséminés dans différentes parties du monde parlent hébreu, russe, yiddish, anglais, ou encore ladin. -

1 Repertoires of Identities
Repertoires of Identities: Language, Intersectionality and Memory in Tunisia (1881-Present) Item Type text; Electronic Dissertation Authors Rahmouni, Kamilia Publisher The University of Arizona. Rights Copyright © is held by the author. Digital access to this material is made possible by the University Libraries, University of Arizona. Further transmission, reproduction, presentation (such as public display or performance) of protected items is prohibited except with permission of the author. Download date 28/09/2021 12:37:54 Link to Item http://hdl.handle.net/10150/633222 REPERTOIRES OF IDENTITIES: LANGUAGE, INTERSECTIONALITY AND MEMORY IN TUNISIA (1881-PRESENT) by Kamilia Rahmouni __________________________ Copyright © Kamilia Rahmouni 2019 A Dissertation Submitted to the Faculty of the SCHOOL OF MIDDLE EASTERN AND NORTH AFRICAN STUDIES In Partial Fulfillment of the Requirements For the Degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY In the Graduate College THE UNIVERSITY OF ARIZONA 2019 1 2 Dedication To my most beloved and supportive mother and father… 3 Acknowledgements I would like to express my sincere gratitude to my advisors Dr. Samira Farwaneh and Dr. Julia Clancy-Smith for their time and patience in guiding me through every major step of the dissertation process, and for their mentorship, guidance and tireless support throughout my journey as a graduate student. I am very grateful for the contributions that each of them made to my intellectual growth during my years of study at the University of Arizona. Special thanks are also due to Dr. Anne Betteridge and Dr. Leila Hudson for their valuable insight into this dissertation and for their generous support and assistance throughout the course of my studies. -

Tekna Berbers in Morocco
www.globalprayerdigest.org GlobalDecember 2019 • Frontier Ventures •Prayer 38:12 Digest The Birth Place of Christ, But Few Will Celebrate His Birth 4—North Africa: Where the Berber and Arab Worlds Blend 7—The Fall of a Dictator Spells a Rise of Violence 22—Urdus: A People Group that is Not a People Group 23—You Can Take the Bedouin Out of the Desert, but … December 2019 Editorial EDITOR-IN-CHIEF Feature of the Month Keith Carey For comments on content call 626-398-2241 or email [email protected] ASSISTANT EDITOR Dear Praying Friends, Paula Fern Pray For Merry Christmas! WRITERS Patricia Depew Karen Hightower This month we will pray for the large, highly unreached Wesley Kawato A Disciple-Making Movement Among Ben Klett Frontier People Groups (FPGs) in the Middle East. They David Kugel will be celebrating Christmas in Bethlehem, and a few other Christopher Lane Every Frontier People Group in the Ted Proffitt places where Arabs live, but most will treat December 25 Cory Raynham like any other day. It seems ironic that in the land of Christ’s Lydia Reynolds Middle East Jean Smith birth, his birth is only celebrated by a few. Allan Starling Chun Mei Wilson Almost all the others are Sunni Muslim, but that is only a John Ytreus part of the story. Kurds and Berbers are trying to maintain PRAYING THE SCRIPTURES their identity among the dominant Arabs, while Bedouin Keith Carey tribes live their lives much like Abraham did thousands of CUSTOMER SERVICE years ago. Who will take Christ to these people? Few if any Lois Carey Lauri Rosema have tried it to this day. -

NATIONALIST MOVEMENTS in the MAGHRIB a Cornparative Approach
Research report no. 78 Hassan Sayed Suliman The Nationalist in the Maghrio A comparative approach Scandinavian Institute of Mrican Studies, Uppsala Research Reports Below you will lind a list of Research Reports published by the institute. Some of the reports are unfortunately out of print. Xero·copies of these reports can be obtained at a cost of SEK 0:50,- per page. 1. Meyer-Heiselberg, R, Notesfrom Liberated Afdcan 24. Nellis, John R, The Ethnic Composition ofLeading Department in the Archives at Fourah Bay College, Kenyan Government Positions. 26 pp. Uppsala 1974. SEK Freetown, Sierra Leone. 61 pp. Uppsala 1967. (OUT-OF 15,-. ISBN 91-7106-079-0. PRINT) 25. Francke, Anita, Kibaha Farmers' Training Centre. Impact 2. Not published. Study 1965-1968. 106 pp. Uppsala 1974. SEK 15,-. ISBN 3. Carlsson, Gunnar, Benthonic Fauna in African 91-7106-081-2. Watercourses with Special Reference to Black Fly 26. Aasland, Tertit, On the move-to-the-Left in Uganda 1969 Populations, 13 pp. Uppsala 1968. (OUT-OF-PRINT). 1971.71 pp. Uppsala 1974. SEK 15,-. ISBN 91-7106 4. Eldblom, Lars, Land Tenure - Social Organisation and 083-9. Structure. 18 pp. Uppsala 1969. (OUT-OF-PRINT) 27. Kirk-Greene, A.H.M., The Genesis ofthe Nigerian Civil 5. Bjeren, Gunilla, Makelle Elementary School Drop-out War and the Theory ofFear. 32 pp. Uppsala 1975. SEK 1967.80 pp. Uppsala 1969. (OUT-OF-PRINT) 15,-. ISBN 91-7106-085-5. 6. M~berg, Jens, Peter, Report Concerning the SOlI Profile 28. Okereke, Okoro, Agrarian Development Programmes of lnvestigation and Collection ofSoil Samples in the West African Countries.