Pietro Vacchelli
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Paolo Colombo, La Monarchia Dal
Quaderni del Dipartimento di Scienze Politiche Università Cattolica del Sacro Cuore 2 2 011 Quaderni del Dipartimento di Scienze Politiche Università Cattolica del Sacro Cuore Anno I - 2/2011 Registrazione presso il Tribunale di Milano n. 355 del 27.06.2011 Direttore responsabile Massimo de Leonardis Comitato editoriale Romeo Astorri, Paolo Colombo, Massimo de Leonardis (Direttore), Ugo Draetta, Vittorio Emanuele Parsi, Valeria Piacentini Fiorani Segretario di redazione Gianluca Pastori I Quaderni sono liberamente scaricabili dall’area web agli indirizzi www.educatt/libri/QDSP e http:// dipartimenti.unicatt.it/scienze_politiche_1830.html È possibile ordinare la versione cartacea: on line all’indirizzo www.educatt.it/libri; tramite fax allo 02.80.53.215 o via e-mail all’indirizzo [email protected] (una copia € 15; abbonamento a quattro numeri € 40). Modalità di pagamento: – bonifi co bancario intestato a EDUCatt - Ente per il Diritto allo Studio dell’Università Cattolica presso Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo - IBAN: IT 06 W 03309 03200 211609500166; – bonifi co bancario intestato a EDUCatt - Ente per il Diritto allo Studio dell’Università Cattolica presso Monte dei Paschi di Siena- IBAN: IT 08 D 01030 01637 0000001901668; – bollettino postale intestato a EDUCatt - Ente per il Diritto allo Studio dell’Università Cattolica su cc. 17710203 © 2011 EDUCatt - Ente per il Diritto allo Studio Universitario dell’Università Cattolica Largo Gemelli 1, 20123 Milano - tel. 02.7234.22.35 - fax 02.80.53.215 e-mail: [email protected] (produzione); [email protected] (distribuzione) web: www.educatt.it/libri ISBN: 978-88-8311-879-1 ISSN: 2239-7302 In copertina: Martin Waldseemller (1470 ca.-post 1522), Mappa della terra, 1507. -

Italian Army and Triple Alliance: an Historiographical Analysis
ISSN 2039-2117 (online) Mediterranean Journal of Social Sciences Vol 4 No 4 ISSN 2039-9340 (print) Published by MCSER-CEMAS-Sapienza University of Rome March 2013 Italian Army and Triple Alliance: An Historiographical Analysis Roberto Sciarrone Università La Sapienza di Roma Doi: 10.5901/mjss.2013.v4n4p197 Abstract During the twelve years between the taking of Rome by the conclusion of the Triple Alliance, the Italian army undergoes profound changes, as the policy of the newly unified state. These long twelve years to help us better understand the preparatory stages and the political effects that lead Italy to sign the agreements of the Triple Alliance. The politicians of taking an attitude almost detached, compared to the problems of the armed forces. In the financial crisis. The economic and social backwardness is manifested when we compare with other European countries. The problem that the Italian government has had to deal with the aftermath of Sedan, is transformation of the Italian army under the Prussian model. Keywords: Triple Alliance, Italian Army, Prussian model, Battle of Custoza, German Empire, Kingdom of Italy, Deutscher Krieg, Austro – Prussian war, Third independence war, Sedan, Prussian military system 1. Preamble Durante i dodici anni che separano la presa di Roma dalla stipulazione della Triplice alleanza, l’esercito italiano subisce profonde trasformazioni, come la politica del neo Stato unitario, ricca di colpi di scena e prodiga nel catapultarsi sul palcoscenico internazionale. Il morale dei militari italiani alla vigilia degli anni ’70 dell’800 è sfiduciato, apatia e delusione serpeggiano tra i soldati. I fallimenti del 1866 mantengono vive le polemiche sugli insuccessi di Custoza e Lissa (Scotti, 2004), destinate a riemergere, nei dibattiti in Parlamento, ogni qualvolta si discute circa i progetti di riordinamento dell’esercito (Venosta, 1866). -

Elenco Dei Governi Italiani
Elenco dei Governi Italiani Questo è un elenco dei Governi Italiani e dei relativi Presidenti del Consiglio dei Ministri. Le Istituzioni in Italia Le istituzioni della Repubblica Italiana Costituzione Parlamento o Camera dei deputati o Senato della Repubblica o Legislature Presidente della Repubblica Governo (categoria) o Consiglio dei Ministri o Presidente del Consiglio dei Ministri o Governi Magistratura Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) Consiglio di Stato Corte dei Conti Governo locale (Suddivisioni) o Regioni o Province o Comuni Corte costituzionale Unione Europea Relazioni internazionali Partiti e politici Leggi e Regolamenti parlamentari Elezioni e Calendario Referendum modifica Categorie: Politica, Diritto e Stato Portale Italia Portale Politica Indice [nascondi] 1 Regno d'Italia 2 Repubblica Italiana 3 Sigle e abbreviazioni 4 Politici con maggior numero di Governi della Repubblica Italiana 5 Voci correlate Regno d'Italia Periodo Nome del Governo Primo Ministro 23 marzo 1861 - 12 giugno 1861 Governo Cavour Camillo Benso Conte di Cavour[1] 12 giugno 1861 - 3 marzo 1862 Governo Ricasoli I Bettino Ricasoli 3 marzo 1862 - 8 dicembre 1862 Governo Rattazzi I Urbano Rattazzi 8 dicembre 1862 - 24 marzo 1863 Governo Farini Luigi Carlo Farini 24 marzo 1863 - 28 settembre 1864 Governo Minghetti I Marco Minghetti 28 settembre 1864 - 31 dicembre Governo La Marmora Alfonso La Marmora 1865 I Governo La Marmora 31 dicembre 1865 - 20 giugno 1866 Alfonso La Marmora II 20 giugno 1866 - 10 aprile 1867 Governo Ricasoli -

The Kingdom of Italy: Unity Or Disparity, 1860-1945
The Kingdom of Italy: Unity or Disparity, 1860-1945 Part IIIb: The First Years of the Kingdom Governments of the Historic Left 1876-1900 Decline of the Right/Rise of the Left • Biggest issue dividing them had been Rome—now resolved • Emerging issues • Taxation, especially the macinato • Neglect of social issues • Free trade policies that hurt the South disproportionately • Limited suffrage • Piedmontization • Treatment of Garibaldi volunteers • Use of police against demonstrations The North-South divide • emerging issues more important to South • Many of Left leaders from South Elections of 1874 • Slim majority for Right Fall of Minghetti, March 1876 Appointment of a Left Prime Minister and the elections of November 1876 Agostino Depretis Benedetto Cairoli Francesco Crispi Antonio Starabba, Marchese di Rudinì Giovanni Giolitti Genl. Luigi Pelloux Prime Minister Dates in office Party/Parliament Key actions or events Agostino Depretis 25 March 1876 Left Coppino Law Lombardy 25 December 1877 Sonnino and Iacini inquiry into the problems of the South Railway construction continues with state aid 26 December 1877 Left Anarchist insurrection in Matese 24 March 1878 Benedetto Cairoli 24 March 1878 Left Attempted anarchist assassination of king Lombary 19 December 1878 Depretis 19 December 1878 Left 14 July 1879 Cairoli 14 July 1879 Left Costa founds Revolutionary Socialist Party of Romagna 25 November 1879 25 November 1879 Left 29 May 1881 Depretis 29 May 1881 Left Widened suffrage; first socialist elected 25 May 1883 Italy joins Austria-Hungary and Germany to create Triplice Use of trasformismo 25 May 1883 Left 30 March 1884 Final abolition of grist tax macinato 30 March 1884 Left First colonial venture into Assab and Massawa on Red Sea coast 29 June 1885 29 June 1885 Left Battle of Dogali debacle 4 April 1887 4 April 1887 Left 29 July 1887 Died in office Francesco Crispi 29 July 1887 Left 10-year tariff war with France begun Sicily 6 February 1891 Zanardelli penal code enacted; local govt. -

JENS PETERSEN the Italian Aristocracy, the Savoy Monarchy, and Fascism
JENS PETERSEN The Italian Aristocracy, the Savoy Monarchy, and Fascism in KARINA URBACH (ed.), European Aristocracies and the Radical Right 1918-1939 (Oxford: Oxford University Press, 2007) pp. 91–110 ISBN: 978 0 199 23173 7 The following PDF is published under a Creative Commons CC BY-NC-ND licence. Anyone may freely read, download, distribute, and make the work available to the public in printed or electronic form provided that appropriate credit is given. However, no commercial use is allowed and the work may not be altered or transformed, or serve as the basis for a derivative work. The publication rights for this volume have formally reverted from Oxford University Press to the German Historical Institute London. All reasonable effort has been made to contact any further copyright holders in this volume. Any objections to this material being published online under open access should be addressed to the German Historical Institute London. DOI: 6 The Italian Aristocracy, the Savoy Monarchy, and Fascism JENS PETERSEN What political role did the aristocracy play in the early decades of a unified Italy? Researchers are widely divided in their opin- ions on this question. They range from the rose-tinted view of Arno Mayer, who regarded the ancien regi,me nobility as still at the core of Italy's social and political system, to opinions that speak of a rapid and unstoppable decline. 1 Although aristocratic values continued to shape the path of upward mobility for the middle classes, nobility as such did not play an important role in the Italian nineteenth-century social structure, because it did not constitute a well-defined group in itself, due to its regional more than national status. -

Questionariostoria
QuestionarioStoria 1 In seguito a quale evento bellico l'esercito del Regno 7 A seguito di quale accusa fu sciolto il Partito d'Italia poté entrare in Roma nel 1870? Socialista Italiano nel 1894? A) Alla sconfitta dei Francesi a Sedan A) L'accusa di aver appoggiato i Fasci siciliani B) Alla sconfitta dei Prussiani a Verdun B) L'accusa di spionaggio a favore della Seconda Internazionale socialista C) Alla sconfitta degli Austriaci a Sadowa C) L'accusa di voler attentare alla vita del sovrano D) Alla sconfitta dei Francesi a Lipsia D) L' accusa di aver attentato alla vita di Umberto I 2 Come reagì il governo Rudinì alle agitazioni popolari del 1898? 8 Tra quali nazioni l'irredentismo italiano fu causa di rapporti diplomatici tesi? A) Cercò alleanze in parlamento A) L'Italia e la Polonia B) Fece importanti concessioni ai dimostranti B) L'Italia e la Grecia C) Rassegnò le dimissioni C) L'Italia e l'Impero ottomano D) Si affidò all'esercito D) L'Italia e l'Austria - Ungheria 3 Nel 1884 il governo Depretis abolì un'imposta invisa alla popolazione. Quale? 9 In quale anno morì Camillo Cavour? A) La tassa sul macinato A) Nel 1865 B) La tassa doganale regionale B) Nel 1875 C) La tassa comunale di utilizzo delle acque pubbliche C) Nel 1861 D) La tassa sulla prima casa D) Nel 1871 4 Quali direttive di politica estera adottò Antonio 10 Nel 1861 espugnò, dopo un assedio, la fortezza di Rudinì nel marzo del 1896, quando fu incaricato di Gaeta, ultima roccaforte dei Borbone; condusse nella sostituire Francesco Crispi alla guida dell'Esecutivo? Terza guerra d'indipendenza le truppe dell'esercito che operavano sul basso Po. -

Working Paper Dipartimento Di Economia Pubblica
WORKING PAPER DIPARTIMENTO DI ECONOMIA PUBBLICA Working Paper n. 141 Silvia Fedeli e Francesco Forte A survival analysis of the circulation of the political elites governing Italy from 1861 to 1994 Roma, Aprile 2011 1 Silvia Fedeli and Francesco Forte A survival analysis of the circulation of the political elites governing Italy from 1861 to 1994 Abstract We study the determinants of governments and legislatures’ survival in Italy from the unification to the end of the I Republic (1861-1994) - excluding the fascist period and the subsequent transitory institutional period, "Constituente" (1946-1948). We test whether institutional features such as electoral systems, form of State and extent of suffrage had any effect on the survival of legislatures and governments. We control for voting power of the parliamentary groups, number of parties represented in the parliament and size of the representative bodies. Unlike the political economy wisdom, we show that, over the whole period, governments and legislatures’ survivals are inversely related to the plurality electoral system. The restricted suffrage and a high voting power of the leading parties reduce the risk of anticipated end of governments. The survival of the legislatures is related to the form of state (republic) and to the voting power of the leading party. Universita’ di Roma “La Sapienza” Facolta’ di Economia Dipartimento di Economia e diritto Via del Castro Laurenziano, 9 00161 Roma – Italy E-mail: [email protected] [email protected] Tel. and Fax +39 06 4976 6399 Keywords: Elites; Survival analysis; Electoral systems; Voting power, Political institutions. 2 1. Introduction In this paper we analyze the “struggle for survival” of governments and legislatures of the Italian democratic parliaments, from the creation of the Italian state (1861) up to 1994, with the exclusion of the fascist period (i.e., the legislatures from 1924 to 1945 in which the democratic institutions were absent and of the subsequent transitory institutional period, known as "Constituente", lasting until 1948). -
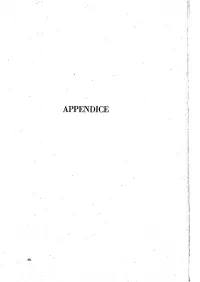
APPENDICE I - ' ' ' -Il
vi APPENDICE I - ' ' ' -il PRESIDENTI DELLA REPUBBLICA ENRICO DE NICOLA, Capo prov visorio dello Stato dal 28 giugno 1946 al 24 giugno 1947 dal 25 giugno al 31 dicembre 1947 ENRICO DE NICOLA, Presidente della Repubblica ; dal 1° gennaio 1948 all'11 maggio 1948 LUIGI EINAUDI, Presidente della Repubblica dall'll maggio 1948 >"..". r ?.-.' V-r^v;*-"^"^ - •«• « ***•••>*• , . :ir.'-.•.:••.• L T • ~ i : ~ . ..' -» "• »-1 -?. ' *- / >^1 • - A •; li ENRICO DE NICOLA 82. • ' ? LUIGI EINAUDI PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI GIOVANNI GRONCHI. dall'8 maggio 1948 PRESIDÈNTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA IVANOE BONOMI dall'8 maggio 1948 GIOVANNI GRONCHI -J-Ì IVANOE BONOMI PRESIDENTI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI DALLA I ALLA XXVI LEGISLATURA VINCENZO GIOBERTI dall'8 maggio al 20 luglio 1848 e dal 16 ott. 30 die. 1848 IL . LORENZO PARETO dal 1° febbr. al 30 marzo 1849 III. LORENZO PARETO dal 30 luglio al 20* nov. 1849 IV . PIER DIONIGI PINELLI dal 20 die. 1849 al 25 aprile 1852 UHBANO RATTAZZI dall'll maggio 1852 al 27 ott. 1853 CARLO BON-COMPAGNI dal 16 al 21 nov. 1853 V ... CARLO BON-COMPAGNI. dal 19 die. 1853 al 16 giugno 1856 CARLO CADORNA.. dal 7 genn. al 16 luglio 1857 VI .. CARLO CADORNA. dal 14 die. 1857 al 14 luglio 1858 URBANO RATTAZZI. dal 10 genn. 1859 al 21 genn. 1860 VII . GIOVANNI LANZA dal 2 aprile al 28 die. 1860 VIII URBANO RATTAZZI. dal 18 febbr. 1861 al 2 marzo 1862 SEBASTIANO TECCHIO dal 22 marzo 1862 al 21 magg. 1863 GIOVANNI BATTISTA CASSINIS dal 25 maggio 1863 al 7 sett. 1865 IX. -

Roma Capitale D'italia
3 2020 20 SETTEMBRE 1870 ROMA CAPITALE D’ITALIA LA PRESA DI PORTA PIA Presentazione del 150° anniversario della Presa di Porta Pia UN IMPORTANTISSIMO PASSO PER LA PATRIA L’ESERCITO ITALIANO RESTITUISCE ROMA ALL’ITALIA Roma caput mundi, dicevano i Romani. Roma capitale d’Italia, gridarono gli italiani un secolo e mezzo fa. Esattamente 150 anni fa, intorno alle 9 del mattino del 20 settembre 1870, l’artiglieria dell’Eser- cito Italiano aprì una breccia nelle Mura aureliane di Roma, a pochi passi da Porta Pia, dopo un cannoneggiamento durato circa quattro ore. Un battaglione bersaglieri e uno di fanteria varcarono la breccia e restituirono alla Città Eterna, dopo ben mille anni, il ruolo di Capitale di tutta la Penisola. La data della presa di Roma, uno degli ultimi capitoli del nostro Risorgimento, venne celebrata in tutto il Paese rinominando, in numerose città italiane, una via centrale in via XX settembre; fu anche proclamata festa nazionale, abolita poi nel 1929 con i Patti Lateranensi FKHSRVHUR¿QHDOOD³4XHVWLRQH5RPDQD´WUD6WDWRH&KLHVD Dopo le prime esitazioni, la popolazione capitolina partecipò con entusiasmo, come raccontano le cronache dell’epoca: «Molti cittadini romani cominciano a girare per le strade armati alla meglio e con bandiere tri- colori. Una folla considerevole s’avvia alle Quattro Fontane (strada di Porta Pia); accoglie ed accompagna con entusiasmo indescrivibile, con plausi e canti e lacrime di gioia l’Esercito libe- ratore che, occupando gli sbocchi delle vie traverse, si dirige sulla gran piazza di Monte Cavallo dirimpetto al palazzo del Quirinale» (Gazzetta del Popolo, 25 settembre 1870). &RQTXHVWR6XSSOHPHQWRDOOD³5LYLVWD0LOLWDUH´O¶(VHUFLWR,WDOLDQRFKHLOVHWWHPEUHULX- scì a realizzare un sogno coltivato dagli italiani in tanti decenni, vuole celebrare assieme a tutti i lettori e gli appassionati questo eccezionale anniversario dando spazio anche a personaggi, DVSHWWLHFXULRVLWjPHQRQRWHGHOODFHOHEUH³EUHFFLDGL3RUWD3LD´ Buona lettura! Il Direttore Proprietario MINISTERO DELLA DIFESA Editore Difesa Servizi S.p.A. -

Interventi Centenario Anci
Camera dei deputati CELEBRAZIONE DEL CENTENARIO DELL'ANCI ROMA, PALAZZO MONTECITORIO 19 MARZO 2001 Resoconto Stenografico CELEBRAZIONE DEL CENTENARIO DELL'ANCI LUNEDI’ 19 MARZO 2001 PRESIDENZA DEI PRESIDENTI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI LUCIANO VIOLANTE E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA NICOLA MANCINO INDICE DEGLI INTERVENTI Violante Luciano, Presidente della Camera dei deputati...................................................................... Mancino Nicola, Presidente del Senato della Repubblica..................................................................... Bianco Enzo, Ministro dell'interno, Presidente della Conferenza Stato-città e autonomie locali ....... Agostinacchio Paolo, Presidente del Consiglio nazionale dell'ANCI................................................... Domenici Leonardo, Presidente dell'ANCI ........................................................................................... 2 I lavori cominciano alle 10,40. (Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi entra in aula accompagnato dal Presidente della Camera e dal Presidente del Senato - L'Assemblea si leva in piedi - Vivi generali applausi) LUCIANO VIOLANTE, Presidente della Camera dei deputati. Signor Presidente della Repubblica, signore, signori, signori sindaci, la storia d’Italia è stata per secoli storia di città. Una poco nota documentazione di questa storia è costituita dal primo grande atlante cartografico italiano, redatto agli inizi del XVII secolo da Giovanni Antonio Mangini. Quest’opera, fondamentale nella cartografia, si caratterizza -

N.B. Per Comodita' Di Consultazione La Risposta Esatta E' Sempre Quella Indicata Nella Colonna “Risposta A” Storia P
N.B. PER COMODITA’ DI CONSULTAZIONE LA RISPOSTA ESATTA E’ SEMPRE QUELLA INDICATA NELLA COLONNA “RISPOSTA A” CODICE DOMANDA RISPOSTA A RISPOSTA B RISPOSTA C RISPOSTA D 00001 Nell'agosto 1862, Giuseppe Garibaldi è ferito e In Aspromonte, durante una Durante uno scontro con le A Brescia, dove una Durante le guerriglie del arrestato.... spedizione armata partita truppe regie ai confini del manifestazione popolare che brigantaggio che lo vedono dalla Sicilia alla volta di Trentino. chiedeva la liberazione di 123 protagonista nel periodo di Roma. volontari garibaldini, si permanenza in Sicilia. concluse tragicamente con i soldati che sparano sulla folla. 00002 Si legga il seguente avvenimento storico: Nel periodo che va dal Nel periodo che va dall'Unità Nel periodo tra la prima e la Nel periodo della prima «nell'agosto del 1860 a Bronte, Nino Bixio guidava i Congresso di Vienna all'Unità d'Italia all'avvento del seconda guerra mondiale. guerra mondiale. garibaldini nella repressione della rivolta dei d'Italia. Fascismo. contadini attuata con una serie di fucilazioni ed arresti in massa». Si indichi in quale dei seguenti periodi storici si è verificato. 00003 La spedizione dei Mille fu preceduta da una serie Francesco Crispi. Palmiro Togliatti. Benito Mussolini. Carlo V. di insurrezioni che si svolsero in Sicilia, le quali dovevano essere sostenute, per non essere represse ancora una volta, da un aiuto esterno. Uno dei principali animatori di tali rivolte fu.... 00004 Da chi era presieduto il Governo italiano che Luigi Pelloux. Giuseppe Garibaldi. Camillo Benso di Cavour. Gabriele D'Annunzio. presentò al Parlamento, nel 1899, alcune leggi eccezionali che prevedevano pesanti limitazioni al diritto di associazione, di riunione e alla libertà di stampa? 00005 La località di Custoza è nota per essere stata Di una famosa sconfitta Di una clamorosa sconfitta Della firma di un armistizio Di una celeberrima vittoria scenario: dell'armata guidata da La della flotta italiana di quattro settimane tra Italia della compagine garibaldina Marmora, nel 1866. -

Competing Ideas
EUROPEAN UNIVERSITY INSTITUTE Department of Political and Social Sciences Competing Ideas The Religious Foundations of the German and Italian Welfare States Josef Hien Thesis submitted for assessment with a view to obtaining the degree of Doctor of Political and Social Sciences of the European University Institute Examining Board: Prof. Sven Steinmo (EUI, Supervisor) Prof. Stefano Bartolini (EUI) Prof. Mark Blyth (Brown University) Prof. Wolfgang Streeck (Max Planck Institute) © (2012) Josef Hien No Parts of the thesis may be copied, reproduced or transmitted without prior permission of the author. 2 ABSTRACT This thesis investigates the influence of political Catholicism and Catholic social doctrine on the evolution of the continental European welfare regimes. Paradoxically it finds that the doctrine had less influence on the formation of welfare regimes in countries where Catholicism was strong in contrast to countries where it was in a weak minority position. This finding does not only challenge many of the accounts that have perceived and analyzed religious influences on welfare state formation as a static and quantifiable variable but also addresses and rivals most postulations of mainstream welfare state theories such as Logic of Industrialism, Power Resource, Class Coalition and Employer Centered Approaches. In contrast to these postulations this thesis finds that welfare in continental Europe evolved during the 19th century and most of the 20th century as the result of a battle over ideas and worldviews between different societal groups and their political outlets. Which idea and worldview makes its way into institutional implementation is not primarily connected to the mere numerical strength or power resources of its societal and political representation but is a function of the performance of the programmatic ideas themselves.