Villaggio Crespi D'adda
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
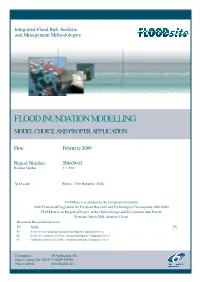
Flood Inundation Modelling Model Choice and Proper Application
Integrated Flood Risk Analysis and Management Methodologies FLOOD INUNDATION MODELLING MODEL CHOICE AND PROPER APPLICATION Date February 2009 Report Number T08-09-03 Revision Number 3_3_P01 Task Leader Deltares | Delft Hydraulics (Delft) FLOODsite is co-funded by the European Community Sixth Framework Programme for European Research and Technological Development (2002-2006) FLOODsite is an Integrated Project in the Global Change and Eco-systems Sub-Priority Start date March 2004, duration 5 Years Document Dissemination Level PU Public PU PP Restricted to other programme participants (including the Commission Services) RE Restricted to a group specified by the consortium (including the Commission Services) CO Confidential, only for members of the consortium (including the Commission Services) Co-ordinator: HR Wallingford, UK Project Contract No: GOCE-CT-2004-505420 Project website: www.floodsite.net Task 8 Flood Inundation Modelling D8.1 Contract No:GOCE-CT-2004-505420 DOCUMENT INFORMATION Title Flood Inundation Modelling – Model Choice and Proper Application Lead Author Nathalie Asselman Paul Bates, Simon Woodhead, Tim Fewtrell, Sandra Soares-Frazão, Yves Contributors Zech, Mirjana Velickovic, Anneloes de Wit, Judith ter Maat, Govert Verhoeven, Julien Lhomme Distribution Public Document Reference T08-09-03 DOCUMENT HISTORY Date Revision Prepared by Organisation Approved by Notes 22/11/07 1_0_P02 NA Deltares |Delft Initial draft 25/02/08 1_1_P35 SSF UCL 01/08/08 1_2_P02 NA Deltares|Delft results on Scheldt and Thames 23/11/08 1_3_p02 NA Deltares|Delft results on Brembo included 3/12/08 1_4_P15 PB UniBris General edit 10/12/08 1_5_p35 SSF-MV-YZ UCL 11/12/08 1_6_p01 JL HRW additional results on Thames 15/12/08 2_0_P02 NA Deltares|Delft final draft 22/01/09 2_1_P03 AK LWI comments 03/02/09 3_0_P02 NA Deltares|Delft incl. -

Devastata La Valle Brembana
Pagina 6 L’ECODI BERGAMO Lunedì 20 luglio 1987 , QUATTROCENTO MILIARDI I DANNI DELL’ ALLUVIONE Devastata la Valle Brembana Tutta l’alta ‘valle è una rete di frane e, paese per paese, è un susseguirsi di situazioni assai critiche - Ancora cinque le località isolate, Ornica, Valtorta, Mezzoldo, Piazzatorre e Foppolo - La statale è parzialmente bloccata, si può procedere su una sola carreggiata, quella discendente: ampi tratti spazzati via nella zona dei Piani di Scalvino e di Camerata - Cancellate numerose strade nella zona di Valtorta e Mezzoldo Centinaia di turisti sono scesi a valle a piedi per mettersi in collegamento con i familiari - La m<ontagna minaccia Pizzino in Val Taleggio= sgomberate unu cinquantina di persone - Una sola vittima accertata: a Lenna - Scomparsa nelle acque del Brembo a Mezzoldo una ragazza di Longuelo - Tante persone salvate in extremis dagli elicotteri - Grande solidarietà nei soccorsi, tempestivi e ben coordinati gli interventi della Protezione Civile, nonché di Carabinieri, agenti di Polizia, tecnici della Sip, della luce, del gas - Una valle totalmente sconvolta: ma si è già cominciato a lavorare per ripristinare la situazione precedente - Il Brembo in lento deflusso, dopo una giornata dal tempo incerto Un disastro di grandi ed an- as+ utilizzando la sede della cora incalcolabili proporzioni, Perrovia. In elicottero sorvolando la zona del disastro anche se una prima quantifi- Il vicepréfetto vicario dott. cazione parla di danni per 400 Mario Torda, ha confermato miliardi: così si uò dire delle ieri pomeriggio che in tutta la conseguenze 8 ell’alluvione Valle Brembana solo una per- scatenatasi su tutta la Valle sona sarebbe rimasta vittima - - - - - - Brembana. -

A Symbol of Global Protec- 7 1 5 4 5 10 10 17 5 4 8 4 7 1 1213 6 JAPAN 3 14 1 6 16 CHINA 33 2 6 18 AF Tion for the Heritage of All Humankind
4 T rom the vast plains of the Serengeti to historic cities such T 7 ICELAND as Vienna, Lima and Kyoto; from the prehistoric rock art 1 5 on the Iberian Peninsula to the Statue of Liberty; from the 2 8 Kasbah of Algiers to the Imperial Palace in Beijing — all 5 2 of these places, as varied as they are, have one thing in common. FINLAND O 3 All are World Heritage sites of outstanding cultural or natural 3 T 15 6 SWEDEN 13 4 value to humanity and are worthy of protection for future 1 5 1 1 14 T 24 NORWAY 11 2 20 generations to know and enjoy. 2 RUSSIAN 23 NIO M O UN IM D 1 R I 3 4 T A FEDERATION A L T • P 7 • W L 1 O 17 A 2 I 5 ESTONIA 6 R D L D N 7 O 7 H E M R 4 I E 3 T IN AG O 18 E • IM 8 PATR Key LATVIA 6 United Nations World 1 Cultural property The designations employed and the presentation 1 T Educational, Scientific and Heritage of material on this map do not imply the expres- 12 Cultural Organization Convention 1 Natural property 28 T sion of any opinion whatsoever on the part of 14 10 1 1 22 DENMARK 9 LITHUANIA Mixed property (cultural and natural) 7 3 N UNESCO and National Geographic Society con- G 1 A UNITED 2 2 Transnational property cerning the legal status of any country, territory, 2 6 5 1 30 X BELARUS 1 city or area or of its authorities, or concerning 1 Property currently inscribed on the KINGDOM 4 1 the delimitation of its frontiers or boundaries. -

Verona Featuring Venice and the Italian Lakes
SMALL GROUP Ma xi mum of LAND 24 Travele rs JO URNEY Verona featuring Venice and the Italian Lakes Inspiring Moments > Embrace the romantic ambience of Verona, where Romeo and Juliet fell in love, brimming with pretty piazzas, quiet parks and a Roman arena. > Wander through the warren of narrow INCLUDED FEATURES streets and bridges that cross the canals of Venice. Accommodations (with baggage handling) Itinerary > Dine on classic cuisine and sip the – 7 nights in Verona, Italy, at the Day 1 Depart gateway city Veneto’s renowned wines as you first-class Hotel Indigo Verona – Day 2 Arrive in Verona and transfer enjoy a homemade meal. Grand Hotel des Arts. to hotel. > Cruise Lake Garda and experience the Extensive Meal Program Day 3 Verona chic Italian lakes lifestyle. – 7 breakfasts, 3 lunches and 3 dinners, Day 4 Lake Garda | Valpolicella Winery > Admire Palladio’s architectural including Welcome and Farewell Dinners; Day 5 Venice genius in Vicenza . tea or coffee with all meals, plus wine Day 6 Verona > Experience three UNESCO World with dinner. Day 7 Bassano del Grappa | Vicenza Heritage sites. – Opportunities to sample authentic cuisine and local flavors Day 8 Padua | Verona Day 9 Transfer to airport and depart Scenic Lago di Garda Your One-of-a-Kind Journey for gateway city – Discovery excursions highlight the local culture, heritage and history. Flights and transfers included for AHI FlexAir participants. – Expert-led Enrichment programs Note: Itinerary may change due to local conditions. enhance your insight into the region. Activity Level: We have rated all of our excursions with activity levels to help you assess this program’s physical – AHI Sustainability Promise: expectations. -

Aggiornamento Piano D'ambito Dell'a.T.O. Di Bergamo
Aggiornamento Piano d’Ambito dell’A.T.O. di Bergamo Inquadramento territoriale Capitolo 1 1.4 Distribuzione della popolazione e delle attività produttive La struttura e la dinamica della popolazione sono elementi fondamentali per un corretto dimensionamento del Piano d’Ambito, pertanto risulta di notevole interesse l’analisi dei dati statistici scaricati dalla banca dati dell’ISTAT. Al 01.01.2013 la Provincia di Bergamo conta una popolazione di 1.094.062 abitanti, suddivisa in 244 Comuni (ora 242) e corrispondente al 11% della popolazione regionale. PROVINCIA POPOLAZIONE RESIDENTE AL 01/01/2013 Varese 876.960 Como 592.504 Lecco 338.425 Sondrio 181.101 Milano 3.075.083 Bergamo 1.094.062 Brescia 1.247.192 Pavia 539.569 Lodi 225.798 Cremona 361.812 Mantova 411.335 Monza e della Brianza 850.684 TOTALE REGIONE 9.794.525 Tabella 1.4.1 - Popolazione residente in Lombardia suddivisa per Provincia, fonte ISTAT. Popolazione residente in Lombardia per provincia, anno 2013 Cremona Monza e della 4% Mantova Brianza Como 4% 9% 6% Lecco Lodi Varese 3% 2% 9% Sondrio Pavia 2% 6% Brescia 13% Milano Bergamo 31% 11% Grafico 1.4.1 - Popolazione residente in Lombardia suddivisa per Provincia in %, fonte ISTAT. Per meglio comprendere le dinamiche demografiche, oltre al dato di riferimento principale appena descritto è interessante riportare anche l’evoluzione demografica nell’ultimo decennio della Provincia di Bergamo e il confronto con le altre province lombarde. 20 Aggiornamento Piano d’Ambito dell’A.T.O. di Bergamo Inquadramento territoriale Capitolo 1 I dati relativi alla popolazione bergamasca nell’intervallo analizzato 2002-2013 mostrano un costante incremento dei residenti interrotto solo da una leggera diminuzione nel 2012 (vd. -

Italy YOUR ITINERARY
Offered to the Students and Friends of Smith Preparatory Academy and FCCPSA The Splendors of Italy Verona-Vicenza-Venice-Padua-Florence-Siena-San Gimignano-Rome* February 24 – March 7, 2022 YOUR ITINERARY Together with Leader Michael Phillips: Headmaster of Smith Preparatory Academy and a Director of FCCPSA. $ from Orlando* February 24–March 7, 2022 Tour Code: 222118 On February 24th, you will depart Orlando to spend 12 wonderful days discovering the splendors of Italy. Fantastic excursions, cultural encounters, historical sites, delicious food and exotic shopping make this trip exciting and rewarding. Bring these amazing memories home with you on March 7th. SPACE ON THE TOUR IS LIMITED, SO DON’T DELAY! PLEASE RETURN YOUR ONLINE APPLICATION AND $100 DEPOSIT TO EATOURS.COM BY AND RECEIVE A FREE GONDOLA RIDE IN VENICE! Verona, Vicenza, Padua & Venice February 24-February 27, 2022 Upon arrival February 25th, you will transfer to Verona, a delightful city for enjoying a guided tour* including the Roman Arena* and Juliet’s balcony before continuing to your hotel in Vicenza. Complete the afternoon exploring the city before dinner. The morning of February 26th, you will depart Vicenza on a scenic train* for an excursion to Padua! Padua is an old university town with an illustrious academic history that is rich in art and architecture. Upon arrival to Padua, a guided tour of the city* is planned, including the Scrovengi Chapel* and St. Anthony’s Basilica*. Dedicate this afternoon to exploring Vicenza where you may optionally visit Teatro Olympico. Your adventure continues February 27th, on a picturesque train* ride excursion to Venice! Enjoy a guided tour of the city* where you may see sights such as St. -

Crespi D'adda
1- Benedetta Barchielli – Silvia Cacciamani Patrimonio Mondiale Liceo Scientifico Statale “Evangelista Torricelli” 2 -Giada Dafano – Francesca Marcucci Roma L’industria tessile in Lombardia Corso di Disegno e Storia dell’arte – Prof.ssa Flavia Pusic 3 - Sara Quadraccia – Silvia Quadraccia 2012/2013 La famiglia Crespi 4 - Michela Campolo – Giulia Paravati Città operaie in Europa: Italia e Inghilterra 5 - Sara Boscherini – Giorgiana Rapagna La storia del Villaggio Crespi d’Adda Crespi d’Adda 6 - Arianna Arigoni – Giulia Cancellara I fondatori – Le ville 7 - Andrea Sabatucci La Villa castello - Architettura Neogotica 8 - Alessandra Albani – Ludovica Iezzi Ingresso – Case operaie – Fabbrica 9 - Davide Morelli – Tiziano Ortelli Storia della Fabbrica dalla costruzione ai nostri giorni 10 - Lorenzo Pecere – Luca pellizzaro Chiesa - Cimitero 11 – Andrea Barigelli – Guido Casarano Scuola – Dopolavoro 12 – Simone Mancini Centrale idroelettrica Taccani 13 – Sara Quadraccia – Silvia Quadraccia Da 1929 ad oggi 1 Crespi d’Adda Patrimonio Mondiale UNESCO PATRIMONIO CULTURALE Barchielli-Cacciamani IL PATRIMONIO MONDIALE DELL'UNESCO E I CRITERI PER L'INSERIMENTO • I beni culturali sono definiti come monumenti o insiemi eccezionali storicamente, artisticamente o scientificamente. I siti naturali sono formazioni fisiche o biologiche che hanno valore estetico o scientifico straordinario. I siti misti, frutto dell'azione combinata della natura e dell'uomo, conservano la memoria di modi di vita tradizionali e rappresentano il legame tra la natura e la cultura. -

Sicily a Guided Walking Adventure
ITALY Sicily A Guided Walking Adventure Table of Contents Daily Itinerary ........................................................................... 4 Tour Itinerary Overview .......................................................... 14 Tour Facts at a Glance ........................................................... 16 Traveling To and From Your Tour .......................................... 18 Information & Policies ............................................................ 21 Italy at a Glance ..................................................................... 22 Packing List ........................................................................... 27 800.464.9255 / countrywalkers.com 2 © 2016 Otago, LLC dba Country Walkers Travel Style This small-group Guided Walking Adventure offers an authentic travel experience, one that takes you away from the crowds and deep in to the fabric of local life. On it, you’ll enjoy 24/7 expert guides, premium accommodations, delicious meals, effortless transportation, and local wine or beer with dinner. Rest assured that every trip detail has been anticipated so you’re free to enjoy an adventure that exceeds your expectations. And, with our optional Flight + Tour Combo and Taormina PrePre----tourtour Extension to complement this destination, we take care of all the travel to simplify the journey. Refer to the attached itinerary for more details. Overview Sicily embraces you warmly, like a glass of its own sweet Moscato—its radiance due to a gloriously temperate climate, striking natural beauty, -

Terna Frees the Parco Delle Orobie Bergamasche and the Province of Bergamo of 56 Km of Old Power Lines
TERNA FREES THE PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE AND THE PROVINCE OF BERGAMO OF 56 KM OF OLD POWER LINES By 2020 Terna will demolish around 200 electricity pylons in the Bergamo area 23 municipalities within the province will benefit from the liberation of over 140 hectares of land Rome, 12 September 2018 - Terna continues its rationalisation of the Lombardy electricity lines to make them more efficient, secure and sustainable, demolishing around 56 km of old power lines and 200 electricity pylons in the province of Bergamo, some of which are located in highly valued areas of natural interest, like the Parco delle Orobie Bergamasche. The demolition works that Terna plans to complete by 2020 have been made possible with the entry into service of the 132 kV Stazzona -Verderio line, following significant modernisation works, and will generate positive results for the local communities by liberating around 140 hectares of land in the province of Bergamo. 23 Municipalities will benefit from the demolition of the old power lines: Solza, Calusco d’Adda, Carvico, Sotto il Monte Giovanni XXIII, Mapello, Ambivere, Palazzago, Almenno S. Bartolomeo, Almenno S. Salvatore, Strozza, Capizzone, Ubiale Clanezzo, Brembilla, Zogno, San Pellegrino Terme, San Giovanni Bianco, Camerata Cornello, Lenna, Piazza Brembana, Piazzolo, Olmo al Brembo, Averara and Mezzoldo. The rationalisation projects are part of a larger plan to restructure the electricity lines in Lombardy, also affecting the provinces of Milan, Sondrio, Lecco and Monza Brianza, and allowing the demolition of over 150 km of old power lines, for a total of around 600 electricity pylons. In Lombardy, Terna manages 9,740 km of electricity lines and 135 electricity substations and has 337 employees responsible for the daily security of the regional electricity grid. -

INTRODUCTION Hospital
INTRODUCTION Hospital Pratical Tips INTRODUCTION CONTENTS WELCOME A brief introduction to USAG Italy 01 | and Family and MWR. VICENZA FACILITIES Information about on-post 02-21 | facilities and services in Vicenza. VICENZA POST MAPS General maps of posts in Vicenza FACILITY INFORMATION 22-23 | with MWR facilities highlighted. A snapshot of everything Family 04 | and MWR offers in USAG Italy. ALL THINGS TRAVEL Information on licenses, traveling, 24-25 | passports and more. FURRY FRIENDS A glimpse of useful information 27 | and tidbits for pet owners. ITALIAN INFO USEFUL INFORMATION Helpful Italian words and phrases Find out helpful information about 28-29 | and local information/traditions. 24 | the community and more! CITIES, MAPS & MORE Get inspired to travel outside the 30-57 | gate with these guides and maps. DARBY FACILITIES Information about on-post 58-63 | facilities and services in Darby. DARBY ON-POST MAP CITY GUIDES A general map of Darby with See a snapshot of cities and places 59 | MWR facilities highlighted. 30 | in and around USAG Italy. Cover Image: Verona, Italy “Go To Guide” designed by: Family and MWR Marketing (Richard Gerke, Beatrice Giometto, Alyssa Olson) Advertising Disclaimer: No federal, DoD or Army endorsement is implied. Interested in advertising with us? Contact Family and MWR Marketing at 0444-61-7992 or at 338-726-4361. INTRODUCTION WELCOME! A WORD FROM USAG ITALY FAMILY AND MWR Welcome to U.S. Army Garrison Italy! USAG Italy is a community of service members, civilians, family members, and Italian military and civilian employees. These Army locations cover a broad region south of the Alps that include: Caserma Ederle, Caserma Del Din and satellite locations around Vicenza, as well as Camp Darby, located in Livorno on Italy’s western coast. -

Vicenza Schools
Vicenza Elementary School Vicenza High School Vicenza Middle School VICENZA SCHOOLS REGISTRATION CHECKLIST SCHOOL YEAR 2016-2017 Documents required for school registration at: Vicenza Elementary/ Middle /High Schools Copy of Orders with Dependents listed ______ Sponsor’s ID Card (Contractors Only) Immunization Records Previous School Records (if new student) st Birth Certificate –Kinder & 1 Grade Students Kindergarten students must be 5 years-old by SEPTEMBER 1 of this calendar year 1st Grade students must be 6 years-old by SEPTEMBER 1 of this calendar year Passport for High School Students only A yearly physical is required for students participating in athletics (Grades 6-12 only) Required registration forms included in packet: DoDEA-Form 600 – Shaded/Colored Areas for Office Use ONLY DoDEA ESL Form F4 – ESL Home Language Questionnaire Guidance Resources Checklist- Guidance Survey DSM For 149 – Request for Student Records DoDEA Form 700 & 700A – Consents & Authorizations, Internet Usage Agreement Nurse Form & DoDEA Form 2942.0 0-M-F1 - School Health Forms School Transportation Form– Return to Transportation Office Lunch account form – Return to PX Customer Service Please return all completed forms & documents to the Registrar. DEPARTMENT OF DEFENSE EDUCATION ACTIVITY ESL Home Language Questionnaire Privacy Act Notice: Authority to Collect Information: 20 U.S.C. 927(c) and 10 U.S.C. 2164(f), as amended; E.O 9387; the Privacy Act of 1974, as amended, 5 U.S.C. 552a. Principal Purpose: The information will be used within the DoD to determine the services to be provided to a student to assist the child to receive a free appropriate public education. -

Winery: Montenidoli Vigneron
Winery: Montenidoli Vigneron: Elisabetta Fagiouli Varietals: Vernaccia Region: San Gimignano, Tuscany, Italy Name of wine: Carato Soil: calcareous & marine sediments Vinification/ Maturation: grapes are harvested when perfectly ripe free-run must from the best vineyards ferments in barrels and ages on the lees for 12 months Tasting Notes: Golden yellow color with aroma's of cedar & vanilla the palate has an amazing richness and complexity with white peach and apricot & a flinty minerality with spice at the end.... perfect with rich seafood dishes such as swordfish or lobster great with cheese! perfect to just drink!! drinkOKwines.com @drinkokwines about Elisabetta and Montinedoli Montenidoli is a place so rooted in tradition and history that sometimes it is hard to remember that Elisabetta (and Sergio) didn't grow up here. So deeply ingrained are the "old ways" and the "traditional vines" that you sipping a Montenidoli wine, you can almost taste the wines imbibed by the Knights of the Templar as they stayed in San Gimignano on the way to whatever crusade was calling for me, the story of Montinedoli is the love story of Elisabetta and Sergio. They came to this place for many reasons - leaving behind the tradition of arranged marriage & the expectation of Italian royalty - drawn by the spirituality and the wildness of the abandoned vineyards & olive groves. Montenidoli means the mountain of the little nests. When Sergio & Elisabetta arrived they had nine children with them - it was 1965. Elisabetta was born to a family that had cultivated vines and olive trees not far from Verona, since the 1700s.