Riese-Memorie-Storiche.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Carte Libri Memorie. Conservare E Studiare Gli Archivi Di Persona
Carte libri memorie. Conservare e studiare gli archivi di persona Materiali dalla giornata di studio organizzata da Fondazione Benetton Studi Ricerche, Treviso, 26 ottobre 2007 Il fondo Angelo Marchesan STEFANO CHIOATTO (Seminario vescovile, Treviso) L’archivio del Seminario vescovile di Treviso viene a formarsi con l’inizio dell’isti- tuzione, all’immediato ridosso del Concilio di Trento. Il primo registro che si possiede risale al 1567. Gli otto trasferimenti di sede succedutisi da quel tempo fino agli anni 1841-1842, allorquando definitivamente il Seminario venne a stabilirsi nei locali dell’ex convento di San Nicolò, acquistato dalla diocesi dal demanio, insieme all’occupazione delle truppe francesi negli anni a cavallo tra Sette e Ottocento, alle vicende belliche delle due guerre mondiali e i relativi bombardamenti, ne hanno ovviamente danneggiato la con- sistenza. E tuttavia anche nell’attuale dimora l’archivio non deve aver trovato per lungo tempo una collocazione precisa e stabile. Prima dei lavori di ristrutturazione della zona adibita a biblioteca, avvenuti tra il 1999 e il 2003, occupava tre locali, in due diverse ali del Seminario. In uno di tali locali era stata trasferita, su armadi appositamente predispo- sti alla fine degli anni ottanta, una parte considerevole di esso. Finalmente dall’autunno del 2003 riposa, per così dire, in un unico locale, utilizzando un piano mezzano, tra il primo e il secondo, del reparto San Giuseppe, costruito all’inizio degli anni cinquanta. Tale problematica situazione logistica è la probabile conseguenza della non chiara attri- buzione di competenze all’interno dell’istituzione su chi dovesse ricoprire il compito di archivista. -

Breda Di Piave Interno 2.Pdf
COMUNE DI BREDA DI PIAVE PROVINCIA DI TREVISO Si ringraziano per la collaborazione: il gruppo di ricerca:Bruscagnin Francesca Cattarin Remo Fedrigo Sandra Panizzo Luigi Pignatiello Roberto e tutte le persone che a vario titolo hanno fornito: fonti, suggerimenti e testimonianze. Si ringrazia inoltre il F.A.S.T. - Foto Archivio Storico Trevigiano che ha concesso alcune delle foto pubblicate. Con il F.A.S.T. - Foto Archivio Storico Trevigiano, l’Amministrazione Provinciale di Treviso ha avviato un’operazione culturale importante e destinata ad irradiarsi ben oltre i propri confini amministrativi. Salvaguardare, le opere dei fotografi diventa un imperativo; con queste si manterrà viva anche la memoria storica della nostra terra veneta. Per le autorizzazioni alla pubblicazione di documenti depositati nell’Archivio di Stato di Treviso, si fa riferi- mento alla concessione della Direzione dello stesso n. 4/2002, prot. n. 880 del 13.3.2002. © Copyright 2002 - Comune di Breda di Piave (Treviso) Stampa: S.I.T. Società Industrie Tipolitografiche s.r.l. Dosson di Casier (TV) Giuliano Simionato BREDA DI PIAVE Vita e storia di un Comune Biblioteca Comunale Breda di Piave 2002 PRESENTAZIONE Se dovessi dire qual è stata la motivazione profonda che mi ha guidato in questi anni di impegno amministrativo, non esiterei a rispondere che è stato l’a- more per la mia terra e la sua gente, senza limiti di spazio e di tempo. Quando decidemmo di offrire ai cittadini e agli studiosi un’opera sulla sto- ria di Breda ci si ponevano due possibili percorsi: quello di una ricostruzione sommaria degli avvenimenti, evidentemente di rapida stesura ma certamente anonima e superficiale, oppure quello di uno studio scientificamente fondato su fonti note e sconosciute. -

Guión Bibliográfico-Hagiográfico Capu¿Hino I(^68-Igy8
Guión bibliográfico-hagiográfico capu¿hino i(^68-igy8 Hace ahora diez años aparecía en las páginas de nuestra revista un estudio acerca del tema que encabeza estas líneas desde el año 1957 hasta 1967, entrambos inclusive1. Hoy se continúa aquella tarea con la intención de ofrecer un instrumento de trabajo a quienes deseen investigar y penetrar más a fondo la personalidad y espiritualidad de los representantes más cualificados de la santidad de la Iglesia en el marco particular de una Orden religiosa. Objeto del presente ensayo, como se desprende de su título, es la temática relativa al santoral capuchino reflejada en la bibliografía pu blicada durante los dos últimos lustros. Se prescinde de la valoración científica de las publicaciones, de su naturaleza, dimensiones y finalidad. Se reseña bibliográficamente todo cuanto se ha publicado respecto al santoral de la Orden, es decir, relacionado con los protagonistas de la santidad canonizada o canonizable en cualquiera de sus fases o estadios en orden al reconocimiento canónico de las virtudes y del culto: desde los primeros pasos dados en las diócesis y provincias respectivas para presentarlos como modelos de conducta ejemplar hasta que la Iglesia los propone a la veneración de los fieles. Asimismo se describen los estudios monográficos acerca de unos cincuenta siervos de Dios, vene rables, beatos y santos que enriquecen y ennoblecen el santoral capu chino en el más amplio sentido de la palabra. El repertorio tiene un carácter meramente informativo, ni valora- tivo ni selectivo, sino exhaustivo, en cuanto lo consiente la índole de semejantes trabajos. Y puesto que su finalidad prinicipal es la de ofre cer una guía bibliográfica a los futuros hagiógrafos, se ha procurado in 1. -

Ricerche Storiche Salesiane Rivista Semestrale Di Storia Religiosa E Civile
47-RSScop_47-RSScop.qxd 27/11/15 07:26 Pagina 1 2015 - Digital Collections - Biblioteca Don Bosco - Roma - http://digital.biblioteca.unisal.it ISSN 0393-3830 ISTITUTO STORICO SALESIANO FONTI RICERCHE STORICHE Serie prima: Giovanni Bosco. Scritti editi e inediti SALESIANE 1. Giovanni BOSCO, Costituzioni della Società di S. Francesco di Sales [1858] - 1875. RIVISTA SEMESTRALE DI STORIA RELIGIOSA E CIVILE Testi critici a cura di Francesco Motto (= ISS, Fonti, Serie prima, 1). LAS-Roma, 1981, 272 p.(in folio) + 8 tav. € 15,49* 2. Giovanni BOSCO, Costituzioni per l’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice (1872-1885). Testi critici a cura di Cecilia Romero (= ISS, Fonti, Serie prima, 2). LAS-Roma, 1982, 358 p. + 8 tav. f.t. € 10,33 4. Giovanni BOSCO, Memorie dell’Oratorio di S. Francesco di Sales dal 1815 al 1855. In troduzione, note e testo critico a cura di Antonio Ferreira Da Silva (= ISS, Fonti, Serie prima, 4). LAS-Roma, 1991, 255 p. € 10,33 47 ANNO XXIV - N. 2 LUGLIO-DICEMBRE 2005 5. Giovanni BOSCO, Memorie dell’Oratorio di S. Francesco di Sales dal 1815 al 1855. Intro duzione e note a cura di Antonio Ferreira Da Silva (= ISS, Fonti, Serie prima, 5). LAS-Roma, 1991, 236 p. [edizione divulgativa] € 10,33 RICERCHE STORICHE SALESIANE RICERCHE STORICHE 6. Giovanni BOSCO, Epistolario. Vol. I (1835-1863) lett. 1-726. Introduzione, note critiche e storiche a cura di Francesco Motto (= ISS, Fonti, Serie prima, 6). LAS-Roma, 1991, 718 p. € 25,82* 8. Giovanni BOSCO, Epistolario. Vol. II (1864-1868) lett. 727-1263. Introduzione, note critiche e stori che a cura di Francesco Motto (= ISS, Fonti, Serie prima, 8). -

La-Mia-Fede-Nei-Santi-Di-Ogni-Giorno
1 MARTINO CARBOTTI LA MIA FEDE nei Santi di ogni giorno Pugliesi Editore 2 Introduzione Non è assolutamente semplice per me, figlio, delineare la figura di mio padre: Ninuccio Carbotti. Non vi nascondo di averci pensato per molto tempo, dubbioso, circa i tanti aspetti su cui avrei dovuto soffermarmi e una delle domande che mi sono subito posto è stata: ma oltre alla figura di padre modello che io conoscevo, cos'altro conosco della vita di mio padre? E qui ho avuto delle perplessità ..... sì dico perplessità perché tutti i padri presumo hanno un determinato comportamento con i figli, dettato dal ruolo, c'è chi lo fà con più severità e chi meno, chi è pedante e chi meno, chi è accondiscendente e chi meno e via dicendo ma sicuramente tutti si apprestano a svolgere questo compito basilare con uno sconfinato e immenso amore !!! Ma un padre oltre a questo è anche un “uomo”ed è proprio il profilo umano, di uomo tra gli uomini, che mi ha portato ad iniziare questo lavoro, oserei dire di ricerca, esegetico, di tutti gli scritti e archiviazioni varie che con pazienza e passione certosina egli aveva iniziato ed implementato nei vari anni della sua vita. Ho avuto la fortuna di crescere in una famiglia molto unita, sotto tutti gli aspetti. Mio padre apparteneva a quelle belle famiglie di una volta, numerose: erano otto figli, madre, padre e “zizì” a carico (una zia di mia padre, sorella minore di mia nonna, la quale viveva sotto lo stesso tetto a causa di lievi problemi invalidanti) e come tradizione comanda, tutti i figli maschi e dico tutti nessuno escluso, hanno ereditato dal padre l'arte della lavorazione del legno. -

Italian Studies) School of Humanities University of Western Australia 2011
European Languages and Studies (Italian Studies) School of Humanities University of Western Australia 2011 Catholic Women’s Movements in Liberal and Fascist Italy This thesis is presented in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy of the University of Western Australia. Helena Aulikki Dawes BA (Hons) ANU, MA Monash, BEc UWA, GradDipA (Adv) UWA CONTENTS Abbreviations ii Note on Citations iii Preface iv Introduction 1 Chapter One The Italian State, the Catholic Church and Women 7 Chapter Two The Cultural, Political and Ideological Context of femminismo cristiano 56 Chapter Three Femminismo cristiano 88 Chapter Four Elisa Salerno’s Contribution to femminismo cristiano 174 Chapter Five The Conservative Catholic Women’s Movements 237 Conclusion 333 Bibliography 337 i ABBREVIATIONS ACV Archivi ecclesiastici della diocesi (Curia vescovile), Vicenza AEP Archivio Elena da Persico (Fondazione Elena da Persico), Affi, Verona AGOP Fondo Giustiniani Bandini (Archivum generale Ordinis praedicatorum), Rome ARM Archivio Romolo Murri (Fondazione Romolo Murri), Urbino BCB Biblioteca civica bertoliana, Vicenza FAC Fondo Adelaide Coari (Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII), Bologna FES Fondo Elisa Salerno (Centro documentazione e studi “Presenza Donna”), Vicenza ii NOTE ON CITATIONS All citations are presented respecting the original spelling, accentuation, capitalization, punctuation and typefaces. Occasionally changes have been made to paragraphing. iii PREFACE The writing of this thesis has depended on access to published documents and archival material in Italy and Australia. I have been able to rely on the excellent interlibrary loans and reader services of the Reid Library of the University of Western Australia, and I am most grateful to its staff for the assistance and courtesy they have shown to me. -

TERRA DI VILLORBA Storia, Lavoro Ed Ambiente
Adriano Favaro, villorbese trentanovenne, laureato in lettere, si oc- cupa prevalentemente di storia locale, folclore, usi e tradizioni della nostra regione, seguendo con particolare interesse il tema della poe- sia vernacolare veneta a cavallo fra ’700 ed ’800. Collabora da anni con numerose riviste del Veneto ed ha curato di- verse pubblicazioni, fra le quali merita sottolineare «Giorgio Baffo inedito» (C.G.S. 1985 - VE) e «Regata Storica» (Arcari Ed. 1986 - Mogliano Veneto). In copertina: Antico affresco riproducente una scena agreste di virgiliana memoria. Il dipinto è collocato sul muro perimetrale dell’azienda agricola Ancillotto di Fontane, località “Colombera”. ADRIANO FAVARO TERRA DI VILLORBA storia, lavoro ed ambiente COMUNE DI VILLORBA Ringraziamenti: L’autore sente il dovere di rivolgere un rin- graziamento all’Amministrazione Comunale di Villorba ed in particolare un cenno di riconoscenza al conte Antonio Fran- cesco Bullo per gli opportuni suggerimenti e per la benevola assistenza offerta nella stesura della presente opera. “... Bisogna trovare il modo di rallentare al massimo la distru- zione di un mondo in cui siamo nati e vissuti, che ci ha nutrito e potrebbe continuare a nutrirci spiritualmente... ”. Giuseppe Mazzotti SOMMARIO 7 Presentazione del Sindaco di Villorba Luciano Durigon 8 Premessa dell’Autore Adriano Favaro 11 Introduzione 35 Le antiche osterie 49 Villorba 99 Lancenigo 159 Piovenzan 199 Fontane 243 Limbraga 251 Appendice Documenti 257 Appendice Tavole fuori testo 278 Abbreviazioni usate 279 Bibliografia PRESENTAZIONE -

Storia Patria
Renato BORSOTTI iscritto al 4° ginnasio, sez. B. liceo milanese “G. Carducci” (1954) è laure- ato in giurisprudenza. È stato Ufficiale di fanteria, docente, avvocato e magistrato, giornalista pubblicista, conferenziere, letterato e storico. Suoi maestri liceali: Teodoro Ciresòla, grecista di fama, molto conosciuto all’estero per i premi conseguiti al latino “Certamen poeticum Hoeufftianum”, Amsterdam; pluripremiato anche in Italia nei vari RENATO BORSOTTI Certamen, capitolino e vaticano. Paolo Ettore Santangelo, filosofo e storico di vaglia. Elena Fagiolo Paci, docente di scienze naturali, coniuge del filosofo Enzo. Franco Vedovello, storico dell’Arte. Nell’Ateneo del Filarete: Gaetano Scherillo, Diritto romano, Istituzioni e esegesi di storia del diritto romano; Gian Piero Bognetti, Diritto italiano; Antonio Amorth, Diritto amministrativo; Giandomenico Pisapia, Diritto processuale penale e Pietro Nuvolone, Diritto penale sostanziale. Per il tramite della figlia, Maria Teresa, “carducciana” conobbe e frequentò Vittorio Sereni, il grande poeta lombardo del secondo Novecento, che lo indirizzò alla Poesia e alla letteratura. Negli anni ’70 del secolo scorso ha conosciuto e frequentato a Pieve di Soligo il prof. Andrea Zanzotto, il maggior poeta dei nostri anni, amico di Vittorio Sereni, tenuto a “battesimo lirico” da Giuseppe Ungaretti (premio poetico San Babila, 1950). Dopo la scomparsa del poeta, è in contatto ancor oggi con la consorte, prof.ssa e preside Marisa Michieli Zanzotto, ancorché ella viva spesso tra Venezia e Milano. Nella città pievigina, però, ci sono i nipoti, Andrea, come il nonno, e Livia, che l’attraggono. Con Zanzotto frequenta anche il poeta Luciano Cecchinel, erede zanzottiano, chiuso nel suo eremo di Lago (Vittorio Veneto). TRACCE di STORIA PATRIA LETTERATURA 3 Quaderni 2018 Renato BORSOTTI TEODORO MARIO G. -

Pietro Braido, Per Una Storia Dell'educazione Giovanile Nell'oratorio
ISTITUTO STORICO SALESIANO – ROMA STUDI – 30 ISTITUTO STORICO SALESIANO – ROMA STUDI – 30 Pietro Braido Per una storia dell’educazione giovanile nell’oratorio dell’Italia contemporanea L’esperienza salesiana Introduzione di PAOLO ALFIERI Revisione del testo a cura di STANISŁAW ZIMNIAK LAS – ROMA Il disegno sulla copertina è di don Thomas George Savari SDB. © 2018 by LAS - Libreria Ateneo Salesiano Piazza dell’Ateneo Salesiano, 1 - 00139 Roma ISBN 88-213-1320-2 Tipolito: Istituto Salesiano Pio XI - 00181 Roma - Via Umbertide, 11 Tel. 06.78.27.819 - 06.78.48.123 - E-mail: [email protected] Finito di stampare: giugno 2018 Tutta la terra è piena della tua gloria La gloria di Do è l’uomo vivente … Fa’ che io viva o Signore, fa’ che creda al potere del tuo amore! San Ireneo PREFAZIONE Don Bosco è stato, nel Novecento, un vero segno e portatore dell’amore di Dio per i giovani poveri ed abbandonati dell’Oratorio di Valdocco (Torino), per oltre quarant’anni. Il suo amore per i giovani era un amore potente e vivificante. Col passare degli anni il suo oratorio festivo divenne un modello di ciò che il suo vero cuore oratoriano poteva realizzare a favore dei giovani. Da ricercatore costante della volontà di Dio –i suoi sogni potrebbero essere interpretati come il risultato della sua “ossessione” di fare la volontà di Dio – seppe anche leggere i segni dei tempi. Di fatto, era aperto a tutto ciò che assicurasse il bene totale e non solo religioso e morale, dei giovani, ad maiorem dei gloriam. Quindi cercò di fare del suo oratorio un ambiente adatto a sviluppare tutti i loro talenti nascosti, di farli vivere felicemente su questa terra e renderli degni del cielo. -

OPUSCOLI RACCOLTI NELLA BIBLIOTECA CAPITOLARE SCATOLA. Sala 1 Scaff. 1 F 174 1 ADRIANO AUGUSTO MICHIELI CHI FU E COSA FECE RUSTICIANO DA PISA - 1925 - Sala 1 Scaff
OPUSCOLI RACCOLTI NELLA BIBLIOTECA CAPITOLARE SCATOLA. Sala 1 Scaff. 1 F 174 1 ADRIANO AUGUSTO MICHIELI CHI FU E COSA FECE RUSTICIANO DA PISA - 1925 - Sala 1 Scaff. 1 F 174 2 ADRIANO AUGUSTO MICHIELI PER LA STORIA DELLA SOCIETA' DEI XL - 1940 - Sala 1 Scaff. 1 F 174 3 ADRIANO AUGUSTO MICHIELI I LONTANI PRECEDENTI DELLA SISTEMAZIONE DELL'ADIGE - 1940 - Sala 1 Scaff. 1 F 174 4 ADRIANO AUGUSTO MICHIELI IL CANONICO TRIVIGIANO PAOLO APROINO DISCEPOLO ED AMICO DI GALILEI Sala 1 Scaff. 1 F 174 5 ADRIANO AUGUSTO MICHIELI ORAZIO ANTINORI - 1942 - Sala 1 Scaff. 1 F 174 6 ADRIANO AUGUSTO MICHIELI UNA FAMIGLIA DI MATEMATICI E DI POLIGRAFI TRIVIGIANI - IACOPO RICCATI - 1943 - Sala 1 Scaff. 1 F 174 7 ADRIANO AUGUSTO MICHIELI UNA FAMIGLIA DI MATEMATICI E DI POLIGRAFI TRIVIGIANI - VINCENZO RICCATI - 1943 - Sala 1 Scaff. 1 F 174 8 ADRIANO AUGUSTO MICHIELI UNA FAMIGLIA DI MATEMATICI E DI POLIGRAFI TRIVIGIANI - GIORDANO RICCATI - 1943 - Sala 1 Scaff. 1 F 174 9 ADRIANO AUGUSTO MICHIELI UNA FAMIGLIA DI MATEMATICI E DI POLIGRAFI TRIVIGIANI - FRANCESCO RICCATI - 1943 - Sala 1 Scaff. 1 F 174 10 ADRIANO AUGUSTO MICHIELI LA STORIA DI UN CORPO SANTO E UN DONO DEI REZZONICO - 1945 - Sala 1 Scaff. 1 F 174 11 ADRIANO AUGUSTO MICHIELI ANCORA DEL CAN. PAOLO APROINO DELLA SUA GENTE E DELLA COLTURA DEL SUO TEMPO Sala 1 Scaff. 1 F 174 12 ADRIANO AUGUSTO MICHIELI UN GRANDE STUDIOSO DELLA MONTAGNA : QUINTINO SELLA Sala 1 Scaff. 1 F 174 13 ADRIANO AUGUSTO MICHIELI TRE SCIENZATI DA NON SCORDARE Sala 1 Scaff. 1 F 174 14 ADRIANO AUGUSTO MICHIELI UN MAESTRO DI IACOPO RICCATI : STEFANO DEGLI ANGELI Sala 1 Scaff. -

Collectanea Franciscana
ISSN 0010-0749 COLLECTANEA FRANCISCANA ANNUS 88 2018 fasc. 3-4 ROMA – ISTITUTO STORICO DEI CAPPUCCINI Periodico trimestrale, luglio-dicembre 2018 Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2 - DCB – Roma Taxe perçue - Tassa riscossa - Roma - Italia Vol. 88 Collectanea Franciscana Fasc. 3-4 ARTICULI Niklaus Kuster, Eine Franziskusbiografie als Alterswerk: Wie der deutsche Historiker Dieter Berg den Poverello in seiner Zeit beleuchtet ................ 485-506 Aleksander Horowski, Un “Quadragesimale” di Bonaventura da Bagno- regio? ................................................................................................................. 507-679 Riccardo Battiloro, Le origini del Terzo Ordine Regolare di san France- sco al vaglio della storiografia contemporanea ............................................ 681-778 Massimo Vedova, Metamorfosi di un’estasi: san Giuseppe da Copertino e la cupola della Santa Casa di Loreto ............................................................... 779-826 Marianna Iafelice, Il ruolo dei Frati Cappuccini della Provincia di Sant’Angelo nel terremoto che ha colpito San Severo e la Capitanata il 30 luglio 1627 ................................................................................................. 827-846 NOTAE Niklaus Kuster, Oktavian Schmucki (1927-2018): Ein Kapuzinerleben für die franziskanische Forschung ................................................................. 847-870 Gianluca Crudo, Cronaca della Giornata -
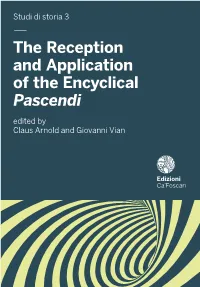
— the Reception and Application of the Encyclical Pascendi Edited by Claus Arnold and Giovanni Vian
Studi di storia 3 — The Reception and Application of the Encyclical Pascendi edited by Claus Arnold and Giovanni Vian Edizioni Ca’Foscari The Reception and Application of the Encyclical Pascendi Studi di storia Collana coordinata da Laura Cerasi Mario Infelise Anna Rapetti 3 Studi di storia Coordinatori Laura Cerasi (Università Ca’ Foscari Venezia, Italia) Mario Infelise (Università Ca’ Foscari Venezia, Italia) Anna Rapetti (Università Ca’ Foscari Venezia, Italia) Comitato scientifico Claus Arnold (Johannes Gutenberg-Universität, Mainz, Deutschland) Marina Caffiero (Università di Roma «La Sapienza», Italia) Giovanni Filoramo (Università degli Studi, Torino, Italia) Marco Fincardi (Università Ca’ Foscari Venezia, Italia) Stefano Gasparri (Università Ca’ Foscari Venezia, Italia) Vincenzo Lavenia (Università degli Studi, Macerata, Italia) Simon Levis Sullam (Università Ca’ Foscari Venezia, Italia) Adelisa Malena (Università Ca’ Foscari Venezia, Italia) Alberto Masoero (Università degli Studi di Genova, Italia) Rolf Petri (Università Ca’ Foscari Venezia, Italia) Giorgio Politi (Università Ca’ Foscari Venezia, Italia) Silvio Pons (Università degli Studi di Roma «Tor Vergata», Italia) Antonella Salomoni (Università della Calabria, Cosenza, Italia) Enzo Traverso (Cornell University, Ithaca, New York, United States) Giovanni Vian (Università Ca’ Foscari Venezia, Italia) Chris Wickham (All Souls College, University of Oxford, United Kingdom) Direzione e redazione Università Ca’ Foscari Venezia Dipartimento di Studi Umanistici Palazzo Malcanton