Circondario Val Di Cornia
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Lista Sezionale LIVORNO
U7050/P13-1 (intercalare) PROVINCIA DI LIVORNO ELEZIONE DI SECONDO GRADO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI LIVORNO 31 ottobre 2018 Elenco n. 1 degli aventi diritto al voto n. 207 elettori LISTA SEZIONALE SEGGIO CENTRALE Palazzo Granducale Piazza del Municipio, 4 - Livorno U7050/P13-1 (intercalare) NUMERO COMUNE COLORE COGNOME , NOME SESSO DATA E LUOGO DI NASCITA D’ORDINE DI APPARTENENZA DELLA SCHEDA 1 Bessi Maria Ida (Sindaco) F 13/04/1961, Capraia Isola (LI) CAPRAIA ISOLA azzurro 2 Cerri Francesco M 13/09/1991, Pisa CAPRAIA ISOLA azzurro 3 Della Rosa Massimiliano M 18/11/1971, Livorno CAPRAIA ISOLA azzurro 4 Garau Alessandro M 19/11/1957, Loceri (NU) CAPRAIA ISOLA azzurro 5 Guarente Tiberio M 01/11/1985, Pisa CAPRAIA ISOLA azzurro 6 Giachini Elena F 04/01/1947, Livorno CAPRAIA ISOLA azzurro 7 Mazzei Fabio M 30/01/1966, Roma CAPRAIA ISOLA azzurro 8 Nugnes Bruno M 31/05/1972, Livorno CAPRAIA ISOLA azzurro 9 Romano Marco M 02/04/1994, Livorno CAPRAIA ISOLA azzurro 10 Vasuino Arturo M 05/12/1955, Taranto CAPRAIA ISOLA azzurro 11 Vito Antonella F 25/08/1968, Livorno CAPRAIA ISOLA azzurro 12 Scalzini Alessandro (Sindaco) M 21/04/1956, Piombino (LI) SASSETTA azzurro 13 Baldassarri Massimo M 27/08/1975, Campiglia Marittima (LI) SASSETTA azzurro 14 Bechelli Marco M 27/09/1975, Piombino (LI) SASSETTA azzurro 15 Bertocci Marco M 11/03/1992, Pisa SASSETTA azzurro 16 Bigoi Angelo M 18/12/1957, Ligonchio (RE) SASSETTA azzurro 17 Cresci Cecilia F 28/02/1985, Cecina (LI) SASSETTA azzurro 18 Leonardi Nicola M 22/03/1982, Pisa SASSETTA azzurro U7050/P13-1 -

International Journal of Earth Sciences
International Journal of Earth Sciences Lateral displacement of a thermally weakened pluton overburden (Campiglia Marittima, Tuscany) --Manuscript Draft-- Manuscript Number: IJES-D-17-00043R1 Full Title: Lateral displacement of a thermally weakened pluton overburden (Campiglia Marittima, Tuscany) Article Type: Original Paper Keywords: Extensional tectonics, Magmatic rocks, Skarn, Mass sliding, Northern Apennines Corresponding Author: Simone Vezzoni, Ph.D. Universita degli Studi di Pisa Pisa, Pisa ITALY Corresponding Author Secondary Information: Corresponding Author's Institution: Universita degli Studi di Pisa Corresponding Author's Secondary Institution: First Author: Simone Vezzoni, Ph.D. First Author Secondary Information: Order of Authors: Simone Vezzoni, Ph.D. Sergio Rocchi Andrea Dini Order of Authors Secondary Information: Funding Information: Abstract: The ascent and emplacement of magmas in the upper crust modify the local pre- existing thermal and rheological settings. Such changes have important effects in producing anomalous structures, mass displacement, rock fracturing, and, in some conditions, hydrothermal mineralizations. In the Campiglia Marittima area, detailed field mapping led to the reconstruction of a local deformation history that overlaps, chronologically and spatially, with regional extension. This local deformation was triggered at the Miocene-Pliocene boundary by the intrusion of a monzogranitic pluton beneath a carbonate sedimentary sequence. The emplacement of the pluton produced a perturbation in the rheological behaviour of the carbonate host rocks, producing transient ductile conditions in the very shallow crust. The carbonate rocks were thermally weakened and flowed laterally, accumulating downslope of the pluton roof, mainly toward the east. As the thermal anomaly was decaying, the brittle-ductile boundary moved progressively back towards the pluton, and large tension gash- shaped volumes of fractured marble were generated. -

Il Comune Settimanale Numero
COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA Il Comune Settimanale n. 512, mercoledì 13 maggio 2020 CENTRO RIABILITAZIONE CAMPIGLIA: IN ATTESA DI RISPOSTE DALL’ASL E DALLA REGIONE Il progetto della Riabilitazione di Campiglia destinato a pazienti Covid-19, sia negativizzati che positivi è proseguito ancora senza il confronto richiesto dalla sindaca di Campiglia. La direzione Asl Toscana Nord Ovest porta avanti il progetto di riabilitazione senza rispondere ai quesiti e alle propo- ste posti dalla sindaca Ticciati. I sinda- cati, che affermano di essere stati an- che loro esclusi da un confronto con l’Azienda, temono per la sicurezza dei lavoratori; la politica è critica su vari fronti. I sindaci della Sds Valli Etrusche (eccetto il sindaco di Cecina) si sentono scavalcati ed esprimono sconcerto in particolare sul metodo. Lunedì 11 mag- gio sono arrivati a Campiglia 4 pazienti Covid positivi per il quali è necessaria la riabilitazione e che hanno tutto il soste- gno e la solidarietà sia della sindaca Ticciati sia di tutti gli altri soggetti in campo contrari, però, al dictat della dire- Nella foto l’ingresso principale del Centro polifunzionale di Campiglia Marittima collo- zione Asl che ha proceduto senza nes- cato dell’ex ospedale, chiuso e riconvertito nell’attuale struttura dopo una lunga fase di progettazione e concertazione con gli Enti locali. suna condivisione. Nel riquadro la sindaca Alberta Ticciati. La cronistoria della vicenda Ripercorriamo velocemente le tappe. I primi di aprile la Asl informa Ticciati di un progetto di riabilitazione per perso- ne guarite dal Coronavirus, con doppio tampone negativo, i protocolli impongono delle cautele e una riorganizzazio- ne temporanea del centro di riabilitazione di Campiglia. -

Piano Strutturale D'area
girondrio2l2di2gorni rovini2di2vivorno ffiio2 rnisti2gomprensorile ino2trutturle2d9re dell2l2di2gorni gomuni2di22gmpigli2wFm22iomino22uvereto vFFF2n°I2del2HQFHIFPHHS ivesyxi2qixievi ivefyey2wyhspsgey2e2iq sy2eggyqvswixy2yiesyxs perio2PHHU INDICE PARTE PRIMA IL QUADRO NORMATIVO E DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 1. Gli orientamenti, gli indirizzi e le determinazioni degli organi decisionali comunali .........3 1.1 L’avvio del procedimento e successiva integrazione ............................................................3 1.2 Il gruppo di lavoro.................................................................................................................6 2. La pianificazione sovraccomunale....................................................................................9 2.1 Il piano di indirizzo territoriale regionale..............................................................................9 2.2 Il piano territoriale di coordinamento provinciale...............................................................16 2.3 I piani di settore...................................................................................................................20 2.3.1 Il piano regionale dei porti e degli approdi turistici .................................................20 2.3.2 Il piano regionale di azione ambientale della toscana 2004-2006............................21 2.3.3 Il piano di tutela delle acque del Bacino “Toscana costa” .......................................26 2.3.4 Il piano dell’ambito territoriale ottimale (Ato) n. 5..................................................29 -

Semi-Automatic Identification and Pre-Screening of Geological–Geotechnical Deformational Processes Using Persistent Scatterer Interferometry Datasets
Article Semi-Automatic Identification and Pre-Screening of Geological–Geotechnical Deformational Processes Using Persistent Scatterer Interferometry Datasets Roberto Tomás 1,*, José Ignacio Pagán 1, José A. Navarro 2, Miguel Cano 1, José Luis Pastor 1, Adrián Riquelme 1, María Cuevas-González 2, Michele Crosetto 2, Anna Barra 2, Oriol Monserrat 2, Juan M. Lopez-Sanchez 3, Alfredo Ramón 4, Salvador Ivorra 1, Matteo Del Soldato 5, Lorenzo Solari 5, Silvia Bianchini 5, Federico Raspini 5, Fabrizio Novali 6, Alessandro Ferretti 6, Mario Costantini 7, Francesco Trillo 7, Gerardo Herrera 8,9 and Nicola Casagli 5 1 Departamento de Ingeniería Civil. Universidad de Alicante, P.O. Box 99, 03080 Alicante, Spain 2 Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC/CERCA), Geomatics Division, Av. Gauss, 7 08860 Castelldefels, Spain 3 Instituto Universitario de Investigación Informática. Universidad de Alicante, P.O. Box 99, 03080 Alicante, Spain 4 Sistema de Información Geográfica de la Universidad de Alicante (SIGUA). Universidad de Alicante, P.O. Box 99, 03080 Alicante, Spain 5 Earth Sciences Department. University of Florence, Via La Pira, 4, 50121 Firenze, Italy 6 TRE-Altamira, Via di Ripa Ticinese, 79, 20143 Milan, Italy 7 e-GEOS—An Italian Space Agency/Telespazio Company, Via Tiburtina, 965, 00156 Rome, Italy 8 Geohazards InSAR Laboratory and Modeling Group, Instituto Geológico y Minero de España (IGME), C/ Alenza 1, 28003 Madrid, Spain 9 Earth Observation and Geohazards Expert Group (EOEG), EuroGeoSurveys, the Geological Surveys of Europe, Rue Joseph II, 36–38, 1000 Brussels, Belgium * Correspondence: [email protected]; Tel.: +34-965-903-400 Received: 24 May 2019; Accepted: 12 July 2019; Published: 14 July 2019 Abstract: This work describes a new procedure aimed to semi-automatically identify clusters of active persistent scatterers and preliminarily associate them with different potential types of deformational processes over wide areas. -

Tiemme Piombino.Csv
DENOMINAZIONE INDIRIZZO COMUNE CAP TABACCHI Nø 4 DI BARLETTANI VIA AURELIA SUD 5 BIBBONA 57020 COSTA TOSCANA INCOMING SRL D LOC.SAN GUIDO N.45 BOLGHERI 57022 BAR LAMPO DI TANI DANIELE LOC. CAMPIGLIA STAZ. INTE CAMPIGLIA MARITTIMA 57021 GIORGERINI GIANCARLO VIA CERRINI 14 - VENTURINA CAMPIGLIA MARITTIMA 57021 BAR 4 STRADE S.N.C. VIA DEI MOLINI N.104 CAMPIGLIA MARITTIMA 57021 EDICOLA E NON SOLO DI FIORENZANI VIA DON STURZO 2-VENTURINA CAMPIGLIA MARITTIMA 57021 TABACCHERIA SANNA DOMENICO VIA INDIPENDENZA 176 CAMPIGLIA MARITTIMA 57021 CARTOLERIA L'ANGOLO DI IEDE VIA INDIPENDENZA N. 167 CAMPIGLIA MARITTIMA 57021 ALIMENTARI COLTIE DI LAFACE VIA LOMBARDIA N. 4 CAMPIGLIA MARITTIMA 57021 LA BRICIOLA DI ROSI LUISA VIA ROMA 13 CAMPIGLIA MARITTIMA 57021 MICHELETTI ARIANNA LOC. COSTA AI MANDORLI N. CASTAGNETO CARDUCCI 57022 TABACCHERIA DI ADRAGNA PAOLA VIA AURELIA 103 - DONORAT CASTAGNETO CARDUCCI 57022 IL COVO DEL GINGILLO DI ZAMPELLI VIA MATTEOTTI 8 - DONORATICO CASTAGNETO CARDUCCI 57022 MICHELETTI ARIANNA VIA VITTORIO EMANUELE II CASTAGNETO CARDUCCI 57022 TABACCHERIA DALLARI ENIO CORSO MATTEOTTI 127 CECINA 57023 CHIOSCO PARDERA CESARE SEDE FISCALE:VIA ARNO 1/B CECINA 57023 ELITE LIVORNO GESTIONI SRL CORSO MATTEOTTI, 8 FIGLINE VALDARNO 50063 BIGLIETTERIA GROSSETO STAZIONE GROSSETO 58100 BEACH BAZAR DI FRANCHINI GRA VIA DELLA CAPRIOLA N. 4/4 LOC.BARATTI - PIOMBINO 57025 NON SOLO BAZAR DI MICHELETTI VIA ITALIA N.22 MARINA DI CASTAGNETO 57022 TABACCHERIA N. 4 DANI NADA PIAZZA CHELI 6 MONTEROTONDO MARITTIMO 58025 TABACCHERIA VENTURI SANDRA VIA 4 NOVEMBRE N.24 MONTEVERDI MARITTIMO 56040 TABACCHERIA N. 1 DI BACCI BA CORSO ITALIA 19 PIOMBINO 57025 CASTALDI CATIA CORSO ITALIA N. -

Comune Di Capoliveri Provincia Di Livorno
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE COMUNE DI CAPOLIVERI PROVINCIA DI LIVORNO C O P I A APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO DI PROGRAMMA SUPERAMENTO DEROGHE Nr. Progr. 69 BORO E ARSENICO Data 29/11/2011 Seduta Nr. 6 Cod. Ente : 049004 L'anno duemilaundici il giorno ventinove del mese di novembre, alle ore 18,00 Solita sala delle Adunanze, regolarmente convocato nei modi di legge, si è riunito in sessione straordinaria il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: presenti assenti BARBETTI RUGGERO X GELSI ANDREA X CARDELLI LEONARDO X DELLA LUCIA CLAUDIO X PUCCINI GABRIELE X MONTAGNA WALTER X CRISPU GABRIELLA X ROTELLINI GABRIELE X LUZZETTI STEFANO X MOROSI MARIO ANGELO X DEIANA BARBARA X PAOLINI GIANLUIGI X DI VITA ALESSANDRO X MARTORELLA FAUSTO X GERI LUCIANO X BALDETTI STEFANO X MARTORELLA GIOVAN BATTISTA X Totale: 14 3 Partecipa alla riunione il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Dott.ssa ROSSI ANTONELLA. In qualità di PRESIDENTE, il Sig. MONTAGNA WALTER assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta. Pagina 1 Esce il Vice Sindaco Andrea Gelsi alle ore 19,20. Illustra il punto all’ordine del giorno l’Assessore Della Lucia. IL CONSIGLIO COMUNALE Visto la Legge regionale 3 Settembre 1996 n.76 “ Disciplina degli Accordi di Programma e delle Conferenze di Servizi” che all’art.3 comma 1 lettera B) prevede la stipula di accordi di programma quando sia necessaria l’azione integrata e coordinata di Regione, EE.LL.,altre amministrazioni ed enti pubblici per la realizzazione di una o più opere, interventi o programmi di intervento; Vista la Direttiva 98/83/CE del 3 novembre 1998 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano ( G.U.C.E 5 Dicembre 1999 n.L330 ); Vista la Direttiva 2000/60/CE del 3 Novembre 1998 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano ( G.U.C.E 5 Dicembre 1999 n.L.330 ); Vista la Direttiva 2006/118/CE del 12 Dicembre 2006 sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento; Visto il Dlgs. -

Reverse Telescoping in a Distal Skarn System
1 Reverse telescoping in a distal skarn system (Campiglia Marittima, Italy) 2 3 Simone Vezzoni*, Dipartimento di Scienze della Terra, Università di Pisa, Via 4 Santa Maria 56 (56126), Pisa, Italy 5 Andrea Dini, Istituto di Geoscienze e Georisorse, CNR, Via Moruzzi 1 (56124), 6 Pisa, Italy 7 Sergio Rocchi, Dipartimento di Scienze della Terra, Università di Pisa, Via Santa 8 Maria 56 (56126), Pisa, Italy 9 10 *corresponding author: e-mail, [email protected] 11 12 Keywords 13 Campiglia Marittima, distal skarn, magmatic rocks, ores, reverse telescoping 14 15 Abstract 16 The Campiglia Marittima Fe-Cu-Zn-Pb(-Ag) skarn deposit has long been regarded 17 as a reference example of an exoskarn showing a symmetric outward mineralogical 18 zoning of both skarn and ore minerals with respect to an axial mafic porphyry dike. 19 Detailed field and underground mapping, along with three-dimensional 20 reconstruction of the geometries of skarn and magmatic bodies, integrated with 21 new petrographic, mineralogical and geochemical data, argue against this model. 22 The shapes of the skarn bodies and the growth versors of skarn minerals in particular, 23 are ascribed to the focusing of metasomatic fluids in sigmoid-shaped volumes of 24 fractured host marble. After skarn formation, a mafic magma was emplaced, 25 forming dikelets and filling residual pockets in the skarn. Field evidence and 26 geochemical data show that the “hot” mafic magma interacted with the previously 27 formed Zn-Pb(-Ag) skarn, triggering textural reworking and chemical redistribution 28 of Zn-Pb sulfides as well as contributing to a late an Fe-Cu mineralization. -
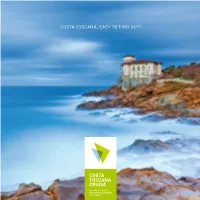
COSTA TOSCANA CRUISE 1 Incoming Projects for the Development of Tourism 2 SUMMARY
COSTA TOSCANA, EasY to FIND OUT! COSTA TOSCANA CRUISE 1 INCOMING PROJECTS FOR THE DEVELOPMENT OF TOURISM 2 SUMMARY 5 LIVORNO: THE PORT FOR TUSCANY 7 Costa TOSCANA CRUISE 13 LIVORNO AND THE GRAND DUCHY OF TUSCANY 27 Bolgheri AND THE WINE ROAD 35 Elba Island AND THE PEARLS OF THE TYRRHENIAN SEA 47 Coast OF THE Etruscans, from THE hilltops to THE SEA 58 FOLKLORE, CUISINE AND CRAFTS 3 4 LIVORNO: THE PORT FOR TUSCANY The port of Livorno is the gateway to the most desirable destinations in Tuscany, a region that offers an endless range of excursions; from artistic cities to medieval villages, with tours of its unparalleled countryside, culture, flavors and good taste. Porto Livorno 2000 operates in the cruise ship and passenger sector in the port of Livorno. It offers a wide range of services where safety and efficiency are the guiding principles; it works in conjunction with local bodies to make the most of local tourist resources. Porto Livorno 2000 manages the Cruise Terminal, the Maritime Passenger Station, information services, car parks and transportation within the Port of Livorno. 5 6 Costa TOSCANA CRUISE The Tuscan Coast has always been an important crossroad for populations and cultures, so it is no surprise that it is a unique treasure trove that has long been famous. The beauty of the countryside and pristine beaches are unparalleled; the picture-postcard views of vineyards and cypresses, archaeological sites, medieval villages, monuments and museums, the gastronomic and wine producing traditions distinguish the entire area, from the hills to the sea, from the coast to the islands. -

The Campiglia Marittima Ore District
Hydrothermal fluid evolution in the "Botro ai Marmi" quartz-monzonitic intrusion (Campiglia Marittima, Tuscany, Italy). Evidence from a fluid inclusion investigation PAOLO FULIGNATI Dipartimento di Scienze della Terra, Università di Pisa - 56126 Pisa, Italy E-mail: [email protected] [Received 25 July 2017; Accepted 15 February 2018; Associate Editor: Katharina Pfaff] Abstract: The quartz-monzonitic intrusion of "Botro ai Marmi" (Tuscany, Italy) can be considered to be a typical example of an intrusion-centered magmatic hydrothermal system. The evolution of hydrothermal fluids in the "Botro ai Marmi" intrusion was investigated using fluid inclusion analyses to provide suitable physico-chemical constraints on the fluids involved in the late- to postmagmatic hydrothermal activity that affected the intrusion, providing inferences on their origin and variations of temperature and pressure with time. This work demonstrates that the earliest fluids circulating in the "Botro ai Marmi" intrusion were high-temperature brines exsolved directly from the crystallizing magma. This fluid circulated in the intrusion under lithostatic conditions (P > 90 MPa, T > 540°C). A second evolutionary stage of the magmatic hydrothermal system is marked by the transition from lithostatic (>90 MPa) to This is a 'preproof' accepted article for Mineralogical Magazine. This version may be subject to change during the production process. DOI: 10.1180/mgm.2018.116. hydrostatic dominated conditions (50 to 10 MPa). In this stage the fluids are also interpreted to be mainly orthomagmatic in origin but unmixed in a high-salinity brine and in a low-salinity vapor aqueous phase, at a temperature ranging from about 500°C to 300°C. -

Comune Di Campiglia Marittima
Comune di Campiglia Marittima Segreteria Generale DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Atto n° 34 del 27/04/2016 OGGETTO: ADEGUAMENTO AL PIANO DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE, DI RECUPERO DELLE AREE ESCAVATE E RIUTILIZZO DEI RESIDUI RECUPERABILI (P.A.E.R.P.). VARIANTE CONTESTUALE AL PIANO STRUTTURALE E AL REGOLAMENTO URBANISTICO. AVVIO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 17 DELLA LRT 65/2014. Il giorno 27/04/2016 alle ore 16:30 nella sede comunale, si riunisce il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, per trattare gli argomenti posti all’ordine del giorno. Presiede l’adunanza il Sindaco Avv. Soffritti Rossana Sono intervenuti i Signori: Presente Assente SOFFRITTI Rossana Sindaco * - BANTI Anna Consigliere * - SICURANI Stefano Consigliere * - FIORENZANI Paolo Consigliere * - PIAZZA Giovanni Consigliere * - GORI David Consigliere * - BORDO Francesco Consigliere * - MACCANTI Debora Consigliere * - LIBERATI Elisa Consigliere * - LELLI Lorenzo Consigliere * - BIMBI Agnese Consigliere - * FIORETTI Daniele Consigliere * - CHESI Cristina Consigliere * - SCAFARO Daniele Consigliere * - PINI Niccolo' Consigliere - * PAZZAGLIA Federico Consigliere - * Assiste Il Segretario Dott.ssa Paradiso Teresa Teodolinda Il Presidente, riconosciuta la validità legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta. Illustra l’argomento il Sindaco; Intervengono i consiglieri Fioretti, Scafaro, Sicurani; Il Sindaco conclude gli interventi; (Il resoconto integrale degli interventi è riportato nel verbale di seduta) IL CONSIGLIO COMUNALE PREMESSO che il Comune di Campiglia M.ma è dotato dei seguenti strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica: il Piano Strutturale d'Area redatto ai sensi dell'art. 17 della LRT n. 01/2005, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 26.03.2007; il Regolamento Urbanistico d'Area redatto ai sensi dell'art. -

Campiglia Marittima - Venturina COSTA DEGLI ETRUSCHI TOSCANA MEDITERRANEA ITALIA
campiglia marittima - venturina COSTA DEGLI ETRUSCHI TOSCANA MEDITERRANEA ITALIA INFORMAZIONI INFORMATION INFORMATIONEN RENSEIGNEMENTS INFORMACIÓNES INFORMAZIONI INFORMATION INFORMATIONEN RENSEIGNEMENTS INFORMACIÓNES INFORMAZIONI INFORMATION INFORMATIONEN RENSEIGNEMENTS INFORMACIÓNES INFORMAZIONI INFORMAZIONI TURISTICHE / TOURIST Il Masseto Loc. Botramarmi, 3 Il Poggetto Via della Fontina, 10 Venturina tel. 339 6849253 Il Vecchio Borgo V. Aurelia Nord, 39 MANEGGI / HORSE - RIDING SCHOOLS / INFORMATION / TOURISTENAUSKUNFT / Palmentello Venturina tel. 0565 846532 Poggetto Venturina tel. 0565 851214 www.poggioaprico.it [email protected] loc. Lumière Venturina tel. 0565 846620 REITSCHULEN / MANÈGES / MANEJOS INFORMATIONS TOURISTIQUES / INFORMACIÓNES www.agriturismomasseto.it www.villapoggetto.it [email protected] Residenza Le Coltie Via Lombardia, 17 Jolly Via Indipendenza, 254 Venturina TURÍSTICAS [email protected] Il Temperino Via di San Vincenzo, 34 Venturina tel. 0565 851292 www.etelam.it tel. 0565 850602 Il Felciaino Via di Cafaggio, 5 Campiglia Marittima Il Piaggione Via delle Lotrine, 1 Venturina Campiglia Marittima tel. 0565 838462 [email protected] Lido e Lida Via Aurelia Nord Loc. Palmentello tel. 0565 838750 Agenzia per il Turismo Costa degli Etruschi tel. 0565 846568 www.ilpiaggione.it La Fucinaia Via di San Vincenzo, 48 Vacanzando Via della Repubblica, 20 Venturina tel. 0565 846532 La Carrozza Via di Cafaggio, 16/a Campiglia Marittima P.zza Cavour, 6 Livorno tel. 0586 204611 [email protected] Campiglia Marittima tel. 0565 838358 Cafaggio Campiglia Marittima tel. 0565 843255 www.costadeglietruschi.it L'Oliveto Via Aurelia Nord, 80 Palmentello www.fucinaia.it [email protected] tel. 0565 843186 www.casavacanzetoscana.eu PARCHI / PARKS / PARKS / PARCS / PARQUES [email protected] Venturina tel. 0565 846534 Letto e Caffé Via Indipendenza, 85 [email protected] TRASPORTI / PUBLIC TRANSPORT / Ufficio Informazioni Via Buozzi www.olivetoagriturismo.it [email protected] Venturina tel.