Scarica Il Documento
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Attitudes Towards the Safeguarding of Minority Languages and Dialects in Modern Italy
ATTITUDES TOWARDS THE SAFEGUARDING OF MINORITY LANGUAGES AND DIALECTS IN MODERN ITALY: The Cases of Sardinia and Sicily Maria Chiara La Sala Submitted in accordance with the requirements for the degree of Doctor of Philosophy The University of Leeds Department of Italian September 2004 This copy has been supplied on the understanding that it is copyright material and that no quotation from the thesis may be published without proper acknowledgement. The candidate confirms that the work submitted is her own and that appropriate credit has been given where reference has been made to the work of others. ABSTRACT The aim of this thesis is to assess attitudes of speakers towards their local or regional variety. Research in the field of sociolinguistics has shown that factors such as gender, age, place of residence, and social status affect linguistic behaviour and perception of local and regional varieties. This thesis consists of three main parts. In the first part the concept of language, minority language, and dialect is discussed; in the second part the official position towards local or regional varieties in Europe and in Italy is considered; in the third part attitudes of speakers towards actions aimed at safeguarding their local or regional varieties are analyzed. The conclusion offers a comparison of the results of the surveys and a discussion on how things may develop in the future. This thesis is carried out within the framework of the discipline of sociolinguistics. ii DEDICATION Ai miei figli Youcef e Amil che mi hanno distolto -

The Differential Object Marking of the Arborense Dialect of Sardinian in Language Contact Setting
journal of language contact 13 (2020) 17-56 brill.com/jlc The Differential Object Marking of The Arborense Dialect of Sardinian in Language Contact Setting Daniela Boeddu Department of Classical Studies, Faculty of Arts, University of the Basque Country, Vitoria-Gasteiz, Spain [email protected] Abstract This paper focuses on the Arborense Differential Object Marking (dom) system, which in line with the typical Sardinian dom system marks the object noun phrases character- ized by a high degree of animacy and specificity with the preposition a. This is why the Sardinian dom is also called prepositional accusative. Authors dealing with other Sar- dinian dialects agree in identifying three domains of distribution of the phenomenon: with personal pronouns and personal names the use of the preposition is mandatory; with inanimate common nouns it is excluded; with common nouns referring animate beings, strong variability occurs. On the basis of an oral corpus of contemporary Arbo- rense, it can be stated that the area of mandatory use of dom is restricted in this dialect and that the optionality area turns out to be more extensive than assumed in tradi- tional descriptions of this Sardinian phenomenon. Since all the Arborense speakers of the oral corpus are bilingual (Sardinian-Italian), the data reflect the situation of dom in a contact setting scenario where Sardinian and both Standard and Regional Italian in- teract. According to Putzu (2005) and Blasco Ferrer and Ingrassia (2010), the extensive area of optionality for the use of the Sardinian dom should be the result of the influence of Standard Italian. However, two facts must be considered that make this idea ques- tionable: first, in the language contact scenario of Modern Sardinian not only Standard Italian but also Regional Italian (with a widespread use of the dom) play a role; second, the synchronic variation observed in contemporary Arborense replicates the same variation which characterizes historical data from texts of the 12th–19th centuries. -

La Sardegna Dalle Origini All'età Vandalica Nell'opera Di Giuseppe Manno
CORE Metadata, citation and similar papers at core.ac.uk Provided by UnissResearch N. 4 – 2005 – Contributi LA SARDEGNA DALLE ORIGINI ALL'ETÀ VANDALICA NELL'OPERA DI GIUSEPPE MANNO ATTILIO MASTINO Università di Sassari I primi due volumi della Storia di Sardegna di Giuseppe Manno[1] comparvero in prima edizione tra il 1825 ed il 1826, in un periodo che precede (ma il discorso vale anche per le edizioni successive tutte uscite prima del 1840) non solo la falsificazione delle Carte di Arborea[2] ma anche le grandi scoperte archeologiche ed epigrafiche del canonico Giovanni Spano, padre dell'archeologia della Sardegna[3] . Da un lato dunque l’opera costituisce un’eccezione nel panorama della produzione dell’Ottocento, per non essere ancora inquinata dal mito delle Pergamente d’Arborea; d’altro lato però si colloca in un periodo in cui non erano stati ancora acquisiti i risultati degli scavi archeologici promossi nell’isola, il che spiega i molti limiti dell’opera, soprattutto per l'età imperiale romana, che non può giovarsi delle indagini topografiche e archeologiche e dell'apporto delle numerose iscrizioni latine anche di carattere pubblico e con riflessi sull'amministrazione provinciale e cittadina, venute alla luce e comunque studiate a partire dalla metà dell'Ottocento ed inserire nel 1883 nel X volume del Corpus Inscriptionum Latinarum[4]. Ma in generale sono evidenti i limiti di una ricerca affrettata, se l’opera fu scritta in sette mesi dal Manno, che non aveva adeguatamente acquisito gli strumenti dell'analisi filologica e la profondità dell'indagine storica, anche se non manca una riflessione pacata, non priva di acume e di ironia, che si differenzia nettamente dalla posizione di tutti gli studiosi precedenti. -

Trasferimenti 2 Grado a S 20 21 Privacy-Signed
BOLLETTINO RISULTATI ELABORATI DAL SISTEMA (CON PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO ANNO SCOLASTICO DI RIFERIMENTO : 2020/21 DATA: 29/06/2020 PROVINCIA: SASSARI PROVI DIST DISTR CLASSE DI CLASSI DI TIPOLOGIA DI NCIA SCUOLA/PROVINCI RETT ETTO CONCORSO/TIPOL CODICE DATA DI MOVIMENTO COMUNE DI PUNTEG TIPO DI ORDINE SCUOLA DI PROVINCIA DI CONCORSO/TIPOL SCUOLA/PROVINCI COMUNE DI PERSONALE COGNOME NOME DI A DI TIPO CATTEDRA O DI PRECEDENZA DI OGIA DI POSTO DI FISCALE NASCITA OTTENUTO DESTINAZIONE GIO MOVIMENTO TITOLARITA' TITOLARITA' OGIA DI POSTO DI A DI TITOLARITA' TITOLARITA' PRIMA DELLA NASCI DESTINAZIONE DEST TITOL DESTINAZIONE TITOLARITA' MOBILITA' TA INAZI ARITA' HH - SOSTEGNO ********** CAPUANO FABIOLA 21/05/1967 NA TRASFERIMENTO NEL SSSD020006 - CATTEDRA I452 - SASSARI 001 Prevista dal C.C.N.I. 366,00 MOVIMENTO A SCUOLA SS HH - SOSTEGNO SSIS00300L - N. I452 - SASSARI 001 TITOLARE SU COMUNE LICEO ARTISTICO - INTERNA DOMANDA SECONDARIA DI II PELLEGRINI SCUOLA FILIPPO FIGARI GRADO SASSARI HH - SOSTEGNO ********** GERANO MARIA CATERINA 23/12/1970 SS TRASFERIMENTO NEL SSSD020006 - CATTEDRA I452 - SASSARI 001 129,00 MOVIMENTO A SCUOLA SS HH - SOSTEGNO SSIS00300L - N. I452 - SASSARI 001 TITOLARE SU COMUNE LICEO ARTISTICO - INTERNA DOMANDA SECONDARIA DI II PELLEGRINI SCUOLA FILIPPO FIGARI GRADO SASSARI HH - SOSTEGNO ********** MOTZO SIMONETTA 09/06/1964 SS TRASFERIMENTO NEL SSPS060006 - LS G. CATTEDRA I452 - SASSARI 001 313,00 MOVIMENTO A SCUOLA SS HH - SOSTEGNO SSRH02000D - I452 - SASSARI 001 TITOLARE SU COMUNE MARCONI INTERNA DOMANDA SECONDARIA DI II IPSAR-IPSEOA SCUOLA GRADO SASSARI HH - SOSTEGNO ********** PONTI ROSA MARIA 28/12/1967 SS TRASFERIMENTO NEL SSPM010006 - CATTEDRA I452 - SASSARI 001 270,00 MOVIMENTO A SCUOLA SS HH - SOSTEGNO SSPS040001 - I452 - SASSARI 001 TITOLARE SU COMUNE MARGHERITA DI INTERNA DOMANDA SECONDARIA DI II GIOVANNI SPANO SCUOLA CASTELVI' GRADO HH - SOSTEGNO ********** AMICO LUCIA 13/05/1978 SS TRASFERIMENTO SSTE01000C - CATTEDRA I452 - SASSARI 001 127,00 MOVIMENTO A SCUOLA SS HH - SOSTEGNO SSIS01600P - IST. -

Convegno a Milano Sulla Figura Del Canonico Giovanni Spano Nel
cultura 14 • Giugno 2004 ltre duecento persone han- Giovanni Pugliese Carratelli (ac- no partecipato nel pome- cademico dei Lincei), Paolo Puli- Origgio di venerdì 28 mag- Convegno a Milano sulla figura na, Grazia Mannironi Lubrano ( gio, a Milano, presso l’Aula Pio archeologa), Tullio De Mauro XI dell’Università Cattolica del (dell’Università “La Sapienza” Sacro Cuore, al convegno di stu- di Roma), Giulio Paulis (del- di su “Il canonico sardo Giovan- del canonico Giovanni Spano l’Università di Cagliari), Mario ni Spano, linguista e archeologo, Segni ( deputato europeo). nel bicentenario della nascita”. Il secondo incontro (Torino, 29 Il convegno è stato organizza- novembre 2003) ha fatto seguito to dalla Federazione delle Asso- nel bicentenario della nascita a due conferenze promosse dai ciazioni Sarde in Italia (FASI) circoli sardi di Livorno e di Ba- come momento conclusivo di Oltre 200 persone al convegno organizzato della FASI reggio-Cornaredo. Nell’occasio- una serie di manifestazioni cele- ne è stato approfondito il fonda- brative del canonico Giovanni all'Università cattolica di Milano mentale contributo di Giovanni Spano, padre delle ricerche lin- Spano alle ricerche archeologi- guistiche e archeologiche appli- zione (a parte, il nostro giornale responsabile del Gruppo Giovani con i più importanti studiosi del- che in Sardegna. cate alla Sardegna, nella ricor- pubblica la sintesi del saggio del del Centro sociale culturale sardo la sua epoca in occasione dei suoi Le relazioni sono state tenute renza del bicentenario della na- presidente Cossiga). Il giornalista di Milano, presieduto da Pieran- numerosi soggiorni nelle città da Paolo Pulina, da Fulvia Lo scita ( Ploaghe, in provincia di sardo-pavese Paolo Pulina, re- gela Abis. -

Necropolis of Sant'andrea Priu ◼ Location of Site
Necropolis of Sant'Andrea Priu ◼ Location of site The archaeological site can easily be reached from Bonorva, about ten kilometres away. On leaving the town, take the provincial road for Bono, and at km 6.8, turn right and take the road that leads to the country church of Santa Lucia. Once past the church, continue for about 500 metres until you reach the necropolis area on the left of the road, run by the local cooperative, Costaval. ◼ History of digs and studies The Sant’Andrea Priu necropolis lies at the foot of the outcrop that borders the Campeda plain, the Mariani hill, that opens towards Goceano, and the Santa Lucia plain. For years, the area of the Santa Lucia plain, full of archaeological findings, was a location for experts, scholars, tomb-robbers and shepherds who used the hypogeum tombs, pillaged since the beginning of time, and turning them into homes for animals and hay stores. In 1834 the abbot Vittorio Angius1 gave a short description of the Tomba del Capo and its frescoes. In 1841, the historian Pietro Martini2 reported the news from a manuscript by the Bishop of Sassari Simon, according to which inside the church of “S. Andrea Frias”, which once belonged to the diocese of Sorra, a small copper vase had been found con- taining some remains and a consecration parchment that dedicated the church to the apostle Andrew in 1303, thanks to the Bishop of Sorres Guantino de Farfara (fig. 1). 1 ANGIUS V., s.v. Bonorva, in Dizionario geografico, storico-statistico-commerciale degli Stati di S.M. -

Le Aquae Calidae Della Sardinia…
Antonio Ibba, Le Aquae calidae della Sardinia… Sylloge Epigraphica Barcinonensis (SEBarc) xv, 2017, pp. 47-68 issn 2013-4118 data de recepció 25.9.2016 data d’acceptació 11.11.2016 Le Aquae calidae della Sardinia The Aquae calidae of Sardinia Antonio Ibba* Riassunto: La Sardegna ha un’importante rete di sorgenti termali, sfruttate sin dall’età preisto- rica e collegate alla viabilità principale. Oltre a una quasi inedita dedica a Venere forse da un impianto termale di Nora, si analizzano le testimonianze dalle terme delle Aquae Ypsitanae, dove si veneravano Esculapio, le Ninfe e Atecina, delle Aquae Lesitanae, legate a Esculapio, delle Aquae Neapolitanae con un numen divinus sanctus, di Maladroxia, forse collegate ad Apollo, Esculapio e Arpocrate, di Flumentepido, S’Acquacotta, di Dorgali e di Casteldoria. Abstract: Sardinia has an important network of hot springs, exploited since prehistoric times and connected to the main roads. Here, apart from an almost little-known dedication to Venus perhaps by a thermal structure from Nora, we analyze the evidence from the baths of Aquae Ypsitanae, where were venerated Asclepius, the Nymphs and Atecina, of Aquae Lesitanae, connected to Asclepius, Aquae Neapolitanae with a numen divinus sanctus, Maladroxia, perhaps linked to Apollo, Asclepius and Harpocrates, Flumentepido, S’Acquacotta, Dorgali and Casteldoria. Parole chiave: Sardegna, acque termali, religione, viabilità Key word: Sardinia, thermal waters, religion, roads Nel 1988 Robert Rowland individuava nella Sardegna romana 34 più 49 proba- bili edifici termali, in 15 casi con molta probabilità associabili a ville rustiche o ad * Università di Sassari, Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali. Il presente contributo riproduce il testo rivisto e corretto di un intervento presentato durante il I Convegno nazionale di studi, Aquae Calidae, le terme degli antichi, svoltosi a Fordongianus (OR) presso il Centro Congressi - Sardegna Grand Hotel Terme il 22 giugno 2012. -

Water-Temples of Sardinia: Identification, Inventory and Interpretation
Department of Archaeology and Ancient History Master's Degree Thesis, 45 credits, 2014 Advisor: Gunnel Ekroth WATER-TEMPLES OF SARDINIA: IDENTIFICATION, INVENTORY AND INTERPRETATION Maud Webster ABSTRACTS Title: Water-temples of Sardinia: Identification, Inventory and Interpretation. Author: Maud Webster 2014. Specification: A two-year master's thesis in Archaeology and Ancient History, Uppsala University. Department Address: Dept. of Archaeology and Ancient History, P.O. Box 626, SE-75126 Uppsala, Sweden. Criteria for identifying prehistoric water-temples among other archaeological remains in Sardinia have not been explicitly discussed so far, making it difficult to investigate this remarkable body of evidence as a whole. This study therefore aims at elaborating a method for identifying water-temples among other fonts and wells in Sardinia, and applying it to produce an inventory. A theoretical discussion of definable criteria for assessing possible cult status in this context precedes an evaluation of the investigable wells and fonts reported in the island. Buildings found to lack cult correlates are noted in an Appendix, while buildings presenting them are inventoried in a Catalogue. A concluding discussion of the results considering spatial, temporal and cultural aspects follows, leading to a new perspective regarding the genesis of the Sardinian water-temples.* Keywords: water-temple, Sardinia, Nuragic, isodomic, cult correlate, sacred well, sacred font, masonry styles Templi ad acqua della Sardegna: identificazione, inventario e interpretazione. Autrice: Maud Webster 2014. Indirizzo del dipartimento: Dip. di Archeologia e Storia antica, C.P. 626, SE-75126 Uppsala, Svezia. Criteri per l'identificazione di templi ad acqua preistorici fra altri residui archeologici in Sardegna non sono stati esplicitamente discussi fin'ora, rendendo difficile l'indagine di questo straordinario insieme di evidenze come tale. -

Convegno a Ozieri Sulle Orme Del Canonico Giovanni Spano
IL MESSAGGERO SARDO 19 NOVEMBRE 2002 ’era grande attesa in Ortueri, 20 anni compiuti il 30 Sardegna e nella comu- TRADIZIONI luglio, che ha esordito nello Cnità dei Sardi in Toscana scorso agosto a Siena correndo e Piemonte per il Palio più an- per il “Bruco”. tico d’Italia, quello che dal Le speranze residue sono 1275 si corre la terza domeni- definitivamente sfumata quan- ca di settembre ad Asti. Ma un I FANTINI SARDI BEFFATI A ASTI do uno dei grandi favoriti, fantino argentino Martin Bal- Massimo Coghe, noto come lestreros, ha messo in fila tutti “Massimino”, è caduto rovino- gli avversari riportando alla DA UN CONCORRENTE ARGENTINO samente nella finalissima. Il vittoria dopo dodici anni il fantino nato 37 anni fa a Nor- rione Tanaro. È stata dunque NEL PALIO PIU' ANTICO D'ITALIA bello, tre volte vincitore a Sie- una giornata amara per i cava- di Giancarlo Ghirra na e altrettante ad Asti (l’ulti- lieri sardi, che si erano presen- tanti, da Vittorio Alfieri a Pao- medioevale e le sue tradizioni, precede la storica corsa in una ma fu nel 2.001), ha tentato di tati in massa alle tre batterie lo Conte, e terra del Palio più insieme a una eccellente qua- città invasa per giorni da ban- riportare al borgo San Paolo il precedenti la finalissima delle antico d’Italia, nato 727 anni lità della vita. Capitale del- diere e stendardi di mille colo- manto di velluto cremisi . Ma 19,15. I vari Coghe, Zedde, fa, quando la città era il libero l’enogastronomia, Asti, nel ri. -

Map 48 Sardinia-Corsica Compiled by S.L
Map 48 Sardinia-Corsica Compiled by S.L. Dyson, 1995 Introduction The ancient geographical information on Sardinia is rich and varied. Moreover, as part of their strategy of controlling the island, the Romans developed a complex network of roads with associated garrisons and way- stations. This complexity is reflected both in the detail of ItAnt, and by the large number of milestones recovered (over 150 to date). Information from classical authors (especially Strabo, Pliny and Ptolemy), the itineraries and inscriptions, together with archaeological remains, allows most locations known from the sources to be identified with reasonable precision. Sardinia also has a long and solid tradition of topographical research, beginning with Ferrero della Marmora (1839). This continued with the researches of Giovanni Spano in the mid to late nineteenth century. The history and archaeology of the island are well summarized in such more recent works as Meloni (1990). It seems clear, however, that its interior saw little in the way of monumental development during Roman times. Even at an important administrative center like Hydata Hypsitana/Forum Traiani (modern Fordongianus), few public or private structures remain. The situation is worse still at smaller centers. Both in Roman times and earlier Sardinia was noted for its mining activity, but so far efforts to locate this with much confidence have largely failed. It is likely that at least some areas mined in modern times were exploited similarly in antiquity, but specific proof remains lacking (cf. Agus 1989). For Corsica, the quantity and quality of the evidence are very different. The Romans made only a limited effort to develop and even control the island. -

1 38 20190408114859.Pdf
Assessoradu de su Turismu, Artesania e Cummèrtziu Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio Elenco soggetti iscritti al Registro Regionale delle Guide Turistiche aggiornato al 05.04.2019 Numero Comune Cognome Nome Luogo di nascita Data di nascita Indirizzo iscrizione residenza 1 Atzeni Maria Graziella Cagliari via S. Lucifero 65 2 Braccu Pina Budoni fraz. Majorca 3 Cannas Matilde Cagliari via Rovereto 10 4 Carboni Dionigi Assemini Assemini 12/03/1953 via Kennedy 27 5 Farris Maria Luisa Cagliari Cagliari 27/08/1950 viale Merello 29 6 Fresu Silvio Cagliari via G. Guglielmo 12 7 Reischer Adelheid Monserrato Innsbruck 06/12/1943 piazza Perù 9 9 Saba Maria Pia Cagliari Villanovafranca 09/10/1951 via Dei Conversi 82 10 Spano Piero 11 Ricci Cristina Olbia Colleferro 16/05/1960 via Pinturicchio 1 12 Beccu Davide Macomer Sassari 11/12/1966 via Luigi Sturzo 14 13 Porcheddu Annarella Cagliari via Acuto 2 14 Bardanzellu Luigi Olbia Olbia 23/02/1958 via Eraclito 34 15 Moro Luciana Sassari via Porcheddu 19 16 Lai Maria Rita Benetutti Benetutti 12/05/1960 via Azuni 5 17 Sugden Hugh Cagliari via Lamarmora 11o 18 Garau Chiara Capoterra San Giovanni Suergiu 25/12/1958 via Gramsci 159 19 Zonno Maria Luisa Cagliari Cagliari 29/09/1966 via Dante 120 20 Vodret Simona Sassari Sassari 08/03/1967 via Olbia 5 21 Busirivici Antonia Laconi via Maggiore 10 22 Marras Maria Antonietta Cagliari via Piccioni 69 23 Cuccu Marina Iglesias via XX settembre 84 24 Sechi Maria Giuseppa Oristano Santu Lussurgiu 05/09/1948 via Enrico Mattei 114 25 Pes Piero Sassari Olbia 22/01/1952 viale Mameli 66 26 Meloni Maria Domenica Olbia Olbia 08/05/1955 via Vincenzo Piro 41 27 Ellis Alison Valerie Cagliari via Dante 93 c/o Laura Mossa Mancini 28 Piras Francesco Sassari Villanova Monteleone 14/09/1958 via De Sena 15 29 Derudas Jeannine Marie Olbia Parigi 31/07/1961 via Enrico Toti 13/A 30 Serventi Maria Carmela Cagliari Giba 06/02/1963 via Monte Sabotino 67 31 Finocchio Maria Mogoro Mogoro 26/07/1967 via F. -
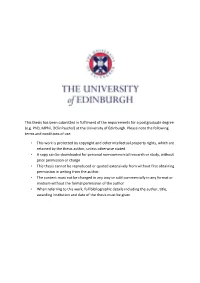
This Thesis Has Been Submitted in Fulfilment of the Requirements for a Postgraduate Degree (E.G
This thesis has been submitted in fulfilment of the requirements for a postgraduate degree (e.g. PhD, MPhil, DClinPsychol) at the University of Edinburgh. Please note the following terms and conditions of use: • This work is protected by copyright and other intellectual property rights, which are retained by the thesis author, unless otherwise stated. • A copy can be downloaded for personal non-commercial research or study, without prior permission or charge. • This thesis cannot be reproduced or quoted extensively from without first obtaining permission in writing from the author. • The content must not be changed in any way or sold commercially in any format or medium without the formal permission of the author. • When referring to this work, full bibliographic details including the author, title, awarding institution and date of the thesis must be given. DE INVENTIO SARDINIÆ THE IDEA OF SARDINIA IN HISTORICAL AND TRAVEL WRITING 1780-1955 Sandro Corso PhD – College of Humanities and Social Sciences THE UNIVERSITY OF EDINBURGH 2010 Edinburgh, 27th December, 2010 This is to declare that the thesis herewith bound, being my own work, has been composed by myself and has not been submitted for any other degree or professional qualification. Sandro Corso 2 ABSTRACT This thesis investigates the way the national identity of Sardinia was perceived in travel literature – and more particularly the way writing about travel experiences contributed to shape identity, both of the visited place and of its inhabitants. The thesis draws from different sources (travelogues, belles lettres, history books); the work reflects therefore a rather eclectic panorama. For obvious reasons the research field has been circumscribed in time and space, but , but aims at drawing general conclusions, i.e.