Relazione Agronomica
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Di Puglia Il Cuore
DI PUGLIA IL CUORE Lorem ipsum C ONSORZI O DI TUTELA VINI DOC CASTEL DEL MONTE 1 Storia della vite e del vino La tradizione vitivinicola millenaria della Puglia è attestata da numerosi do- cumenti e manufatti, alcuni risalenti agli antichi Greci, oggi custoditi nel Museo Nazionale di Palazzo Jatta a Ruvo di Puglia. Già Plinio Il Vecchio e Marziale erano soliti decantare le qualità del vino pugliese, la cui produzio- ne, già molto diffusa, si espanse ulteriormente sotto l’imperatore Federico II di Svevia, con l’introduzione di nuove varietà provenienti dall’oriente. Canne della Battaglia > Dopo l’avvento della fillossera in Francia e in Italia (di cui il Sud rimane inizialmente escluso), la Puglia vive un momento di massi- mo fulgore della viticoltura, con la messa a dimora nella Regione di varietà idonee alla realizzazione di basi alcoliche, diventando così il principale produttore ed esportatore di mosti. Grazie inoltre allo sviluppo di scuole e istituzioni promotrici del rigore scientifico nella vitivinicoltura la Puglia valorizza a pieno il proprio potenziale di territori e varietà di uve. Dalla seconda metà degli anni Settanta si iniziano così a vedere i segni di quel progresso che verrà poi consolidato nei decenni suc- cessivi del secolo scorso, legato alle tre grandi varietà a bacca ros- sa della Regione – il Nero di Troia al nord e nel barese, il Primitivo nell’areale di Manduria e nel Salento e il Negroamaro ancora nel Salento e nel brindisino – e soprattutto a uomini di grande volontà e lungimiranza che hanno saputo rivoluzionare l’enologia pugliese con vini moderni e innovativi. -

“Accoglienza: CUP-Hospitality”
0093196|18/10/2019 |ASL_FG|N_10021|I - Azienda Sanitaria Locale FG Provincia di Foggia Direzione Strategica Via M. Protano s.n.c Foggia Partita IVA e C.F. 03499370710 Tel. 0881884609 Fax 0881884614 AZIENDA SANITARIA LOCALE FG Foggia Progetto “Accoglienza: CUP-Hospitality” Definizione di un nuovo modello di gestione dei servizi di front office attraverso un sistema coordinato di reception e accoglienza Vito Piazzolla Comuni ASL FG: Foggia - Cerignola - Manfredoni - San Severo - Lucera - San Giovanni Rotondo - Orta Nova – Torremaggiore - San Nicandro – Direttore Generale Garganico - San Marco in Lamis – Vieste – Apricena - Monte Sant'Angelo - Vico del Gargano - Troia - Cagnano Varano - CarapelleMattinata – Lesina - Ascoli Satriano - San Paolo di Civitate – Stornara – Stornarella – Ischitella – Carpino – Peschici – Serracapriola - Delicato - Rodi Garganico – Bovino – Zapponata – Biccari - Orsara di Puglia - Poggio Imperiale – Pietramontecorvino – Ordina – Candela – Accadia - Rignano Garganico - Castelluccio dei Sauri - Sant'Agata di Puglia - Casalvecchio di Puglia - Rocchetta - Sant'Antonio – Volturino – Chiesti - Celenza Valfortore - Casalnuovo Monterotaro - Anzano di Puglia - Castelnuovo della Daunia - Castelluccio Valmaggiore - Roseto Valfortore - San Marco la Catola - Monteleone di Puglia - Carlantino - Alberona - Panni - Motta - Montecorvino - Faeto - Volturara Appula - Isole Tremiti - Celle di San Vito Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell' Amministrazione Digitale) e successive modifiche, integrazioni e norme collegate, -

Vino-Rosso-Pugliese.Pdf
Vini Rossi Pugliesi Ebook - www.vinook.it Aleatico di Puglia In questa pagina parleremo di : La Puglia vinicola I vitigni rossi L'Aleatico di Puglia DOC rosso Le aziende La Puglia vinicola L'Aleatico è prodotto in tutta la regione Puglia, che è divisa in otto subregioni geograficamente differenti, con due zone montuose, il Gargano e l'Appennino Dauno, con i loro 1000 metri circa di altitudine; il Tavoliere delle Puglie, la piu grande pianura italiana dopo quella Padana; la zona collinare di origine calcarea delle Murge con caratteristiche carsiche; il Salento con zone collinari e pianeggianti alternate, la Terra di Bari, caratterizzata dal dolci e basse colline e terreni pianeggianti; la Valle dell'Itria, l'Arco Ionico in provincia di Taranto e infine le isole. La regione è a prevalenza calcarea e dolomitica, formata dall'emersione delle terre dalle profondità marine. È da qui che si formò il ricco strato sedimentario di calcare, con presenza di microrganismi fossili che caratterizza il suolo pugliese. Questo lungo processo prevede la formazione di tufo e calcare tenero, che arricchisce gli elementi nutritivi della vite. La regione è divisa esattamente tra zone pianeggianti e zone collinari dolci, mentre le montagne rappresentano meno del 2% del territorio, ubicate al confine con la Campania. Il clima è mediterraneo, con estati lunghe e secche, che concentrano gli elementi presenti nelle uve. Gli inverni sono miti e brevi. I vitigni rossi 2 www.vinook.it I vitigni rossi coltivati per questa denominazione sono l'Aleatico, il Negro Amaro, La Malvasia Nera e il Primitivo. L'Aleatico è conosciuto anche con il nome di Leatico o Agliano ed è una varietà italiana particolare caratterizzata da un forte aroma di Muscat. -

Francesco Violante Organizzazione Del Territorio E Strutture Produttive Tra XI E XVI Secolo
Francesco Violante Organizzazione del territorio e strutture produttive tra XI e XVI secolo [A stampa in Storia di Manfredonia, dir. S. Russo, I, Il Medioevo, a cura di R. Licinio, Edipuglia, Bari 2008, pp. 101-123 © dell’autore e dell’editore - Distribuito in formato digitale da “Reti Medievali”, www.biblioteca.retimedievali.it]. ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO E STRUTTURE PRODUTTIVE TRA XI E XVI SECOLO di Francesco Violante Siponto-Manfredonia: il territorio Nella vicenda storica della città di Siponto e, in seguito, di Manfredonia, un ruolo peculiare e originale svolgono le caratteristiche geo-morfologiche, litologiche e idro- logiche del territorio e le loro dinamiche. Siponto sorgeva infatti sul mare, nell’ansa formata dalla costa pugliese a sud del Gargano, in un territorio costituito in preva- lenza, dal punto di vista geologico e litologico, da calcari di piattaforma risalenti al Cretacico alternati ad argille e calcareniti pleistoceniche e plioceniche e a detriti di falda e depositi alluvionali databili all’Olocene e continuamente accresciuti, in epoca storica, dal corso dei fiumi Candelaro, Cervaro, Carapelle e affluenti minori, attualmente so- pravviventi in forma torrentizia 1. L’evoluzione delle forme insediative e del paesaggio agrario sono state strettamente legate a questa conformazione geofisica. Il progressivo impaludamento dell’insenatura che ospitava Siponto nel corso del XIII secolo, processo definitivamente concluso alla fine del XVI secolo, è dovuto infatti all’azione dei depo- siti alluvionali di corsi d’acqua dotati di una portata maggiore rispetto all’attuale, fe- nomeno probabilmente causato da condizioni climatiche generalmente più calde, mentre il paesaggio agrario si strutturava nelle forme dello sfruttamento cerealicolo- pastorale nelle zone argillose pedemontane e della piana del Tavoliere 2. -

Relazione Archeologica
Allegato 4 Relazione Archeologica Manfredonia Zapponeta (FG) C A S T PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN ELETTRODOTTO ONSHORE PER LA CONNESSIONE DEL PARCO EOLICO MARINO Arte "GARGANO SUD" Storia Archeologia Cooperativa del Territorio del Documento di valutazione archeologica preventiva Committente: Parco Eolico Marino "Gargano Sud" s.r.l. Carta del rischio archeologico: Cast s.c.r.l. Alta sorveglianza: Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia RELAZIONE Ricognizione Archeologica – Manfredonia - Zapponeta (FG) 1 Sommario Introduzione ................................................................................................... 2 Geomorfologia, geologia e idrologia .............................................................. 3 Fonti dei dati .................................................................................................. 6 Metodologia di ricognizione ........................................................................... 7 Analisi bibliografica ...................................................................................... 10 Elenco schede ............................................................................................. 13 Bibliografia generale .................................................................................... 25 Fotointerpretazione e fotorestituzione .......................................................... 30 La ricognizione sul terreno ........................................................................... 32 Schede area di rischio ................................................................................ -

Appendice 1- ZONE DI ALLERTA
Appendice 1: Zone di Allerta Sommario 1. Premessa .................................................................................................. 3 2. Criteri climatici ........................................................................................... 3 2.1 Inquadramento termometrico ................................................................... 4 2.2 Inquadramento pluviometrico ................................................................... 5 3. Criteri geomorfologici ed idrografici ........................................................... 6 3.1 Caratteri geomorfologici ........................................................................... 6 3.2 Bacini idrografici ....................................................................................... 9 3.3 Rilievo del terreno .................................................................................. 10 4. Criteri di Rischio ...................................................................................... 11 5. Criteri amministrativi................................................................................ 12 6. Le zone di allerta della Puglia ................................................................. 13 2 1. Premessa Le zone di allerta definiscono degli ambiti territoriali ritenuti significativamente omogenei per tipologia e severità degli eventi attesi e caratterizzati da risposta meteorologica e/o idrologica omogenea in occasione dell’insorgenza dei fenomeni meteorologici e/o idrologici ( Direttiva PCM del 27/02/2004) . L’individuazione -

44.2 Scheda Fossir ASCOLI SATRIANO
SCHEDA TERRITORIALE ASCOLI SATRIANO (FG) Località Mezzana La Terra Ascoli Satriano (Àsculë in dialetto locale, fino al 1862 chiamata Ascoli) è un comune italiano di 6.188 abitanti della provincia di Foggia in Puglia. Situata nel subappennino dauno, è il quinto comune per superficie nella provincia, l'ottavo in Puglia e trentunesimo in Italia. La città fu un importante centro di origine certamente preromana. I primi abitanti furono i Dauni, popolazione indo-europea giunta via mare dalle sponde illiriche nell'XI secolo a.C. che si mescolò con le preesistenti popolazioni di origine mediterranea. Fu l'antico toponimo Auhuscli - è questa la scritta che compare con lettere greche sulle monete che vi si coniavano tra il IV e il III secolo a.C. che si trasformò nel latino Ausculum è stato ricondotto al termine aus(s), ossia fonte. L'aggettivo Satriano, che la distingue da omonime località italiane, deriva presumibilmente dall'antica Satricum che sorgeva nei pressi. Provincia: Foggia Superficie: 336.68 km² densità abitativa: 6,95 ab/km2 coordinate: 41°12’ 56’’N 15°33’ 28’’E Altitudine: 429 m Area: montuosa/collinare classe sismica: zona 1 (sismicità alta) Frazioni: San Carlo, Palazzo d’ascoli, Corleto, Amendola, Giameria. Aree naturali di rilievo: Sono presenti nel territorio di Ascoli S. diverse pinete, tra queste la più frequentata è quella denominata Cambö Sandö Viëcchiö, inoltre, sulla strada che collega Ascoli ad Orta Nova, si erige la Selva San Giacomo (lu Vuschettö) dove un tempo veniva allestita l'omonima fiera e al cui interno vi è una fontana antica. Territorio: l’abitato sorge a sud-ovest della città di Foggia su un'altura formata da tre colline che dominano la valle del Carapelle, nel Tavoliere delle Puglie. -

Resoconto Dell'escursione Del Gruppo Di Floristica (SBI) Nel 2011 Nel S
INFORMATORE BOTANICO ITALIANO, 46 (2) 175-208, 2014 175 Contributo alla conoscenza floristica della Puglia: resoconto dell’escursione del Gruppo di Floristica (S.B.I.) nel 2011 nel settore meridionale dei Monti della Daunia R.P. WAGENSOMMER, M. MARRESE, E.V. PERRINO, F. BARTOLUCCI, L. CANCELLIERI, F. CARRUGGIO, F. CONTI, R. DI PIETRO, P. FORTINI, G. GALASSO, E. LATTANZI, P. LAVEZZO, D. LONGO, S. PECCENINI, L. ROSATI, G. RUSSO, G. SALERNO, A. SCOPPOLA, A. SOLDANO, A. STINCA, A. TILIA, A. TURCO, P. MEDAGLI, L. FORTE ABSTRACT - Contribution to the floristic knowledge of Apulia: report of the excursion of the “Floristic Group” (Italian Botanical Society) held in 2011 in the southern sector of Daunia Mountains -.The inventory of the taxa collected in Apulia Region during the annual excursion 2011 of the “Floristic Group” of the Italian Botanical Society is presented and dis- cussed. During the excursion 605 entities of 76 different plant families were recorded. 33 taxa are particularly interesting, because they are new or confirmed for Apulia. In detail, 16 taxa are new for Apulia (including 1 allochthonous species), while 6 entities are confirmed for Apulia and 11 species, already known for Apulia, are assigned to a subspecies. Key words: Apulia, new records, vascular flora Ricevuto il 30 Giugno 2014 Accettato l’1 Ottobre 2014 INTRODUZIONE I Monti della Daunia, noti anche come Monti Dauni Daunia sono situati in provincia di Foggia. o Subappennino Dauno, costituiscono una catena Le aree protette ricadenti, almeno in parte, sul montuosa che rappresenta il prolungamento orienta- Subappennino Dauno sono il Parco Naturale le dell’Appennino Sannita, occupando la parte occi- Regionale “Fiume Ofanto”, di complessivi 15.307 dentale della Capitanata, lungo il confine della ettari, e 6 siti della Rete Natura 2000. -

DPP Geologia Foggia
Sindaco Franco LANDELLA Assessorato all’Urbanistica Francesco D’EMILIO Responsabile del Procedimento COMUNE DI ing. Francesco Paolo AFFATATO FOGGIA DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRELIMINARE PUG FOGGIA PROGETTISTA/COORDINATORE prof. arch. Francesco KARRER GRUPPO DI LAVORO _NOTA DI AGGIORNAMENTO arch. Guglielmo BILANZONE DPP ing. Claudio CONVERSANO ALLEGATO_RELAZIONE GEOLOGICA PRELIMINARE arch. Massimo PADRONE prof. avv. Giuseppe DURANO prof. dott. geol. Alessandro REINA dott.ssa Paola LOCHE dott.ssa archeol. Grazia SAVINO ing. Leonardo CHECOLA arch. Sergio PASANISI arch. Alberto QUACQUARINI KARTO-GRAPHIA di Remo Rainone MARZO 2019 PREMESSA 1. CARATTERI GEOLOGICI DEL TERRITORIO COMUNALE DI FOGGIA 1.1 ASPETTI GEOMORFOLOGICI 1.2 IDROGEOLOGIA 2. ADEGUAMENTO AL PPTR 2.1 COMPONENTI IDROLOGICHE 2.2 COMPONENTI GEOMORFOLOGICHE 3. AGGIORNAMENTO CARTA IDROGEOMORFOLOGICA 4. CARTA DELLA PERICOLOSITÀ 5. PROPOSTA DI MICROZONAZIONE DI I LIVELLO 2 PREMESSA Il presente studio geologico del territorio comunale di Foggia ha tra le altre finalità lo studio per le proposte di adeguamento al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale e di aggiornamento della Carta Idrogeomorfologica. In riferimento all’adeguamento del DPP al PPTR lo studio geologico del territorio comunale verificherà la presenza e la definizione aree dei Beni Paesaggistici e degli Ulteriori Contesti riconducibili alla geologia. Attraverso il controllo sul campo saranno stabilite con precisione le componenti geologiche e geomorfologiche che concorrono all’aggiornamento della carta idrogeomorfologica. -
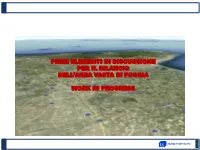
Diapositiva 1
PRIMI ELEMENTI DI DISCUSSIONE PER IL RILANCIO DELL’AREA VASTA DI FOGGIA WORK IN PROGRESS CRESME RICERCHE SPA 1 INQUADRAMENTO CRESME RICERCHE SPA 2 Foggia territorio snodo: la perdita di centralità storica, ma i nuovi corridoi… La collocazione spaziale della città di Foggia, situata in posizione baricentrica nella vasta pianura del Tavoliere delle Puglie, storicamente le assegna un ruolo di cerniera territoriale. Costituisce infatti l’attestamento di antiche direttrici stradali interne provenienti da Molise, Campania e Basilicata, che qui si innestano sul corridoio adriatico verso l’Abruzzo, la Puglia meridionale e la direttrice ionica verso Taranto. Il collegamento con lo storico porto di Manfredonia peraltro, che per la sua collocazione geografica rappresenta uno degli approdi più sicuri dell’Adriatico, garantisce l’accesso alle vie di comunicazione marittima, assegnando al capoluogo dauno una funzione strategica di snodo tra nord e sud, oriente ed occidente, entroterra e mare. Verso la fine degli anni Sessanta, con l’affermazione nel programma di infrastrutturazione autostradale dell’ipotesi di collegamento diretto tra Napoli e Bari ed intersezione della direttrice adriatica all’altezza di Canosa, la città di Foggia ha perso un po’ della sua storica funzione di cerniera territoriale, a vantaggio della città di Bari che invece ha assunto una collocazione sempre più baricentrica. Un sostanziale rilancio dello storico ruolo di cerniera territoriale della città di Foggia verrà tuttavia dalla realizzazione della rete TEN-T (Trans European Network) ed in particolare del corridoio V (Helsinki-Valletta) che prevede la realizzazione di interventi di potenziamento ed adeguamento funzionale della tratte esistenti tra Napoli-Cancello- Dugenta-Benevento-Ariano-Foggia (alcuni già realizzati ed altri in realizzazione, con ultimazione prevista entro il 2016), per la connessione della linea Napoli-Foggia-Bari alla rete europea AV/AC. -

Relazione D.P.P
REGIONE PUGLIA Provincia di Foggia COMUNE DI SAN MARCO LA CATOLA DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRELIMINARE RELAZIONE D.P.P. Il Sindaco sig. Paolo De Martinis Responsabile Ufficio Tecnico geom. Valter Pellegrino Elaborazione P.U.G. e V.A.S. arch. Antonio Marino Geologia, geomorfologia, idrologia dott.ssa geologa Giovanna Cardillo Collaborazione per ricerche e dati ing. Gianluca Marino ing. Armando Liturri Elaborazione disegni geom. Simone Di Canio INDICE PREMESSA ...................................................................................................................................................................... 3 PARTE PRIMA ................................................................................................................................................................ 3 1.1. INDIRIZZI DI PIANIFICAZIONE .............................................................................................................................. 3 1.2. PRINCIPI DEL PIANO URBANISTICO GENERALE ................................................................................................... 5 PARTE SECONDA - SAN MARCO LA CATOLA ALL’INTERNO DELL’AREA VASTA E DEI PIANI SOVRACOMUNALI ........................................................................................................................................................ 7 2.1. AREA VASTA - DOCUMENTO STRATEGICO DELLA REGIONE PUGLIA (DSR) 2007-2013 ...................................... 7 2.2. PO FESR 2007-2013 ........................................................................................................................................... -

Piattaforma Ampelografica Denominazioni E Tipologie Vini ( Codice 9 Caratteri ) Vendemmia 2014
Piattaforma Ampelografica Denominazioni e Tipologie Vini ( Codice 9 caratteri ) Vendemmia 2014 Codice Codice Perc min Perc max Perc min Perc max Base Regione Descrizione tipologia Descrizione varietà Gruppo tipologia varietà singola singola gruppo gruppo ampelografica PUGLIA B124X0092 ALEATICO DI PUGLIA 009 ALEATICO N. 85 100 Prima PUGLIA B124X0092 ALEATICO DI PUGLIA 139 MALVASIA NERA DI BASILICATA N. 0 15 Prima PUGLIA B124X0092 ALEATICO DI PUGLIA 140 MALVASIA NERA DI BRINDISI N. 0 15 Prima PUGLIA B124X0092 ALEATICO DI PUGLIA 141 MALVASIA NERA DI LECCE N. 0 15 Prima PUGLIA B124X0092 ALEATICO DI PUGLIA 163 NEGRO AMARO N. 0 15 Prima PUGLIA B124X0092 ALEATICO DI PUGLIA 199 PRIMITIVO N. 0 15 Prima PUGLIA B213X1633 ALEZIO ROSATO 163 NEGRO AMARO N. 80 100 Prima PUGLIA B213X1633 ALEZIO ROSATO 141 MALVASIA NERA DI LECCE N. 0 20 Prima PUGLIA B213X1633 ALEZIO ROSATO 150 MONTEPULCIANO N. 0 20 Prima PUGLIA B213X1633 ALEZIO ROSATO 218 SANGIOVESE N. 0 20 Prima PUGLIA B213X1632 ALEZIO ROSSO 163 NEGRO AMARO N. 80 100 Prima PUGLIA B213X1632 ALEZIO ROSSO 141 MALVASIA NERA DI LECCE N. 0 20 Prima PUGLIA B213X1632 ALEZIO ROSSO 150 MONTEPULCIANO N. 0 20 Prima PUGLIA B213X1632 ALEZIO ROSSO 218 SANGIOVESE N. 0 20 Prima PUGLIA B432X8881 BARLETTA BIANCO 129 MALVASIA BIANCA B. 60 100 Prima PUGLIA B432X8881 BARLETTA BIANCO 998 VARIETA UVA DA VINO A BACCA BIANCA 0 40 Prima PUGLIA B432X1291 BARLETTA MALVASIA BIANCA 129 MALVASIA BIANCA B. 90 100 Prima Pag.1 di 118 Piattaforma Ampelografica Denominazioni e Tipologie Vini ( Codice 9 caratteri ) Vendemmia 2014 Codice Codice Perc min Perc max Perc min Perc max Base Regione Descrizione tipologia Descrizione varietà Gruppo tipologia varietà singola singola gruppo gruppo ampelografica PUGLIA B432X1291 BARLETTA MALVASIA BIANCA 998 VARIETA UVA DA VINO A BACCA BIANCA 0 10 Prima PUGLIA B432X9993 BARLETTA ROSATO 247 UVA DI TROIA N.