Quaderni Bertinoresi N. 18
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Almanacco N°58
Direttore Nando Odescalchi [email protected] Condirettore Giorgio Boccolari [email protected] Comitato di direzione Nando Bacchi, Antonio Canovi, Maurizio Casini, Giuseppe Catellani, Corrado Corghi, Flavia De Lucis, Carlo De Maria, Mirco Dondi, Alberto Ferraboschi, Marco Fincardi, Alain Goussot, Giuseppe Innocenti, Marzia Maccaferri, Fabrizio Montanari, Massimiliano Panarari, Dino Terenziani, Adolfo Zavaroni Segreteria Rosanna Gandolfi Editore La Nuova Tipolito snc - Felina (RE) Stampa La Nuova Tipolito snc Via Ganapini, 19 - Felina (RE) - Tel. 0522.717428 La rivista esce in fascicoli semestrali. Prezzo: euro 10,00. Abbonamenti annui (Italia e estero): euro 20,00. I manoscritti e/o dattiloscritti, anche se non pubblicati, non verranno restituiti. Sito internet: www.almanaccoreggiano.it Periodico dell’Istituto per la Storia del Movimento Operaio e Socialista «P. Marani» (ISMOS) Sede: Via Roma, 44 - 42042 Fabbrico (RE) Autorizzazione n. 593 del Tribunale di Reggio E. del 12.4.1985 L’almanacco rassegnA di studi storici E di ricerchE Sulla società contemporanea a. XXXI, n. 58 Gennaio - Giugno 2012 Ricerca Storica D. Valisena, Casalgrandesi e scandianesi a Parigi tra le due guerre mondiali ………………………………………………… 7 G. Amaini, Giuditta Sidoli Bellerio e Felicita Bevilacqua La Masa: vite parallele di due donne del Risorgimento ……………………………… 29 M. Del Bue, In ricordo di Antonio Vergnanini ……………………………… 57 G. Catellani, Antonio Vergnanini (Reggio 1861 - Roma 1934) ……………61 R. Testi, Antonio Vergnanini: tra socialismo e cooperazione; tra lavoro, capitale e scienza ………………………………………………71 Materiali Pietro Marani, senatore socialista Commemorazione nel decennale della morte (23 dicembre 1979) Intervento di Sergio Masini ………………………………………………… 119 Testimonianza di Don Prospero Simonelli …………………………… 123 Testimonianza di Corrado Costa ……………………………………… 125 Orazione ufficiale di Luigi Dino Felisetti …………………………… 127 Schede A. -

Staying Dry on Spanish Wine: 2019 the Rejection of the 1905 Spanish-Italian Trade Agreement
STAYING DRY ON SPANISH WINE: 2019 THE REJECTION OF THE 1905 SPANISH-ITALIAN TRADE AGREEMENT Jacopo Timini Documentos de Trabajo N.º 1932 STAYING DRY ON SPANISH WINE: THE REJECTION OF THE 1905 SPANISH-ITALIAN TRADE AGREEMENT STAYING DRY ON SPANISH WINE: THE REJECTION OF THE 1905 SPANISH-ITALIAN TRADE AGREEMENT (*) Jacopo Timini (*) BANCO DE ESPAÑA (*) E-mail: [email protected]. The views expressed in this paper are those of the author and do not necessarily represent the views of Banco de España or the Eurosystem. I would like to thank the editor, Thomas Stratmann, and the anonymous referees for their invaluable inputs. I would like to express my gratitude to Stefano Battilossi, Pilar Nogues-Marco, Giovanni Federico, Brian A’Hearn, Micheal Huberman, and Vicente Pinilla for their comments on early versions of this paper. I would also like to thank Raquel Carrasco, David Chilosi, David De La Croix, Daniel Tirado-Fabregat, Julia Estefania Flores, Rodolfo Campos, Silvia Albrizio, Celia Barroso Gutiérrez, Ángel Estrada, Pedro del Rio and the other participants of the June 2018 Research Seminar at Banco de España, May 2019 IX Iberometrics meeting at University of Alcalá, and the May 2019 Joint Seventh CEPR Economic History Symposium and Fifth Banco de España Economic History Seminar. I wish to acknowledge funding from the People Programme (Marie-Curie Actions) of the European Union’s Seventh Framework Programme FP7/2007-2013 under REA grant agreement no. 608129. All remaining errors are mine. Documentos de Trabajo. N.º 1932 2019 Updated May 2020 The Working Paper Series seeks to disseminate original research in economics and fi nance. -

This Cannot Happen Here Studies of the Niod Institute for War, Holocaust and Genocide Studies
This Cannot Happen Here studies of the niod institute for war, holocaust and genocide studies This niod series covers peer reviewed studies on war, holocaust and genocide in twentieth century societies, covering a broad range of historical approaches including social, economic, political, diplomatic, intellectual and cultural, and focusing on war, mass violence, anti- Semitism, fascism, colonialism, racism, transitional regimes and the legacy and memory of war and crises. board of editors: Madelon de Keizer Conny Kristel Peter Romijn i Ralf Futselaar — Lard, Lice and Longevity. The standard of living in occupied Denmark and the Netherlands 1940-1945 isbn 978 90 5260 253 0 2 Martijn Eickhoff (translated by Peter Mason) — In the Name of Science? P.J.W. Debye and his career in Nazi Germany isbn 978 90 5260 327 8 3 Johan den Hertog & Samuël Kruizinga (eds.) — Caught in the Middle. Neutrals, neutrality, and the First World War isbn 978 90 5260 370 4 4 Jolande Withuis, Annet Mooij (eds.) — The Politics of War Trauma. The aftermath of World War ii in eleven European countries isbn 978 90 5260 371 1 5 Peter Romijn, Giles Scott-Smith, Joes Segal (eds.) — Divided Dreamworlds? The Cultural Cold War in East and West isbn 978 90 8964 436 7 6 Ben Braber — This Cannot Happen Here. Integration and Jewish Resistance in the Netherlands, 1940-1945 isbn 978 90 8964 483 8 This Cannot Happen Here Integration and Jewish Resistance in the Netherlands, 1940-1945 Ben Braber Amsterdam University Press 2013 This book is published in print and online through the online oapen library (www.oapen.org) oapen (Open Access Publishing in European Networks) is a collaborative initiative to develop and implement a sustainable Open Access publication model for academic books in the Humanities and Social Sciences. -

Elenco Dei Governi Italiani
Elenco dei Governi Italiani Questo è un elenco dei Governi Italiani e dei relativi Presidenti del Consiglio dei Ministri. Le Istituzioni in Italia Le istituzioni della Repubblica Italiana Costituzione Parlamento o Camera dei deputati o Senato della Repubblica o Legislature Presidente della Repubblica Governo (categoria) o Consiglio dei Ministri o Presidente del Consiglio dei Ministri o Governi Magistratura Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) Consiglio di Stato Corte dei Conti Governo locale (Suddivisioni) o Regioni o Province o Comuni Corte costituzionale Unione Europea Relazioni internazionali Partiti e politici Leggi e Regolamenti parlamentari Elezioni e Calendario Referendum modifica Categorie: Politica, Diritto e Stato Portale Italia Portale Politica Indice [nascondi] 1 Regno d'Italia 2 Repubblica Italiana 3 Sigle e abbreviazioni 4 Politici con maggior numero di Governi della Repubblica Italiana 5 Voci correlate Regno d'Italia Periodo Nome del Governo Primo Ministro 23 marzo 1861 - 12 giugno 1861 Governo Cavour Camillo Benso Conte di Cavour[1] 12 giugno 1861 - 3 marzo 1862 Governo Ricasoli I Bettino Ricasoli 3 marzo 1862 - 8 dicembre 1862 Governo Rattazzi I Urbano Rattazzi 8 dicembre 1862 - 24 marzo 1863 Governo Farini Luigi Carlo Farini 24 marzo 1863 - 28 settembre 1864 Governo Minghetti I Marco Minghetti 28 settembre 1864 - 31 dicembre Governo La Marmora Alfonso La Marmora 1865 I Governo La Marmora 31 dicembre 1865 - 20 giugno 1866 Alfonso La Marmora II 20 giugno 1866 - 10 aprile 1867 Governo Ricasoli -

Festa Di San Domenico May 2014
IL POSTINO V O L . 15 NO. 8 MAY 2014 :: MAGGIO 2014 $2.00 Festa di San Domenico May 2014 IL POSTINO • OTTAWA, ONTARIO, CANADA Page 2 MAGGIO 2014 IL POSTINO Letters to the Editor 865 Gladstone Avenue, Suite 101 • Ottawa, Ontario K1R 7T4 (613) 567-4532 • information@ilpostinocana Good News for Ottawa www.ilpostinocanada.com Publisher Years ago, when I was the head of for granted and what those who leave In real terms, 2013 saw the City of Preston Street Community Foundation the Canadian Tourism Commission, Ottawa realize quickly: Ottawa has some Ottawa receive $2.4 billion worth of Italian Canadian Community Centre I often ran into former Ottawa resi- of the best tap water in the world. construction applications versus $2 of the National Capital Region Inc. dents who were living abroad. billion in 2012. Building Permits Up Executive Editor Without fail, one of the things that These figures show that Ottawa’s Angelo Filoso always came up when talking about Meanwhile, new statistics show economy is moving along at a strong the things they missed about our city that our economy is continuing to pace and that Ottawa is transforming Managing Editor was our tap water. grow and we see new opportuni- itself for the better. Marcus Filoso ties for job creation in the skilled It sounds like a strange thing to miss trades sector. At City Hall we recognize that growth Layout & Design about a city but it really is true that at this level brings challenges to our Laura Natalia Garcia Ottawa has exceptionally good tap Many think of Ottawa as entirely a city’s infrastructure and our ability water. -

Working Paper Dipartimento Di Economia Pubblica
WORKING PAPER DIPARTIMENTO DI ECONOMIA PUBBLICA Working Paper n. 141 Silvia Fedeli e Francesco Forte A survival analysis of the circulation of the political elites governing Italy from 1861 to 1994 Roma, Aprile 2011 1 Silvia Fedeli and Francesco Forte A survival analysis of the circulation of the political elites governing Italy from 1861 to 1994 Abstract We study the determinants of governments and legislatures’ survival in Italy from the unification to the end of the I Republic (1861-1994) - excluding the fascist period and the subsequent transitory institutional period, "Constituente" (1946-1948). We test whether institutional features such as electoral systems, form of State and extent of suffrage had any effect on the survival of legislatures and governments. We control for voting power of the parliamentary groups, number of parties represented in the parliament and size of the representative bodies. Unlike the political economy wisdom, we show that, over the whole period, governments and legislatures’ survivals are inversely related to the plurality electoral system. The restricted suffrage and a high voting power of the leading parties reduce the risk of anticipated end of governments. The survival of the legislatures is related to the form of state (republic) and to the voting power of the leading party. Universita’ di Roma “La Sapienza” Facolta’ di Economia Dipartimento di Economia e diritto Via del Castro Laurenziano, 9 00161 Roma – Italy E-mail: [email protected] [email protected] Tel. and Fax +39 06 4976 6399 Keywords: Elites; Survival analysis; Electoral systems; Voting power, Political institutions. 2 1. Introduction In this paper we analyze the “struggle for survival” of governments and legislatures of the Italian democratic parliaments, from the creation of the Italian state (1861) up to 1994, with the exclusion of the fascist period (i.e., the legislatures from 1924 to 1945 in which the democratic institutions were absent and of the subsequent transitory institutional period, known as "Constituente", lasting until 1948). -

Portrait of Italian Jewish Life (1800S – 1930S) Edited by Tullia Catalan, Cristiana Facchini Issue N
Portrait of Italian Jewish Life (1800s – 1930s) edited by Tullia Catalan, Cristiana Facchini Issue n. 8, November 2015 QUEST N. 8 - FOCUS QUEST. Issues in Contemporary Jewish History Journal of Fondazione CDEC Editors Michele Sarfatti (Fondazione CDEC, managing editor), Elissa Bemporad (Queens College of the City University of New York), Tullia Catalan (Università di Trieste), Cristiana Facchini (Università Alma Mater, Bologna; Max Weber Kolleg, Erfurt), Marcella Simoni (Università Ca’ Foscari, Venezia), Guri Schwarz (Università di Pisa), Ulrich Wyrwa (Zentrum für Antisemitismusforschung, Berlin). Editorial Assistant Laura Brazzo (Fondazione CDEC) Book Review Editor Dario Miccoli (Università Cà Foscari, Venezia) Editorial Advisory Board Ruth Ben Ghiat (New York University), Paolo Luca Bernardini (Università dell’Insubria), Dominique Bourel (Université de la Sorbonne, Paris), Michael Brenner (Ludwig-Maximilians Universität München), Enzo Campelli (Università La Sapienza di Roma), Francesco Cassata (Università di Genova), David Cesarani z.l. (Royal Holloway College, London), Roberto Della Rocca (DEC, Roma), Lois Dubin (Smith College, Northampton), Jacques Ehrenfreund (Université de Lausanne), Katherine E. Fleming (New York University), Anna Foa (Università La Sapienza di Roma), François Guesnet (University College London), Alessandro Guetta (INALCO, Paris), Stefano Jesurum (Corriere della Sera, Milano), András Kovács (Central European University, Budapest), Fabio Levi (Università degli Studi di Torino), Simon Levis Sullam (Università Ca’ -
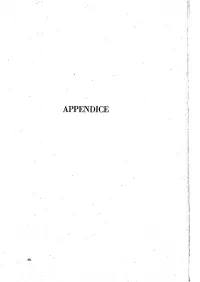
APPENDICE I - ' ' ' -Il
vi APPENDICE I - ' ' ' -il PRESIDENTI DELLA REPUBBLICA ENRICO DE NICOLA, Capo prov visorio dello Stato dal 28 giugno 1946 al 24 giugno 1947 dal 25 giugno al 31 dicembre 1947 ENRICO DE NICOLA, Presidente della Repubblica ; dal 1° gennaio 1948 all'11 maggio 1948 LUIGI EINAUDI, Presidente della Repubblica dall'll maggio 1948 >"..". r ?.-.' V-r^v;*-"^"^ - •«• « ***•••>*• , . :ir.'-.•.:••.• L T • ~ i : ~ . ..' -» "• »-1 -?. ' *- / >^1 • - A •; li ENRICO DE NICOLA 82. • ' ? LUIGI EINAUDI PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI GIOVANNI GRONCHI. dall'8 maggio 1948 PRESIDÈNTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA IVANOE BONOMI dall'8 maggio 1948 GIOVANNI GRONCHI -J-Ì IVANOE BONOMI PRESIDENTI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI DALLA I ALLA XXVI LEGISLATURA VINCENZO GIOBERTI dall'8 maggio al 20 luglio 1848 e dal 16 ott. 30 die. 1848 IL . LORENZO PARETO dal 1° febbr. al 30 marzo 1849 III. LORENZO PARETO dal 30 luglio al 20* nov. 1849 IV . PIER DIONIGI PINELLI dal 20 die. 1849 al 25 aprile 1852 UHBANO RATTAZZI dall'll maggio 1852 al 27 ott. 1853 CARLO BON-COMPAGNI dal 16 al 21 nov. 1853 V ... CARLO BON-COMPAGNI. dal 19 die. 1853 al 16 giugno 1856 CARLO CADORNA.. dal 7 genn. al 16 luglio 1857 VI .. CARLO CADORNA. dal 14 die. 1857 al 14 luglio 1858 URBANO RATTAZZI. dal 10 genn. 1859 al 21 genn. 1860 VII . GIOVANNI LANZA dal 2 aprile al 28 die. 1860 VIII URBANO RATTAZZI. dal 18 febbr. 1861 al 2 marzo 1862 SEBASTIANO TECCHIO dal 22 marzo 1862 al 21 magg. 1863 GIOVANNI BATTISTA CASSINIS dal 25 maggio 1863 al 7 sett. 1865 IX. -

La Partecipazione Delle Donne Al Movimento Cospiratorio Risorgimentale
KWARTALNIK NEOFILOLOGICZNY, LX, 2/2013 GIULIA CILLONI (WARSZAWA) LA PARTECIPAZIONE DELLE DONNE AL MOVIMENTO COSPIRATORIO RISORGIMENTALE A key role in Italy’s unification process was played by the underground Carbonari movement, an organisation which also included women. In this article, I shall present more than just their activ- ity within the organisation, which took on various forms, mainly involving communicating secret information, espionage and propagating revolutionary ideas, or “liquidating” traitors. They carried out the often vital tasks entrusted to them with passion and commitment, with no regard to the risks these exposed them to. Their underground activities are a significant and interesting subject, as this is the first example of women participating in secret societies, and above all of women coming into their own in a national liberation movement. Il presente articolo mira a presentare il movimento cospiratorio dell’epoca risorgimentale in uno dei suoi aspetti meno conosciuti – ovvero la presenza delle donne nelle organizzazioni carbonare e il loro contributo in diverse azioni di carattere insurrezionale e irredentista. Questo lato del Risorgimento costituisce un elemento di primaria importanza, da una parte – per una ricostruzione completa e di conseguenza una migliore comprensione della storia nella sua complessità, dall’altra – in quanto la parteci- pazione delle donne alle cospirazioni risorgimentali, segnando il momento della loro adesione al movimento patriottico e quindi dell’ingresso sulla scena politica (anche se ancora in una forma piuttosto discreta), rappresenta una fase cruciale nella storia del loro lungo cammino verso i diritti e l’emancipazione, poiché proprio questo loro primo rilevante impegno nella causa nazionale darà vita ad un’identità e consapevolezza di cittadinanza, che prima non poteva manifestar- si, data la forte emarginazione delle donne dalla sfera pubblica. -

Italian Leaders of To-Day Helen Zimmern
ITALIAN LEADERS OF TO-DAY HELEN ZIMMERN ITALIAN LEADERS OF TO-DAY H.M. KING VICTOR EMANUEL III. OF ITALY Photo Record Press ITALIAN LEADERS OF TO-DAY BY HELEN ZIMMERN AUTHOR OF 'THE HANSA TOWNS," "ITALY OF THE ITALIANS/ ETC., ETC. WITH SEVEN PORTRAITS LONDON -"j WILLIAMS & NORGATE 14 HENRIETTA STREET, COVENT GARDEN, W.C. FOREWORD As I have repeatedly ventured to assert both in my Italy of the Italians and elsewhere, the Italy of to-day is too little known to the English, despite the fact that they cross her frontier in their thousands every year. They are intimately acquainted with the Italy of the thirteenth, fourteenth, and fif- teenth centuries ; Dante, Botticelli, Michael Angelo, and many a lesser light are familiar as household words. After their day, how- ever, comes a long gap in the traveller's historical knowledge until the names of Mazzini, Garibaldi, and the other heroes of the loom on the horizon Risorgimente ; the intervening centuries are as though they had never existed ! Then comes another blank. Of the men who are shaping the destinies of the Italy of to-day, of the influ- ences which have made her what she is at vi ITALIAN LEADERS OF TO-DAY this great moment of her history, the majority know little or nothing. And yet this should not be, more especially since not only have Italy and England always been friends, bound together by ties of respect and affection, but they are now political allies ; and we trust that once this cruel war is over they may not only remain allies, but become closer friends than ever. -
1 Il Tormentato Avvio Della XVII Legislatura: Le Elezioni Politiche, La
Il tormentato avvio della XVII legislatura: le elezioni politiche, la rielezione del Presidente Napolitano e la formazione del governo Letta di Marco Olivetti (*) SOMMARIO. – 1. Premessa. – 2. Antefatto: l’apertura della crisi. – 2.1. Le dimissioni condizionate del governo Monti: una prassi atipica in via di consolidamento? – 2.2. Le dimissioni del governo Monti, le consultazioni del Presidente della Repubblica e lo scioglimento delle Camere. – 3. I risultati delle elezioni parlamentari del 24 e 25 febbraio 2013. – 4. Tre scenari per la soluzione della crisi. – 5. L’elezione dei presidenti delle due Camere. – 6. Excursus n. 1: l’ipotesi dell’elezione del Presidente del Consiglio Monti alla Presidenza del Senato ed i problemi da essa posti. – 7. L’avvio del procedimento di formazione del governo: le consultazioni del Presidente della Repubblica e il pre-incarico all’on. Bersani – 8. Excursus n. 2: il pre-incarico, la sua differenza dal mandato esplorativo e alcuni suoi profili problematici. – 9. Le «piccole consultazioni» del Presidente del Consiglio pre-incaricato. – 10. Il «congelamento» del tentativo Bersani ed il nuovo giro di consultazioni del Presidente Napolitano. – 11. La sospensione del procedimento di formazione del governo e la nomina di un Comitato di dieci «saggi». – 12. La controversia sulla costituzione delle Commissioni parlamentari. 13. Le dimissioni del Ministro degli Esteri Terzi. – 14. L’elezione del nuovo Presidente della Repubblica. – 14.1. Il contesto politico. – 14.2. Le «Quirinarie» indette dal Movimento Cinque Stelle. – 14.3. I nomi discussi fra i partiti e le candidature di Marini e Rodotà. – 14.4. La candidatura Prodi e il suo fallimento. -

IB History Study Guide
Notum sit universis et singulis, quorum interest aut quomodolibet interesse potest, potest, interesse quomodolibet aut interest quorum singulis, et universis sit Notum postquam a multis annis orta in Imperio Romano dissidia motusque civiles eo usque usque eo civiles motusque dissidia Romano Imperio in orta annis multis a postquam increverunt, ut non modo universam Germaniam, sed et aliquot finitima regna, regna, finitima aliquot et sed Germaniam, universam modo non ut increverunt, potissimum vero Galliam, ita involverint, ut diuturnum et acre exinde natum sit bellum, bellum, sit natum exinde acre et diuturnum ut involverint, ita Galliam, vero potissimum primo quidem inter serenissimum et potentissimum principem ac dominum, dominum dominum dominum, ac principem potentissimum et serenissimum inter quidem primo Ferdinandum II., electum Romanorum imperatorem, semper augustum, Germaniae, Germaniae, augustum, semper imperatorem, Romanorum electum II., Ferdinandum Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae, Sclavoniae regem, archiducem Austriae, Austriae, archiducem regem, Sclavoniae Croatiae, Dalmatiae, Bohemiae, Hungariae, ducem Burgundiae, Brabantiae, Styriae, Carinthiae, Carniolae, marchionem Moraviae, Moraviae, marchionem Carniolae, Carinthiae, Styriae, Brabantiae, Burgundiae, ducem ducem Luxemburgiae, Superioris ac Inferioris Silesiae, Wurtembergae et Teckae, Teckae, et Wurtembergae Silesiae, Inferioris ac Superioris Luxemburgiae, ducem principem Sueviae, comitem Habsburgi, Tyrolis, Kyburgi et Goritiae, marchionem Sacri Sacri marchionem Goritiae,