ZPS “Monti Ausoni E Aurunci” IT6040043
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Prog Salvaguardia E Tutela Del Parco Aurunci
PROGETTO SALVAGUARDIA E TUTELA DEL PARCO DEI MONTI AURUNCI e PARCO DEI MONTI AUSONI E LAGO DI FONDI ALLEGATO 3A - Scheda progetto per l’impiego di operatori volontari in servizio civile in Italia ENTE 1) Denominazione e codice SU dell’ente titolare di iscrizione all’albo SCU proponente il progetto (*) PARCO DEI MONTI AURUNCI SU00204 2) Denominazione e codice SU di eventuali enti di accoglienza dell’ente proponente il progetto ……………………………………… 3) Eventuali enti coprogettanti 3.a) denominazione e codice SU degli enti di accoglienza dell’ente titolare di iscrizione all’albo SCU proponente il progetto ……………………………………………… 3.b) denominazione e codice SU degli enti titolari di iscrizione all’albo SCU ed eventuali propri enti di accoglienza PARCO NATURALE REGIONALE MONTI AUSONI E LAGO DI FONDI - SU00347 Numero N. Sede di attuazione Comune Codice sede Nominativo Olp volontari PARCO AURUNCI Sede centrale Domenico Sepe Uff. serv. CAMPODIMELE 1 171032 2 Marzella Antonio Vigilanza e comunicazione PARCO AURUNCI CAMPODIMELE 2 Sede centrale Domenico Sepe Uff.promozione 171030 1 Tedeschi Antonio PARCO AURUNCI 3 ITRI 171043 2 Ialongo Giampaolo Vivaio del Parco Uff. patrimonio ambientale PARCO AURUNCI Soscia Fulvio 4 ITRI 171041 2 Vivaio del Parco Centro visitatori parco Antonio PARCO AURUNCI Monumento Naturale Settecannelle Mola della 5 FONDI 171019 2 Izzi Fabrizio Corte Uff. educaz. Ambientale PARCO AURUNCI Centro studi De Santis Ufficio promozione- FORMIA 6 171015 2 Buttaro Raffaele archivio dei Monti Aurunci PARCO AURUNCI SPIGNO 7 171020 4 Tarantino Marco Museo Naturalistico SATURNIA PARCO AURUNCI Palazzo Spinelli-Museo del Carsismo(percorso ESPERIA 8 171022 6 Perrella Paolo grotta carsica) 2 PARCO AURUNCI Monticelli Esperia-Uff. -
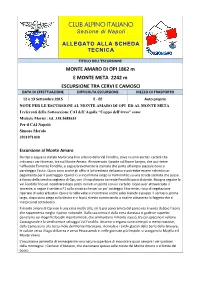
Scheda Escursioni Monte Amaro E Monte Meta
CLUB ALPINO ITALIANO Sezione di Napoli ALLEGATO ALLA SCHEDA TECNICA TITOLO DELL’ESCURSIONE MONTE AMARO DI OPI 1862 m E MONTE META 2242 m ESCURSIONE TRA CERVI E CAMOSCI DATA DI EFFETTUAZIONE DIFFICOLTA ESCURSIONE MEZZO DI TRASPORTO 12 e 13 Settembre 2015 E - EE Auto proprie NOTE PER LE ESCURSIONI AL MONTE AMARO DI OPI ED AL MONTE META I referenti della Sottosezione CAI dell’Aquila “Coppo dell’Orso” sono: Michele Morisi : tel. 338.5688653 Per il CAI Napoli: Simone Merola 3931971038 Escursione al Monte Amaro Da Opi si segue la statale Marsicana fino al bivio della Val Fondillo, dove vi sono anche i cartelli che indicano i vari itinerari, tra cui Monte Amaro. Attraversato il ponte sul fiume Sangro, che qui riceve l’affluente Torrente Fondillo, si segue brevemente la sterrata che porta all’ampio piazzale dove si parcheggia l’auto. Qui ci sono anche gli uffici e la foresteria del parco e potrebbe essere richiesto un pagamento per il parcheggio. Quindi ci si incammina lungo la Val Fondillo su una strada sterrata che passa a fianco della vecchia segheria di Opi, con il limpidissimo torrente Fondillo poco distante. Bisogna seguire la val Fondillo fino ad incontrare dopo pochi minuti un ponte con un cartello. Dopo aver attraversato il torrente, si segue il sentiero F1 sulla sinistra che per un po’ costeggia il torrente, ricco di vegetazione ripariale di salici arbustivi. Qua e là nella valle si incontrano anche salici bianchi e pioppi. Il sentiero, prima largo, dopo poco piega sulla destra e si fa più stretto cominciando a risalire attraverso la faggeta che si inerpica nel sottobosco. -

Abruzzo: Europe’S 2 Greenest Region
en_ambiente&natura:Layout 1 3-09-2008 12:33 Pagina 1 Abruzzo: Europe’s 2 greenest region Gran Sasso e Monti della Laga 6 National Park 12 Majella National Park Abruzzo, Lazio e Molise 20 National Park Sirente-Velino 26 Regional Park Regional Reserves and 30 Oases en_ambiente&natura:Layout 1 3-09-2008 12:33 Pagina 2 ABRUZZO In Abruzzo nature is a protected resource. With a third of its territory set aside as Park, the region not only holds a cultural and civil record for protection of the environment, but also stands as the biggest nature area in Europe: the real green heart of the Mediterranean. en_ambiente&natura:Layout 1 3-09-2008 12:33 Pagina 3 ABRUZZO ITALY 3 Europe’s greenest region In Abruzzo, a third of the territory is set aside in protected areas: three National Parks, a Regional Park and more than 30 Nature Reserves. A visionary and tough decision by those who have made the environment their resource and will project Abruzzo into a major and leading role in “green tourism”. Overall most of this legacy – but not all – is to be found in the mountains, where the landscapes and ecosystems change according to altitude, shifting from typically Mediterranean milieus to outright alpine scenarios, with mugo pine groves and high-altitude steppe. Of all the Apennine regions, Abruzzo is distinctive for its prevalently mountainous nature, with two thirds of its territory found at over 750 metres in altitude.This is due to the unique way that the Apennine develops in its central section, where it continues to proceed along the peninsula’s -

Piccoli Comuni Comunità Montane
La montagna del Lazio: situazione e prospettive A cura di Patrizia Di Fazio MANIFESTO DELLA MONTANITA’ L’Uncem Lazio, il soggetto sindacale, culturale e politico delle Comunità Montane del Lazio, ha svolto una profonda riflessione sul ruolo e sul futuro delle istituzioni locali per fornire, in occasione delle elezioni regionali del 4 marzo p.v., un opportuno apporto alla necessaria riforma del governo delle aree montane ed interne, già in atto a livello nazionale e regionale, ed oggi: 1. Sottolinea la specialità e l’importanza dell’amministrazione delle zone montane del Lazio da cui dipende il welfare di 1.047.116 di cittadini, il 18% dell’intera popolazione e la tenuta territoriale della maggioranza della superficie regionale, 8.928,52 Kmq, il 52% di essa, che 245 Comuni Montani su 378, cioè il 65%, associati in Comunità Montane, difendono, manutengono e promuovono. 2. Indica come compito prioritario quello di depurare la concezione degli enti di gestione territoriale dalle scorie populistiche innescate dai media e da diffusi pregiudizi, in assenza di qualsiasi cognizione ed esperienza sul loro effettivo ruolo istituzionale. 23/02/2018 1 2 3. Afferma che le Comunità Montane del Lazio sono un patrimonio di pluridecennale esperienza amministrativa; di personale politico e funzionale di consolidata professionalità e pronto ad adeguarsi alle nuove sfide; di politiche di crescita create e sviluppate a contatto e prossimità delle popolazioni montane. Tale patrimonio può e deve essere pienamente valorizzato 4. Indica come fondativa, in ossequio all’art.44 della Costituzione, la specialità e peculiarità della Montanità, caratterizzata dai condizionamenti, spesso negativi e talvolta drammatici, che interessano i cittadini che abitano luoghi montani, derivanti dagli agenti atmosferici, dai dissesti idrogeologici, dalle particolari cure e manutenzioni straordinarie, di cui necessitano le infrastrutture viarie, boschive, idriche, commerciali, scolastiche, sanitarie, postali, energetiche, informatiche, sociali, e culturali. -

By Agabus Bipustulatus (Insecta, Coleoptera, Dytiscidae)
Predation on Italian newt larva, Lissotriton italicus (Amphibia, Caudata, Salamandridae), by Agabus bipustulatus (Insecta, Coleoptera, Dytiscidae) LUIGI CORSETTI1 and GIANLUCA NARDI2 1 Via Adige, 45. I-04100 Latina, Italy. 2 Centro Nazionale per lo Studio e la Conservazione della Biodiversità Forestale - Corpo Forestale dello Stato. Strada Mantova, 29. I-46045 Marmirolo (MN), Italy. 2 Author for correspondence: [email protected] ABSTRACT — Predation of a larva of Lissotriton italicus by adults of a diving beetle (Agabus bipustulatus) on the Aurunci Mountains (central Italy, Latium region) is recorded. This is the first identified invertebrate predator of this Italian endemic newt. The possible role of this beetle in the local demographic control of the newt is briefly discussed. HE Italian Newt, Lissotriton italicus (Peracca), (Latina province, Castelforte, Monte Siola W-SW Tpreviously referred to the genus Triturus slope, 240 m a.s.l). No other amphibians occurred (Rafinesque), is endemic to central and southern in the pond, which was probably feebly trickle fed Italy. The northern most limits of its distribution by a very small spring. In this pond about 15 adults include an oblique area extended from the Ancona of a predaceous diving beetle, Agabus bipustulatus province (Marches region) South to Lepini (Linnaeus) (Insecta, Coleoptera, Dytiscidae) were Mountains (Latium region, Rome province), on observed attacking a larva of the Italian Newt. The the Adriatic and Tyrrhenian sides of the Apennines, larva was initially attacked by a single beetle that respectively (Corsetti et al., 2005; Balletto, 2006; was quickly followed by the others and was Scillitani et al., 2006; Scillitani & Tripepi, 2007). devoured, almost completely, in about 10-15 It is a euryoecious species living in a wide range seconds. -

Rifugio Campo Imperatore + Center for Ecotourism and Cultural Creativity
CAMPO IMPERATORE Center for Ecotourism + Cultural Creativity ANALYSIS, RESEARCH AND DESIGN FOR THE REQUALIFICATION OF NEGLECTED SPACES Prepared by Elsa G. De Leon ENVIRONMENT LOCATION Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga Provincia di Terramo Urbino Provincia Marche di Pescara Abruzzo Campo L’Aquila Provincia Imperatore Lazio di Chieti Roma Campo Imperatore Parco Nazionale della Parco Nazionale Provincia Majella dell’Aquila d’Abruzzo ABRUZZO - ITALY. Italian Region. PROVINCIA DELL’AQUILA. Abruzzo Province. GRAN SASSO. National Park. CAMPO IMPERATORE. Alpine meadow. ASCOLIPICENO CULTURAL + VALUES SAN GIACOMO L’ecomuseo di Valle Castellana Ripe Valle Castellana Lago di CEPPO Campotosto L’ecomuseo di Lago di Valle Castellana Campotosto TERAMO AMATRICE CAMPOTOSTO PIETRACAMELA ISOLA DEL GRAN SASSO Arsita Prati di Tivo S. Pietro CAMPO IMPERATORE Museo del Camoscio Orto Botanico Appenninico di San Colombo FONTE VETICA FONTE CERRETO Farindola Arischia Assergi LAGO RACOLLO S. Stefano di Sessanio L’AQUILA Barisciano Calascio PARCO NAZIONALE L’Aquila Centro GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA Visite Fiume Tirino Bussi sul Tirino Historic Center km 0 1 2 3 4 5 km ENVIRONMENTAL + CULTURAL VALUES 150.000 3 5 44 HECTARES REGIONS PROVINCES MUNICIPALITIES BIODIVERSITY AGRO-BIODIVERSITY 51 In danger flora Cereals Solina, Farro Rosso 59 Spontaneous Orchids Legumes Lentils of Santo Stefano di Sessanio 2 Carnivorous plants Vegetables Red Potato Aromatic Plants Tansy, Customary 2364 Register Plants Fruit Trees Apples, figs, Mediterranean hack berry, almonds -

Discovery Marche.Pdf
the MARCHE region Discovering VADEMECUM FOR THE TOURIST OF THE THIRD MILLENNIUM Discovering THE MARCHE REGION MARCHE Italy’s Land of Infinite Discovery the MARCHE region “...For me the Marche is the East, the Orient, the sun that comes at dawn, the light in Urbino in Summer...” Discovering Mario Luzi (Poet, 1914-2005) Overlooking the Adriatic Sea in the centre of Italy, with slightly more than a million and a half inhabitants spread among its five provinces of Ancona, the regional seat, Pesaro and Urbino, Macerata, Fermo and Ascoli Piceno, with just one in four of its municipalities containing more than five thousand residents, the Marche, which has always been Italyʼs “Gateway to the East”, is the countryʼs only region with a plural name. Featuring the mountains of the Apennine chain, which gently slope towards the sea along parallel val- leys, the region is set apart by its rare beauty and noteworthy figures such as Giacomo Leopardi, Raphael, Giovan Battista Pergolesi, Gioachino Rossini, Gaspare Spontini, Father Matteo Ricci and Frederick II, all of whom were born here. This guidebook is meant to acquaint tourists of the third millennium with the most important features of our terri- tory, convincing them to come and visit Marche. Discovering the Marche means taking a path in search of beauty; discovering the Marche means getting to know a land of excellence, close at hand and just waiting to be enjoyed. Discovering the Marche means discovering a region where both culture and the environment are very much a part of the Made in Marche brand. 3 GEOGRAPHY On one side the Apen nines, THE CLIMATE od for beach tourism is July on the other the Adriatic The regionʼs climate is as and August. -

(1990). Lithological Analysis of Material Used for the Sacred Area of Saidu Sharif I (Swat Valley, N.W.F.P., Pakistan) and Their Origins
Claudio Faccenna Curriculum Vitae Publication list 1 Di Florio R., Faccenna C., Lorenzoni S. & Lorenzoni Zanettin E. (1990). Lithological analysis of material used for the sacred area of Saidu Sharif I (Swat Valley, N.W.F.P., Pakistan) and their origins. In"Saidu Sharif I (Swat, Pakistan). The Buddhist sacred area: the stupa terrace - Appendix D-" edito da Faccenna D., Reports and Memoires IsMEO, vol. XXIII.2, 317-340. 2 De Vittorio P., Faccenna C. & Praturlon A. (1991). Monte Velino-Monti della Magnola- Monte Sirente. In Damiani et al. "Elementi litostratigrafici per una sintesi delle facies carbonatiche meso-cenozoiche dell'Appennino centrale". Studi Geologici Camerti, vol. sp. 1991/2, 203-205. 3 Di Florio R., Faccenna C., Lorenzoni S. & Lorenzoni Zanettin E. (1993). Lithological analysis of material used for the sacred area of Panr I (Swat valley, Northern Pakistan) and their origins. In "PanrI, Swat, Pakistan-Appendix D-" edita da Faccenna D., Nabi Khan A. & Nadiem I.H. Reports and Memoires IsMEO, 357-372. 4 De Vittorio P. & Faccenna C. (1990). Ulteriori dati sulla tettonica da thrust presente nell’area Sirente-Magnola. Geologica Romana, vol. XXVI (1987), 287-291. 5 Faccenna C. & Funiciello R. (1993). Tettonica pleistocenica tra il Monte Soratte e i Monti Cornicolani. Il Quaternario, 6 (1), 103-118. 6 Faccenna C., Olivieri L., Lorenzoni S. & Lorenzoni Zanettin E. (1993). Geo-archeology of the Swat Valley (N.W.F.P. Pakistan) in the Charbag-Barikot stretch. Preliminary note. East and West (IsMEO), vol. 41, 1-4, 257-270. 7 Faccenna C., Florindo F., Funiciello R. & Lombardi S. (1993). -

Map 44 Latium-Campania Compiled by N
Map 44 Latium-Campania Compiled by N. Purcell, 1997 Introduction The landscape of central Italy has not been intrinsically stable. The steep slopes of the mountains have been deforested–several times in many cases–with consequent erosion; frane or avalanches remove large tracts of regolith, and doubly obliterate the archaeological record. In the valley-bottoms active streams have deposited and eroded successive layers of fill, sealing and destroying the evidence of settlement in many relatively favored niches. The more extensive lowlands have also seen substantial depositions of alluvial and colluvial material; the coasts have been exposed to erosion, aggradation and occasional tectonic deformation, or–spectacularly in the Bay of Naples– alternating collapse and re-elevation (“bradyseism”) at a staggeringly rapid pace. Earthquakes everywhere have accelerated the rate of change; vulcanicity in Campania has several times transformed substantial tracts of landscape beyond recognition–and reconstruction (thus no attempt is made here to re-create the contours of any of the sometimes very different forerunners of today’s Mt. Vesuvius). To this instability must be added the effect of intensive and continuous intervention by humanity. Episodes of depopulation in the Italian peninsula have arguably been neither prolonged nor pronounced within the timespan of the map and beyond. Even so, over the centuries the settlement pattern has been more than usually mutable, which has tended to obscure or damage the archaeological record. More archaeological evidence has emerged as modern urbanization spreads; but even more has been destroyed. What is available to the historical cartographer varies in quality from area to area in surprising ways. -

RGZM – Tagungen 34 (Mainz 2018)
Römisch-Germanisches Zentralmuseum Leibniz-Forschungsinstitut für Archäologie OFFPRINT RGZM – TAGUNGEN Band 34 zugleich INTERDISZIPLINÄRE FORSCHUNGEN zu den Häfen von der Römischen Kaiserzeit bis zum Mittelalter in Europa Band 5 Herausgegeben von Claus von Carnap-Bornheim, Falko Daim, Peter Ettel und Ursula Warnke Claus von Carnap-Bornheim · Falko Daim Peter Ettel · Ursula Warnke (eds) HARBOURS AS OBJECTS OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH – ARCHAEOLOGY + HISTORY + GEOSCIENCES International Conference »Harbours as objects of interdisciplinary research – Archaeology + History + Geosciences« at the Christian-Albrechts-University in Kiel, 30.9.-3.10.2015, within the framework of the Special Research Program- me (DFG-SPP 1630) »Harbours from the Roman Period to the Middle Ages« Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz 2018 Die Tagung wurde gefördert von der Redaktion: Ilka Elisabeth Rau (ZBSA), Nina Marschler (Duisburg), Claudia Nickel, Marie Röder (RGZM) Englisches Lektorat: Ilka Elisabeth Rau (ZBSA), Wilson Huntley (Göttingen) Satz: Dieter Imhäuser, Hofheim a. T. Bildbearbeitung: Manfred Albert (RGZM) Umschlaggestaltung: Claudia Nickel (RGZM) Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie: Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. ISBN 978-3-88467-293-8 ISSN 1862-4812 © 2018 Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, der Entnahme von Abbildungen, der Funk- und Fernsehsendung, der Wiedergabe auf fotomechanischem (Fotokopie, Microkopie) oder ähnlichem Wege und der Speicherung in Datenverarbeitungs- anlagen, Ton- und Bildträgern bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Die Vergütungsansprüche des §54, Abs.2, UrhG. werden durch die Verwertungsgesellschaft Wort wahrgenommen. Druck: johnen-druck GmbH & Co. -

S Italy Is a Contracting Party to All of the International Conventions a Threat to Some Wetland Ibas (Figure 3)
Important Bird Areas in Europe – Italy ■ ITALY FABIO CASALE, UMBERTO GALLO-ORSI AND VINCENZO RIZZI Gargano National Park (IBA 129), a mountainous promontory along the Adriatic coast important for breeding raptors and some open- country species. (PHOTO: ALBERTO NARDI/NHPA) GENERAL INTRODUCTION abandonment in marginal areas in recent years (ISTAT 1991). In the lowlands, agriculture is very intensive and devoted mainly to Italy covers a land area of 301,302 km² (including the large islands arable monoculture (maize, wheat and rice being the three major of Sicily and Sardinia), and in 1991 had a population of 56.7 million, crops), while in the hills and mountains traditional, and less resulting in an average density of c.188 persons per km² (ISTAT intensive agriculture is still practised although land abandonment 1991). Plains cover 23% of the country and are mainly concentrated is spreading. in the north (Po valley), along the coasts, and in the Puglia region, A total of 192 Important Bird Areas (IBAs) are listed in the while mountains and hilly areas cover 35% and 41% of the land present inventory (Table 1, Map 1), covering a total area of respectively. 46,270 km², equivalent to c.15% of the national land area. This The climate varies considerably with latitude. In the south it is compares with 140 IBAs identified in Italy in the previous pan- warm temperate, with almost no rain in summer, but the north is European IBA inventory (Grimmett and Jones 1989; LIPU 1992), cool temperate, often experiencing snow and freezing temperatures covering some 35,100 km². -

Ente Parco Naturale Regionale Monti Ausoni E Lago Di Fondi Via Cavour N
Ente Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi DIREZIONE CAPITALE NATURALE PARCHI E AREE PROTETTE Il Direttore Oggetto: Proroga termine di scadenza di presentazione della domanda per partecipare all’Avviso pubblico “VIVI NEL PARCO L'ESTATE 2021” Con riferimento all’Avviso in oggetto, approvato con Deliberazione n. 18 del 22.04.2021 e pubblicato con Determinazione Dirigenziale n. 66 del 29.04.2021, finalizzato a stimolare le realtà associazionistiche così come altri soggetti, per avanzare proposte per un programma di eventi e attività da realizzare nei Comuni delle aree protette gestite dall’Ente Parco, vale a dire il Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi, la Riserva Naturale Regionale Città di Fregellæ, Fabrateria Nova e Lago di S. Giovanni Incarico e la Riserva Naturale Regionale Lago di Canterno; preso atto delle numerose richieste di informazioni pervenute da parte dei soggetti interessati; ritenuto opportuno e necessario ampliare i termini per la presentazione delle proposte e dei progetti al fine di favorire una sempre maggiore partecipazione; con la presente si comunica che il termine di scadenza di presentazione della domanda e dei suoi allegati, relativo all’Avviso Pubblico “VIVI NEL PARCO L'ESTATE 2021”, è prorogato entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 19 maggio 2021, nel rispetto delle modalità già indicate nel suddetto Avviso. Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione relativi al presente Avviso, è possibile contattare l’Ente Parco all’indirizzo e-mail [email protected] oppure [email protected] (Responsabile del procedimento: Giovanni Persichetti), [email protected] (collaboratore del Responsabile del procedimento: Gabriella Tiribelli).