Regione Lazio
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
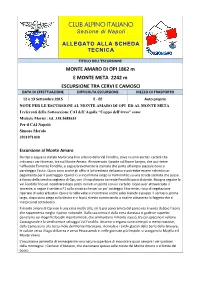
Scheda Escursioni Monte Amaro E Monte Meta
CLUB ALPINO ITALIANO Sezione di Napoli ALLEGATO ALLA SCHEDA TECNICA TITOLO DELL’ESCURSIONE MONTE AMARO DI OPI 1862 m E MONTE META 2242 m ESCURSIONE TRA CERVI E CAMOSCI DATA DI EFFETTUAZIONE DIFFICOLTA ESCURSIONE MEZZO DI TRASPORTO 12 e 13 Settembre 2015 E - EE Auto proprie NOTE PER LE ESCURSIONI AL MONTE AMARO DI OPI ED AL MONTE META I referenti della Sottosezione CAI dell’Aquila “Coppo dell’Orso” sono: Michele Morisi : tel. 338.5688653 Per il CAI Napoli: Simone Merola 3931971038 Escursione al Monte Amaro Da Opi si segue la statale Marsicana fino al bivio della Val Fondillo, dove vi sono anche i cartelli che indicano i vari itinerari, tra cui Monte Amaro. Attraversato il ponte sul fiume Sangro, che qui riceve l’affluente Torrente Fondillo, si segue brevemente la sterrata che porta all’ampio piazzale dove si parcheggia l’auto. Qui ci sono anche gli uffici e la foresteria del parco e potrebbe essere richiesto un pagamento per il parcheggio. Quindi ci si incammina lungo la Val Fondillo su una strada sterrata che passa a fianco della vecchia segheria di Opi, con il limpidissimo torrente Fondillo poco distante. Bisogna seguire la val Fondillo fino ad incontrare dopo pochi minuti un ponte con un cartello. Dopo aver attraversato il torrente, si segue il sentiero F1 sulla sinistra che per un po’ costeggia il torrente, ricco di vegetazione ripariale di salici arbustivi. Qua e là nella valle si incontrano anche salici bianchi e pioppi. Il sentiero, prima largo, dopo poco piega sulla destra e si fa più stretto cominciando a risalire attraverso la faggeta che si inerpica nel sottobosco. -

Boll. Soc. Entomol. 142-3-2 30-11-2010 10:51 Pagina 111
Boll. Soc. Entomol. 142-3-2 30-11-2010 10:51 Pagina 111 BOLL. SOC. ENTOMOL. ITAL., 142 (3): 111-120 30 NOVEMBRE 2010 Paolo NERI & Augusto VIGNA TAGLIANTI Note su Ocydromus alticola e O. incognitus, con descrizione di una nuova razza di O. alticola dei Monti della Laga, Appennino Centrale (Coleoptera Carabidae) Riassunto - Vengono discussi alcuni aspetti tassonomici e nomenclatoriali del genere Ocydromus Clairville, 1806, con particolare ri- ferimento alle specie italiane del “Gruppe des nitidulum” sensu Netolitzky (1943), Ocydromus alticola (A. Fiori, 1903) e O. incognitus (G. Müller, 1931), che presentano il medesimo schema di struttura dell’endofallo e che vengono assegnate al sottogenere Peryphus De- jean, 1821. Viene presentato uno schema di confronto tra la terminologia qui utilizzata e quelle adottate dai precedenti autori nella descrizione delle medesime strutture dell’endofallo dei vari sottogeneri. Viene infine descritto Ocydromus (Peryphus) alticola lagae n. ssp. dei Monti della Laga (Appennino Centrale), che differisce dalla forma tipica di Maiella, Monti della Meta, Marsicano e Greco per le antenne scure, la forma del pronoto, la microscultura e punteggiatura elitrale e la forma del lobo mediano dell’edeago. Abstract - Notes on Ocydromus alticola and O. incognitus, with description of a new subspecies of O. alticola from Monti della Laga, Central Apennine (Coleoptera Carabidae). Some taxonomical and nomenclatorial problems concerning the genus Ocydromus Clairville, 1806 are discussed with particular ref- erence to which subgenus the italian species of the “Gruppe des nitidulum” sensu Netolitzky (1943) are to be referred to. Ocydromus incognitus (G. Müller, 1931) and Ocydromus alticola (A. Fiori, 1903), characterized by a similar morphology of the endophallus, are included in the subgenus Peryphus Dejean, 1821. -

Sistema Geografico Della Montagna Del Lazio
Enti Locali e Politiche per la Sicurezza EIM Ente Italiano della Montagna SISTEMA GEOGRAFICO DELLA MONTAGNA DEL LAZIO POLITICHE, ECONOMIA E TERRITORIO I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi. Coordinatore della ricerca: Stefano Pignotti Gruppo di ricerca: Chiara Finocchietti Clelia Losavio Vincenzo Bonanno Alessandro Cinnirella Luigi Falco Pier Paolo Poncia REGIONE LAZIO Direzione Regionale Enti locali Software sviluppato in collaborazione con e Politiche per la Sicurezza SI2G S.r.l., spin-off company Via Rosa R. Garibaldi, 7 Università Politecnica delle Marche, Ancona 00145 ROMA Grafica: UNCEM Cliccaquì sas Delegazione regionale del Lazio Viale Castro Pretorio, 116 Elaborazione cartografica e stampa: 00185 ROMA SystemCart srl EIM Ente Italiano della Montagna Si ringraziano Rosanna Farina per l’attività di rendicontazione Piazza dei Caprettari, 70 finanziaria del progetto e Alessandra Cupelli per la revisione del 00186 ROMA testo. SISTEMA GEOGRAFICO DELLA MONTAGNA DEL LAZIO ono molto felice di poter scrivere la prefazione alla pub- blicazione “Sistema Geografico della Montagna del S Lazio. Politiche, economia e territorio”, che raccoglie i frutti di un lavoro pluriennale condotto da un’équipe di ricerca- tori dell’Ente Italiano della Montagna. Questo volume, oltre a fornire scenari interessanti e in parte inediti relativi alla composizione fisica, socio-economica, e di accessibilità delle aree montane del Lazio, offre anche una ricognizione delle possibilità offerte dalla programmazione comunitaria, opportunità in gran parte ancora da scoprire e da utilizzare per rispondere ai tanti bisogni di questa splendida parte del territorio della Regione Lazio. -

Nigritella Widderi (Orchidaceae-Orchideae) in the Apennines
ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Phyton, Annales Rei Botanicae, Horn Jahr/Year: 1987 Band/Volume: 27_1 Autor(en)/Author(s): Rossi Walter, Capineri Romano, Teppner Herwig, Klein Erich Artikel/Article: Nigritella widderi (Orchidaceae-Orchideae) in the Apennines. 129-138 ©Verlag Ferdinand Berger & Söhne Ges.m.b.H., Horn, Austria, download unter www.biologiezentrum.at Phyton (Austria) Vol. 27 Fasc. 1 129-138 17. 7. 1987 Nigritella widderi (Orchidaceae - Orchideae) in the Apennines By 1 Walter Rossi ), Romano CAPINERI2), Herwig TEPPNER3) and Erich KLEIN4) With 10 Figures Received July, 13, 1986 Key words: Nigritella widderi, Orchidaceae. - Apomixis, chromosome number, embryology. - Flora of Italy. Summary Rossi W., CAPINERI R., TEPPNER H. & KLEIN E. 1987. Nigritella widderi (Or- chidaceae - Orchideae) in the Apennines. - Phyton (Austria) 27 (1): 129-138, 10 figu- res. - English with German summary. The Nigritella of Central Italy was identified as conspecific with N. widderi TEPPNER & KLEIN from the Northeastern Alps. It occurs in mountains of the region Abruzzo and in adjacent parts of neighbouring regions. Distribution in Italy, karyolo- gy (chromosome number 2n = 80) and embryology (apomixis, nucellar embryos) are discussed. [ Zusammenfassung Rossi W., CAPINERI R., TEPPNER H. & KLEIN E. 1987. Nigritella widderi (Orchida- ceae - Orchideae) im Apennin. - Phyton (Austria) 27 (1): 129-138, 10 Abbildungen. - Englisch mit deutscher Zusammenfassung. Die Nigritella Zentral-Italiens wird zu der aus den nordöstlichen Alpen be- schriebenen JV. widderi TEPPNER & KLEIN gestellt. Sie kommt im Apennin in der Region Abruzzo und in angrenzenden Teilen benachbarter Regionen vor. Die Verbrei- tung in Italien, Karyologie (Chromosomenzahl 2n = 80) und Embryologie (Apomixis, Nuzellarembryonen) werden diskutiert. -

Rapaci Lazio
ANALISI DELLO STATUS E DELLA DISTRIBUZIONE DEI RAPACI DIURNI NIDIFICANTI NEL LAZIO foto di Vincenzo Penteriani Quaderni - Natura e Biodiversità 2/2012 1 Informazioni legali L’istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le persone che agiscono per conto dell’Istituto non sono responsabili per l’uso che può essere fatto delle informazioni contenute in questo Quaderno. La Legge 133/2008 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008, ha isti- tuito l’ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. L’ISPRA svolge le funzioni che erano proprie dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (ex APAT), dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (ex INFS) e del- l’Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica Applicata al Mare (ex ICRAM). Informazioni legali ISPRA – Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale Via Vitaliano Brancati, 48 – 00144 Roma www.isprambiente.it ISPRA, Quaderni – Natura e Biodiversità n. 2/2012 ISBN 978–88–448–0529–6 Riproduzione autorizzata citando la fonte Elaborazione grafica: ISPRA Editing e grafica: Paolo Di Orazio Grafica di copertina: Franco Iozzoli Foto di copertina: Albanella minore (Roberto Ragno) – Astore, Grifone (Vincenzo Pen- teriani) – Grillaio (Stefano Laurenti), Falco pecchiaiolo, Aquila reale (Michele Cento) Coordinamento tipografico: Daria Mazzella ISPRA – Settore Editoria Citazione del volume: Aradis A., Sarrocco S. & Brunelli M. 2012. Analisi dello status e della distribuzione dei rapaci diurni nidificanti nel Lazio. Quaderni Natura e Biodiversità 2/2012 ISPRA, ARP Lazio. -

Geology of the Central Apennines: a Regional Review
Geology of the central Apennines: a regional review Domenico Cosentino, Paola Cipollari, Pietro Marsili, Davide Scrocca Journal of the Virtual Explorer, Electronic Edition, ISSN 1441-8142, volume 36, paper 12 In: (Eds.) Marco Beltrando, Angelo Peccerillo, Massimo Mattei, Sandro Conticelli, and Carlo Doglioni, The Geology of Italy: tectonics and life along plate margins, 2010. Download from: http://virtualexplorer.com.au/article/2010/223/apennines-review Click http://virtualexplorer.com.au/subscribe/ to subscribe to the Journal of the Virtual Explorer. Email [email protected] to contact a member of the Virtual Explorer team. Copyright is shared by The Virtual Explorer Pty Ltd with authors of individual contributions. Individual authors may use a single figure and/or a table and/or a brief paragraph or two of text in a subsequent work, provided this work is of a scientific nature, and intended for use in a learned journal, book or other peer reviewed publication. Copies of this article may be made in unlimited numbers for use in a classroom, to further education and science. The Virtual Explorer Pty Ltd is a scientific publisher and intends that appropriate professional standards be met in any of its publications. Journal of the Virtual Explorer, 2010 Volume 36 Paper 12 http://virtualexplorer.com.au/ Geology of the central Apennines: a regional review Domenico Cosentino 1. Dip. Scienze Geologiche - Università degli Studi Roma Tre L.go S. Leonardo Murialdo, 1 I-00146 Roma Email: [email protected] 2. Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria, CNR, Rome, Italy Paola Cipollari 1. Dip. Scienze Geologiche - Università degli Studi Roma Tre L.go S. -

Geografická Olympiáda
Gymnázium Janka Kráľa, Zlaté Moravce Geografická olympiáda Šk. rok: 2013-2014 Zuzana Košútová II.B Gymnázium Janka Kráľa, Zlaté Moravce Vybrané prímorské strediská cestovného ruchu v Európe (Práca geografickej olympiády – Kategória A) Školiteľ : PaedDr. Viera Šedíková Šk. rok : 2013 - 2014 Zuzana Košútová II.B Obsah Abstrakt práce.................................................................... Chyba! Záložka nie je definovaná. 0 Úvod ............................................................................... Chyba! Záložka nie je definovaná. 1 Prehľad použitej literatúry .............................................. Chyba! Záložka nie je definovaná. 2 Metodika práce ............................................................... Chyba! Záložka nie je definovaná. 3 Fyzicko-geografická charakteristika Apeninského polostrova a priľahlých ostrovov ........... 5 3.1 Stavba .......................................................................................................................... 5 3.2 Poloha .......................................................................................................................... 9 3.3 Povrch ........................................................................................................................ 10 3.4 Podnebie .................................................................................................................... 13 3.5 Vodstvo ..................................................................................................................... 14 3.6 Rastlinstvo -

Programma Attività 2021
Corsi e Incontri di Cultura e del Sapere Biblioteca In sede è possibile consultare la biblioteca, ricca di manuali Nell’arco dell’anno saranno organizzati eventi inerenti la tecnici, monografie, romanzi e riviste inerenti la montagna. cultura montana e del territorio, con presentazione di La biblioteca offre i seguenti servizi: C libri, videoproiezioni, incontri etc. I dettagli degli eventi * consultazione - tutti i libri sono consultabili in sede saranno di volta in volta resi disponibili sul sito web e contattando il referente della biblioteca (servizio disponibile A nella bacheca della sezione. Con lo scopo di fornire le anche per i non soci CAI); basi per una corretta e sicura fruizione escursionistica * e/o alpinistica dell’ambiente montano, si organizzano prestito - i soci CAI possono usufruire del prestito libri alle I serate nelle quali si approfondiscono le tematiche più condizioni riportate nello specifico regolamento; * acquisto - sia i soci che i non soci CAI possono acquistare i diverse: dalla natura al rispetto della montagna, dalla sicurezza in parete al comportamento da tenere in libri in corso di edizione o disponibili in più copie. E ambiente innevato. I titoli dei libri disponibili sono pubblicati sulla pagina “Biblioteca” del sito web sezionale. S Videoproiezioni in Programma Manutenzione Sentieri SPELEOLOGIA P Nella pagina “Sentieri e Mappe” del nostro sito web sono La Grotta Segreta di Ulisse disponibili le tracce dei sentieri dei Monti Aurunci, contrassegnati Club Alpino Italiano AMBIENTE con la numerazione CAI dal n.906 al n. 980. Sono i sentieri a E The Dark Side of Mountain cui la Sezione CAI di Esperia provvede alla manutenzione e alla Sezione di Esperia segnatura. -

Coleotteri Saproxilici in Direttiva Habitat Del
BOLL. SOC. ENTOMOL. ITAL., 146 (3): 99-110, ISSN 0373-3491 15 DICEMBRE 2014 Daniele DI SANto* - Alessandro B. BISCACCIANtI** Coleotteri saproxilici in Direttiva Habitat del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga (Appennino centrale) (Coleoptera Rhysodidae, Lucanidae, Cetoniidae, Cerambycidae) Riassunto: In questa nota si presenta un aggiornamento dei dati sui coleotteri saproxilici inclusi in Direttiva Habitat presenti nel territorio del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. Sono state censite cinque specie, Rhysodes sulcatus, Lucanus cervus, Osmoderma eremita, Cerambyx cerdo e Rosalia alpina, per ognuna delle quali, oltre a riportarne i dati di cattura e bibliografici a noi noti, se ne discute brevemente il significato ecologico e conservazionistico. Lucanus cervus è qui citato per la prima volta dell’Abruzzo e, assieme a Rhysodes sulcatus e C. cerdo, anche per il territorio dell’area protetta. Il rinvenimento di R. sulcatus risulta particolarmente significativo sia per la rarità della specie, sia perché il reperto qui riportato ne conferma la presenza nell’Italia peninsulare. Abstract: Saproxylic beetles of Habitats Directive of the Gran Sasso e Monti della Laga National Park (Central Apennine). A review of data on saproxylic beetles listed in the EU Habitats Directive occurring in the Gran Sasso e Monti della Laga National Park is presented. Five species, Rhysodes sulcatus, Lucanus cervus, Osmoderma eremita, Cerambyx cerdo, and Rosalia alpina have been recorded; known biblio- graphic references and collecting data are provided, together with a brief discussion on their ecological and conservation significance. Lucanus cervus is here quoted for the first time for the Abruzzo region and, together with Rhysodes sulcatus and C. -

CATENA DELLE MAINARDE Parco Nazionale Abruzzo Lazio E Molise
CLUB ALPINO ITALIANO Sezione di Bari via Volpe 6 70100 BARI 080.5559602 www.caibari.it 11 – 12 APRILE 2015 Passo dei Monaci (m. 1967) CATENA DELLE MAINARDE Parco Nazionale Abruzzo Lazio e Molise Organizzatori: Giuseppe Labellarte: tel. 349 2112852 – Paolo Tempesta: tel. 3288399229 Partenza da Bari: sabato 11 aprile ore 15,00 c/o il supermercato Famila di V.le della Resistenza Grado difficoltà: EAI (escursionisti in ambiente innevato) Possibilità di pernottamento: CASTEL DI SANGRO - Hotel “Il Lavatoio” Tel. 338 3690024 ************************************************************************************** AVVICINAMENTO STRADALE: • (giorno 11) - A14 uscita Castel di Sangro – SS652 fino a Castel di Sangro (Bari - Castel di Sangro = Km 313 ca – tempo: h 3,47) • (giorno 12) - Partenza: Castel di Sangro – girare a sinistra: SS17 in direzione di NAPOLI - girare a destra: SS652 in direzione Venafro - girare a destra: ss158 in direzione di: Alfedena – Pizzone ( Castel di Sangro – Pizzone = Km 28 – tempo: 30 min). Da Pizzone (724 m s.l.m.) si raggiunge, attraverso una serie di tornanti, l’altopiano Le Forme nella Vallefiorita (1400 m) da cui si gode lo spettacolare scenario della catena delle Mainarde ricoperta da foresta selvaggia, a tratti impenetrabile. Parcheggio auto e ritrovo con soci di altre sezioni: ore 9,00. PERCORSO ESCURSIONISTICO: Gruppo Montuoso: APCEN088 Monti della Meta Numerazione: Tappa 17 Difficoltà: EAI Descrizione itinerario: Valle Fiorita - Pianoro Le Forme – Acquedotto Le Forme e Rifugio- Faggeta - Valle Pagana- Passo dei Monaci Quota partenza: Valle Fiorita (Pizzone) 1400 mslm Quota arrivo: Passo dei Monaci 1967 mslm Dislivello: in salita: mt 567 Tempo di percorrenza (ore 6,30): 3.30 andata e 3.00 ritorno Descrizione del percorso Salendo dal centro abitato di Pizzone (quota mt 750) con le automobili sull'asfaltata per circa 12 Km con 16 tornanti si arriva nel Pianoro delle Forme (mt 1400), meglio conosciuto come "Valle Fiorita". -

Rischio Sismico
PIANO di PROTEZIONE CIVILE di Roma Capitale Fascicolo 7 Rischio sismico 2021 Piano di Protezione Civile di Roma Capitale Piano Comunale di Protezione Civile (art. 12, comma 2, lett. e) del D.lgs. 1/2018) Piano di Emergenza Comunale (D.G.R. Lazio 363/2014) FASCICOLO 7 Rischio Sismico Dicembre 2020 Piano di Protezione Civile di Roma Capitale Fascicolo n. 7 - Rischio Sismico ARTICOLAZIONE DEL PIANO Informazioni di carattere generale……………….............................................Fascicolo 1 Rischio idraulico…………………………………................................................Fascicolo 2 Rischio idrogeologico da frana……………………............................................Fascicolo 3 Rischio neve e ghiaccio …………………............................................................Fascicolo 4 Rischio incendio boschivo e di interfaccia.........................................................Fascicolo 5 Rischio incidente rilevante..................................................................................Fascicolo 6 Rischio sismico ..................................................................................................Fascicolo 7 Altri rischi...............................................................................................................Fascicolo 8 3 Piano di Protezione Civile di Roma Capitale Fascicolo n. 7 - Rischio Sismico 4 Piano di Protezione Civile di Roma Capitale Fascicolo n. 7 - Rischio Sismico SOMMARIO 1. Normativa di riferimento ................................................................................................ -

Escursioni Settimana Verde – Abruzzo 26 -6 / 4-7 2021 Pnalm – Gran Sasso
ESCURSIONI SETTIMANA VERDE – ABRUZZO 26 -6 / 4-7 2021 PNALM – GRAN SASSO Inizieremo la settimana con arrivo a Pescasseroli (AQ), sabato 26. Consegna camere al pomeriggio dopo le 15. Alloggeremo presso l’ Hotel “Orso Bianco” 4 stelle, conduzione famigliare, posto a ca. 1 km da centro del paese. Trattamento di mezza pensione (bevande incluse ai pasti), pernottamento in camere doppie. PESCASSEROLI (AQ) ca.700 Km da Vimodrone Alcune brevi informazioni: Pescassèroli è un comune italiano di 2 105 abitanti della provincia dell'Aquila in Abruzzo. È sede dell'ente gestore del parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. (PNALM) Territorio Il territorio del comune è geograficamente compreso nel bacino idrografico dell'Alto Sangro in una valle montana che scende dal valico di Gioia Vecchio (Passo del Diavolo, 1400 m s.l.m.) fino ad una conca montana a quota 1 167 m s.l.m., nel cuore dei monti Marsicani a ovest del gruppo Montagna Grande (monte Argatone, la Terratta e Serra della Terratta) e di quello del monte Marsicano (2 253 m s.l.m.), che la dividono dalla vallata di Scanno a est, e a est dello spartiacque appenninico, sede del centro abitato principale del parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e della sua direzione amministrativa centrale. A nord-ovest il valico Aceretta mette in comunicazione i territori montani di Pescasseroli e Villavallelonga. Sul monte delle Vitelle (noto come monte Coste delle Vitelle, 1966 m s.l.m.) ha sede l'omonima stazione sciistica che fa parte del comprensorio sciistico dell'Alto Sangro. Temperatura media giu – lug max 21°-24° - minima 7° - 9°.