Powered by TCPDF (
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
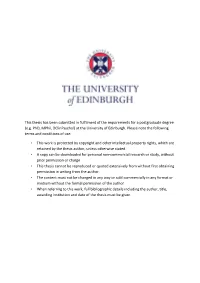
Ferguson2012.Pdf
This thesis has been submitted in fulfilment of the requirements for a postgraduate degree (e.g. PhD, MPhil, DClinPsychol) at the University of Edinburgh. Please note the following terms and conditions of use: • This work is protected by copyright and other intellectual property rights, which are retained by the thesis author, unless otherwise stated. • A copy can be downloaded for personal non-commercial research or study, without prior permission or charge. • This thesis cannot be reproduced or quoted extensively from without first obtaining permission in writing from the author. • The content must not be changed in any way or sold commercially in any format or medium without the formal permission of the author. • When referring to this work, full bibliographic details including the author, title, awarding institution and date of the thesis must be given. Carlo Emilio Gadda as Catholic and Man of Science: The Case of Quer pasticciaccio brutto de via Merulana Christopher John Ferguson Ph.D The University of Edinburgh 2012 Declaration I declare that this thesis has been composed exclusively by myself, that it is my own work and that no part of it has been submitted for any other degree or professional qualification. Christopher John Ferguson Stoneyburn, 16 th of May 2012. 2 This thesis is dedicated to my mum, my dad and Sarah. 3 Abstract The present study looks at the influence that two of the major cultural forces of the twentieth century had on the output of Carlo Emilio Gadda. It grew out of a search for ways of discussing Gadda and in particular his 1957 novel Quer pasticciaccio brutto de via Merulana that would be accessible to the widest possible audience. -

Miscellanea Medicea Ii (201-450). Inventario
STRUMENTI CLXXXVI MISCELLANEA MEDICEA MISCELLANEA MEDICEA II II ROMA 2009 MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI Stemma ligneo della famiglia Medici, Archivio di 2009 Stato di Firenze STRUMENTI PUBBLICAZIONI DEGLI ARCHIVI DI STATO CLXXXVI STRUMENTI CLXXXVI ISBN 978-88-7125-305-3 ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE MISCELLANEA MEDICEA MISCELLANEA MEDICEA II II (201-450) (201-450) Inventario a cura di BEATRICE BIAGIOLI GABRIELLA CIBEI VERONICA VESTRI Inventario a cura di BEATRICE BIAGIOLI, GABRIELLA CIBEI, VERONICA VESTRI Coordinamento scientifico e revisione PIERO MARCHI MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI ROMA DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI 2009 2009 Nel ricordo di Anna Bellinazzi: ci mancheranno i suoi consigli e la sua amicizia Il lavoro di schedatura è stato finanziato dalla Direzione generale per gli archivi attraverso una convenzione con l’Istituto nazionale di studi sul Rinascimento. PUBBLICAZIONI DEGLI ARCHIVI DI STATO STRUMENTI CLXXXVI ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE MISCELLANEA MEDICEA II (201-450) Inventario a cura di BEATRICE BIAGIOLI, GABRIELLA CIBEI, VERONICA VESTRI Coordinamento scientifico e revisione PIERO MARCHI MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI 2009 DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI Servizio III - Studi e ricerca Direttore generale per gli archivi: Luciano Scala Direttore del Servizio III: Patrizia Ferrara Cura redazionale: Maria Grazia Lippolis Elaborazione schede: Beatrice Biagioli, Gabriella Cibei, Veronica Vestri (le specifiche a p. 1095) Si ringraziano: Patrizia Ferrara e Maria Grazia Lippolis della Direzione generale per gli archivi. Carla Zarrilli, direttrice dell’Archivio di Stato di Firenze. Rosalia Manno Tolu, già direttrice dell’Archivio di Stato di Firenze, per avere promosso la realizzazione di questo lavoro. -

Ludovico Maria Sinistrari's De Daemonialitate and Its
Ludovico Maria Sinistrari’s De Daemonialitate and its Transmission in Manuscript and Print MA Thesis Book and Digital Media Studies Matt Beros Leiden University s1441345 Supervisor: Prof. Adriaan van der Weel Second Reader: Dr. Susanna de Beer 21 June 2019 Word count: 18,142 Table of Contents Introducton 3 1. Isidore Liseux’s Daemonialitate Manuscript: Discovery, Reception and Authenticity 1.1 Liseux’s Discovery of the Daemonialitate Manuscript 10 1.2 The Fin de Siècle Reception of Liseux’s De la Démonialité 12 1.3 ‘Facétie Bibliographique’: Accusations of a Manuscript Forgery 18 1.4 On the Authenticity and Provenance of the Liseux Manuscript 20 2. De Delictis et Poenis Tractatus Absolutissimus: From Publication to Prohibition 2.1 A Brief Life of Ludovico Maria Sinistrari 25 2.2 The Publishing History of De Delicits et Poenis 27 2.3 The Historical Context of De Daemonialitate 33 2.4 The Censoring of De Delictis et Poenis 37 2.5 De Daemonialitate as an Unexpurgated Manuscript Draft 41 3. The Manuscript Circulation of De Daemonialitate 1699-1753 3.1 The Manuscript Filiation of De Daemonialitate 50 3.2 Ambrosiana MS 52 3.3 Muratori MS 54 3.4 Tadisi MS 55 3.5 Villarosa MS 40 62 3.6 Casanatense MS 4953 65 3.7 Angelica MS 2240 65 4. The Later Print Editions of De Daemonialitate 1879-1927 4.1 The Later Editions of Liseux 67 4.2 The Editions of Fryar, Clymer and Summers 71 Conclusion 75 Appendix Creaturarum Rationalium Corporearum: Tadisi’s Accounts of Demoniality 77 Bibliography 84 2 Introduction C’est le péché lettré, patricien et décadent par excellence; il faur plus que de l’imagination, beaucoup de lecture et un peu d’archéologie pour le commettre. -

Avvertenze Al Catalogo
Avvertenze al catalogo: Le diciture delle biblioteche sono state abbreviate secondo le seguenti norme: Pd BU : Padova Biblioteca Universitaria Ts BC: Trieste, Biblioteca Civica Attilio Hortis Ve BMC: Venezia, Biblioteca del Museo Correr Ve BM: Venezia, Biblioteca Marciana Ve FGC: Venezia, Biblioteca della Fondazione Giorgio Cini Vi BCB: Vicenza, Biblioteca Civica Bertoliana Tra parentesi quadre si sono indicate le misure delle incisioni, le iscrizioni e le indicazioni di responsabilità. Catalogo Il Seicento N. cat.: 1 Autore: Panvinio Onofrio (Verona 1530-Palermo 1568) Titolo: ONVPHRII/ PANVINII/ VERONENSIS,/ DE LVDIS CIRCENCIBVS, LIBRI II./ DE TRIUMPHIS, LIBER VNVS./ Quibus vniversa ferè/ ROMANORVM VETERVM/ SACRA RITVSQ. DECLARANTVR,/ ac Figuris Aeneis Illustrantur./ AD SERENISSIMVM/ FRANCISCVM MARIAM/ Secundum Vrbini Ducem Sextum./ Cum rerum memorabilium Indice copiosissimo./ VENETIIS, Apud Ioannem Baptistam Ciottum/ Senesem. M.DC. Superiorum permissu.// Formato: 37 x 25 cm Volume: 1 vol. Luogo di pubblicazione: Venezia Editore o stampatore: Giovanni Battista Ciotti Anno di pubblicazione: 1600 Dedica: Descrizione: Per la descrizione delle incisioni del frontespizio (fig. 1a) e delle tavole, cfr. la scheda dell’edizione veneziana del 1642 (cat. 11). Note: L’apparato iconografico è realizzato da Onofrio Panvinio e da Étienne Dupérac, ma compaiono anche copie e rifacimenti da disegni di Pirro Ligorio. Nel testo sono inserite calcografie raffiguranti rilievi, piante, vedute a volo d’uccello del Circo Massimo, del Circo Variano di Roma e dell’Ippodromo di Costantinopoli, e di altri edifici in cui, nell’antichità, si svolgevano degli spettacoli come teatri e anfiteatri. Oltre alla numerosa serie di architetture, nelle tavole piegate e inserite all’interno del testo, sono riprodotti anche reperti archeologici come fronti di sarcofagi e rovesci di monete raffiguranti le gare, le cerimonie e i riti che si svolgevano in questi luoghi. -

Religion and Food
RELIGION AND FOOD RELIGION AND FOOD Based on papers read at the conference arranged by the Donner Institute for Research in Religious and Cultural History, Åbo Akademi University, Turku/Åbo, Finland, on 25–27 June 2014 Edited by RUTH ILLMAN and BJÖRN DAHLA Scripta Instituti Donneriani Aboensis 26 Turku/Åbo 2015 Editorial secretary Maria Vasenkari Linguistic editing Sarah Bannock ISSN 0582-3226 ISBN 978-952-12-3192-6 Aboprint Pargas 2015 Table of contents Ruth Illman and Björn Dahla Religion and food 7 Benjamin E. Zeller Totem and taboo in the grocery store: quasi-religious foodways in North America 11 Graham Harvey Respectfully eating or not eating: putting food at the centre of Religious Studies 32 Michel Desjardins Imagining Jesus, with food 47 Panu Pihkala Ecotheology and the theology of eating: convergencies and controversies 64 Natalia Moragas Segura and Elena Mazzetto Contexts of offerings and ritual maize in the pictographic record in Central Mexico 82 Gioia Filocamo Hungry women: sin and rebellion through food and music in the early modern era 101 Andrea Gutierrez Modes of betel consumption in early India: bhoga and abhoga 114 Bindu Malieckal Early modern Goa: Indian trade, transcultural medicine, and the Inquisition 135 5 Ulrica Söderlind Religion and diet in a multi-religious city: a comprehensive study regarding interreligious relations in Tbilisi in everyday life and on feast days 158 Miriam Abu Salem Religious dietary rules and the protection of religious freedom: some evidence from practice in Italy 181 Katarina Plank The -

Dono Di Eterna Riconoscenza
(ll arlo ,£i ar t olome o ìlì omilli A R C ! V E S C G V O DIMILA NO. mall ’ antica e nobile famiglia bergamasca dei conti R OMIL LI nas ce v a BA R TOL OME O ai 44 d e l 4 9 marzo 7 6. Fra le doti caratteristiche di u n sublime n ff i gegno , a erma i l filosofo ,essere la preco i à c t ,la quale anche ad onta di poca o ne s s u na ed ucazione delle facoltà intellettuali ,non l T L ME ma m tarda a svilupparsi . n BA R O O O Ro o < s )e assecondato l ’ ingegno da retta educazione che il lustro della famiglia esigeva ,non tardò ’ a dimostrare che l inge gno s uo e d i retti insegnamenti avvalorati da efficace v olontà , favorivano le più care conseguenze . Varche r emo i l periodo di giovinezza di m onsignore ’ R OMILL I, nel quale la diligenza , l ingegno,la condotta lo resero caro ai condiscepoli che ’ in lui 5 avevano un amico ; grato ai maestri , ’ cui rendeva il migliore tributo d e ll imp ar ar e ; amato dai cons anguinei e genitori che tante Speranze in lui avevano riposte . Nei pubblici e nei privati esperimenti e gli diede lodevoli ’ prove di s è ,e l indole s ua docile , pieghe ’ vole , s u niv a a rendere più eminenti i suoi progressi . Erudito nei prim i e ne ce s s arjelementi della l ingua italiana ,che doveva parlare e scrivere i n appresso con tanto buon gusto ,egli avan zava il piede nel tempio delle belle lettere . -

Dissüberarbeitet END 10.1.19 Version Vom 26.3.18 Komprimiert
Kirchenmusik in Mailand von 1740 bis 1780 Biritualität im Kontext der ambrosianischen und römischen Liturgie Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde an der Philosophischen Fakultät der Universität Freiburg (CH) Genehmigt von der Philosophischen Fakultät auf Antrag der Herren Professoren Luca Zoppelli (1. Gutachter) und Claudio Toscani (2. Gutachter) Freiburg, den 8. März 2012 Prof. Marc-Henry Soulet, Dekan Christoph Riedo, Plaffeien (FR) Latuada, Serviliano: Descrizione di Milano ornata con molti disegni in rame delle fabriche più conspicue, che si trovano in questa metropoli, Bd. 5, Mailand 1737–38. Inhaltsverzeichnis Liturgische Bücher, bibliographische Abkürzungen und Bibliothekssigel .............................. iv Liturgische Bücher ................................................................................................................ iv Bibliographische Abkürzungen ..............................................................................................v Bibliotheken und Archive ..................................................................................................... vi Vorwort ................................................................................................................................ vii Bemerkung zur Gehalts- und Preisentwicklung in Mailand im 18. Jahrhundert ....................x Einleitung ................................................................................................................................1 I. Kapitel: ....................................................................................................................................6 -

Indicazioni Per La Ricerca Genealogica Delle Famiglie Ticinesi
INDICAZIONI PER LA RICERCA GENEALOGICA DELLE FAMIGLIE TICINESI di Giovanni Maria Staffieri I - PREMESSE La presente memoria non vuol essere un trattato di metodologia per la storiografia delle famiglie ticinesi, ma è destinata a servire in qualche modo da strumento pratico, alla portata di chiunque abbia interesse a ripercorrere le vicende della propria stirpe sulla scorta della più estesa documentazione rintracciabile. La base della ricerca è costituita dalle famiglie "patrizie", ove per patrizio s'intende "colui che è membro dell'antico comune e partecipa al godimento dei beni indivisi. L'Antico comune si chiamava "vicìnia"; chi vi era ascritto era un "vicìno". Le denominazioni "patrizio", "patriziato", applicate nel suddetto senso, sorsero nel 1798 ..." (v. Lienhard-Riva: Armoriale Ticinese, pag. XVIII). Dal 1835 il "patriziato" è un ente di diritto pubblico, e meglio una corporazione perpetua di famiglie con beni comuni, avente personalità giuridica e posta sotto la salvaguardia di una legge organica patriziale (attualmente quella del 1992, in vigore dal I gennaio 1995, la quarta in ordine di tempo). Ricordiamo che solo in una parte dei comuni sono organizzati uno (nella quasi totalità dei casi) o più patriziati a partire dal 1835, epoca della prima legge organica e talvolta anche precedentemente, a seguito della separazione dal comune politico; per contro diversi patriziati, un tempo fiorenti, hanno cessato ogni attività o sono stati disconosciuti in base alla nuova LOP. Molti archivi comunali conservano, assieme ai propri documenti, anche le carte dell'antica vicinia e quelle del successivo patriziato. Di regola, le famiglie patrizie sono le più antiche indigene o venute a risiedere nel comune: spesso, e anche in tempi passati, una famiglia estranea che si domiciliava nel comune poteva, previa richiesta e approvazione della "vicinanza" (l'assemblea dei vicini) essere iscritta con atto notarile alla vicinia con l'esborso di una certa somma di denaro. -

Hungry Women Sin and Rebellion Through Food and Music in the Early Modern Era
Hungry women Sin and rebellion through food and music in the early modern era GIOIA FILOCAMO onging for food has always had different implications for men and women: associated with Lpower and strength for men, it tends to have a worrying proximity to sexual pleasure for women. Showing an interesting parallelism throughout the Cinquecento, Italian humanists and teachers insisted on forbidding women music and gluttony. Food and music were both considered dangerous stimulants for the female senses, and every woman was encouraged to consider herself as a kind of food to be offered to the only human beings authorized to feel and satisfy desires: men and babies. Women could properly express themselves only inside monastic circles: the most prolific female composer of the seventeenth century was a nun, as was the first woman who wrote down recipes. Elaborate music and food became the means to maintain a lively relationship with the external world. Moreover, nuns also escaped male control by using the opposite system of affirming themselves through fasting and mortifying the flesh. In memory of Francesca, who enjoyed cooking and loved music The relationship between food and Christianity has always been problematic and ambivalent, given the complicated dynamics respecting intentionality and the remission of sins. From reading Penitentials – books circulating between the sixth and eleventh centuries where penances were mathematically calcu- lated, which spread after the crisis of public penitence, but before the diffusion of manuals for confessors (Muzzarelli 1994; 2003: 10–11; 2006: 66–7) – we can see that the remission of sins followed simple rules managed by the priest,1 who assigned a precise number of days of taking only ‘bread and water’ as a penance.2 1 Previously, public penitence had instead been managed by the bishop. -

Capítulos De La Provincia De La Corona De Aragón Del Siglo XVII *
Capítulos de la Provincia de la Corona de Aragón del siglo XVII * POR Q u ir in o F e r n á n d e z , o s a IV. LOS DEL ÚLTIMO CUARTO DEL SEISCIENTOS (1674-1699) SUMARIO: Introducción Capítulos celebrados.- Tiempo y lugar.- Los códices.- Por qué se prescin de de los criterios de transcripción enunciados. Actas capitulares: XXXV. Capítulo intermedio de 1674.- XXXVI. Cap. prov. de 1675.- XXXVII. Cap. Ínter, de 1679.- XXXVIII. Cap. prov. de 1684.- XXXIX. Cap. ínter, de 1685.- XL. Cap. prov. de 1687.- XLI. Cap. ínter, de 1688.- XLII. Cap. prov. de 1690.- XLIII. Cap. Ínter, de 1691.- XLIV. Cap. prov. de 1693.- XLV. Cap. ínter, de 1694.- XLVI. Cap. prov. de 1696.- XLVII. Cap. ínter, de 1697,- XLVIII. Cap. prov. de 1699. INTRODUCCIÓN Después de lo dicho en las introducciones precedentes sobre la institución de la «Alternativa» en los puestos de gobierno y su evolución histórica, sobre los conventos y número de religiosos de la provincia, sobre la década de la re- . Archivo Agustiniano 62,1978,281-343; 63,1979,109-178; 65,1981,75-216. 42 Q. FERNÁNDEZ, OSA 274 belión de Cataluña y los difíciles años que la sucedieron, sobre los estudios y la predicación, sobre la bibliografía y criterios de transcripción, la correspon diente a esta cuarta entrega se limitará sencillamente a unas observaciones pre vias. Durante estos últimos veinticinco años del Seiscientos (1674-1699) se ce lebraron dieciocho capítulos —nueve provinciales y otros nueve inter medios— en la provincia de la Corona de Aragón. Los capítulos provinciales se celebraban la segunda semana después de Pascua de Resurrección; los inter medios, al cumplirse el año y medio* que solía ser por el mes de noviembre del año siguiente. -

Storia Di Pombia Antica E Del Suo Territorio
STORIA DI POMBIA ANTICA E DEL SUO TERRITORIO date e avvenimenti dal XIV al XIX secolo a cura di Claudio Silvestri anno 2016 Storia di Pombia Antica e del suo territorio Progetto e realizzazione grafica Claudio Silvestri Stampato presso Tipolitografia TLS via Borgoticino 7 - Comignago Prima edizione settembre 2016 2 Storia di Pombia Antica e del suo territorio Presentazione Ci siamo lasciati al volume primo della Storia di Pombia Antica con gli avvenimenti all’inizio del XIV secolo, la distruzione della fortilicia (il Castel Domino) nel 1311 nel corso delle guerre tra il Comune di Milano e il Comune di Novara, ultimo baluar- do di residenza signorile nell’antico castrum pombiese. Non avevo promesso nulla circa la prosecuzione della ricerca storica, avevo però lan- ciato segnali rimandando ad ulteriori approfondimenti la descrizione di luoghi e av- venimenti a chiusura del secolo XIV e come cerniera con gli inizi del secolo XV con i feudi di Pombia e di Varallo Pombia e poi una carrellata storica percorrendo i suc- cessivi secoli sino all’Ottocento. Oggi questo impegno diventa realtà. Mi pare di poter dire che le vicende di Pombia nei secoli successivi, ad iniziare dall’epoca feudale, sono ricche di argomenti legati a tradizione storica e vita sociale di grande fascino, registra forse minore interesse negli studiosi che si sono riferiti soprattutto al periodo medioevale per la grande storia di Pombia e dei suoi monu- menti. E’ questa una condizione comune a tutto il territorio, anche Pombia sostanzialmente, dopo la distruzione delle strutture fortificate e la generale riorganizzazione ammini- strativa dei territori voluta dai Visconti nel novarese, perde inevitabilmente di impor- tanza. -

Tesi Di Dottorato Di Ricerca Il Monastero Della Visitazione
DIPARTIMENTO DI STUDI STORICI CORSO DI DOTTORATO IN STUDI STORICI E DOCUMENTARI (ETÁ MEDIEVALE, MODERNA, CONTEMPORANEA) XXVIII CICLO TESI DI DOTTORATO DI RICERCA IL MONASTERO DELLA VISITAZIONE DI MILANO (XVIII-XIX SECOLO). RELIGIONE, POLITICA, SOCIETÁ SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M-STO/07 Dott.ssa Daniela Sora Matricola: R09936 Tutor accademico Chiar.ma Prof.ssa Paola Vismara Tutor esterno Chiar.mo Prof. Giuliano Ferretti- Université Grenoble Alpes Coordinatore Chiar.mo Prof. Vittorio Criscuolo A.A. 2014-1015 Introduzione Il presente lavoro di ricerca ha preso spunto inizialmente da un capitolo di tesi di laurea magistrale in scienze storiche relativo al monastero della Visitazione di Milano. In seguito, viste l’abbondanza di materiale archivistico e la sua varietà, alla ricerca è stata data una maggiore ampiezza e organicità, elaborando un progetto che ha costituito con poche variazioni la struttura portante della presente tesi di dottorato1. Il titolo scelto, “Il Monastero della Visitazione di Milano (XVIII-XIX secolo). Religione, politica, società”, indica in sintesi i nuclei principali della ricerca stessa che corrispondono in maniera abbastanza precisa ai vari capitoli nei quali è suddiviso il lavoro. Il caso di studio preso in considerazione è il monastero della Visitazione di Santa Sofia a Milano; si tratta di un monastero femminile di clausura fondato nel 1713 e tuttora esistente il cui archivio, pur se non perfettamente riordinato, presenta però una certa continuità e ampiezza del materiale documentario anche per il fatto di non avere subìto spostamenti o traslochi obbligati tra Sette e Ottocento. Uno degli aspetti più interessanti che hanno motivato la decisione di occuparsi di Santa Sofia, è stato il fatto che si tratta di un unicum dal momento che fu l’unico monastero contemplativo milanese, per di più di un ordine d’oltralpe, sopravvissuto ai difficili rivolgimenti storico-politici a cavaliere tra XVIII e XIX secolo.