Ammentu 008 Dossier Tunisia
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
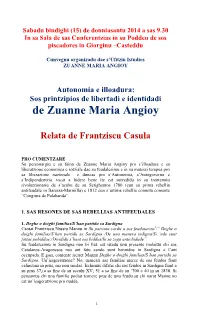
Cunvegnu De Sa CSS Subra Zuanne Maria Angioy.Rtf
Sabadu bindighi (15) de donniasantu 2014 a sas 9.30 In sa Sala de sas Cunferentzias in su Poddeu de sos piscadores in Giorginu –Casteddu Cunvegnu organizadu dae s’Ufitziu Istudios ZUANNE MARIA ANGIOY Autonomia e illoadura: Sos printzipios de libertadi e identidadi de Zuanne Maria Angioy Relata de Frantziscu Casula PRO CUMENTZARE Su personargiu e sa faina de Zuanne Maria Angioy pro s’illoadura e sa liberatzione economica e sotziale dae su feudalesimu e in su matessi tempus pro sa liberazione nazionale e duncas pro s’Autonomia, s’Autogovernu e s’Indipendentzia. tocat a bidere bene ite est sutzedidu in su trentenniu rivolutzionariu de s’acabu de su Setighentos 1780 (cun sa prima rebellia antifeudale in Baressa-Marmilla) e 1812 cun s’urtima rebellia connota comente “Congiura de Palabanda”. 1. SAS RESONES DE SAS REBELLIAS ANTIFEUDALES 1. Deghe o doighi familias/S’han partidu sa Sardigna Cantat Frantziscu Nassiu Mannu in Su patriota sardu a sos feudatarios 1:” Deghe o doighi familias/S’han partidu sa Sardigna /De una manera indigna/Si ‘nde sunt fattas pobiddas;/Divididu s’hant sas biddas/In sa zega antichidade”. Su feudalesimu in Sardigna non bi fiat: est istadu unu presente malaittu chi sos Catalanos-Aragonesos nos ant fatu cando sunt bennidos in Sardigna e l’ant occupada. E gasi, comente iscriet Mannu Deghe o doighi familias/S’han partidu sa Sardigna. Un’isageratzione? No, mancari sas familias meres de sos feudos fiant calincuna in prus, ma non medas. Ischimus difatis chi sos feudos in Sardigna fiant a su prus 37,(a sa fine de su seculu XV; 51 a sa fine de su ‘700 e 40 in su 1838. -

Examples of Positive Intercultural Practices in Modern Italy
UNIVERSITY OF BUCHAREST DEPARTMENT UNESCO CHAIR ON THE STUDY OF INTER-CULTURAL AND INTER-RELIGIOUS EXCHANGES MA Programme Intercultural Communication EXAMPLES OF POSITIVE INTERCULTURAL PRACTICES IN MODERN ITALY Author: ALEXANDRA VÎLCU Scientific Coordinator: Prof. MARTIN HAUSER FEBRUARY 2008 Summary I. Introduction / 4 II. The Risorgimento: the Story of the Italian Unification and the Triumph of Italian culture / 8 1. Historical Outline / 8 2. The Risorgimento as an Intercultural Process / 9 3. The Risorgimento: a Golden Age in Italian Culture / 11 4. Conclusions / 14 III. Ethnic minorities: history, status and cultural influences / 16 1. The Napoleonic Age & French culture / 16 2. The Habsburg domination and Austrian culture / 22 3. The South Tyrol Region / 25 4. The Island of Sardinia / 28 5. Conclusions / 32 IV. Intercultural practices and programmes for foreigners and immigrants. Support for immigrants and their adaptation to Italian culture / 34 1. General immigration issues in Italy / 34 2. Programmes of integration for immigrants / 36 3. Case study: Romania. What about the good intercultural practices? / 40 4. Conclusions / 45 2 V. Italy and international cultural exchange. Promoting Italian culture abroad / 47 1. Creating an image for the Italian culture / 47 2. Cultural initiatives of national institutions: Foreign Affairs Ministry, Ministry of Culture and UNESCO / 48 3. Italy and European Capitals of Culture / 53 4. Conclusions / 58 VI. Good intercultural practices and the media: is there enough media coverage? / 60 1. Cultural events as news values / 60 2. Cultural news and the Italian media / 62 VI. Final conclusions / 64 Bibliography / 69 3 I. Introduction During the past decades, many debates have taken place around the concepts of culture and intercultural practice. -
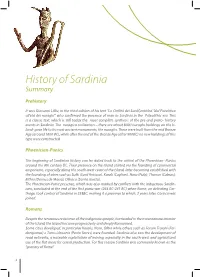
History of Sardinia Summary
History of Sardinia Summary Prehistory It was Giovanni Lilliu, in the third edition of his text “La Civilità dei Sardi”,entitled “dal Paeolitico all’età dei nuraghi” who confirmed the presence of man in Sardinia in the Paleolithic era. This is a classic text, which is still today the most complete synthesis of the pre and proto- history events in Sardinia. The nuragica civilization – there are about 8000 nuraghi buildings on the Is- land- gave life to its most ancient monuments, the nuraghs. These were built from the mid Bronze Age (around 1600 BC), while after the end of the Bronze Age (after 900BC) no new buildings of this type were constructed. Phoenician-Punics The beginning of Sardinian history can be dated back to the arrival of the Phoenician- Punics around the 9th century BC. Their presence on the island started via the founding of commercial emporiums, especially along the south-west coast of the Island, later becoming established with the founding of cities such as Sulki (Sant’Antioco), Karali (Cagliari), Nora (Pula), Tharros (Cabras), Bithia (Domus de Maria), Othoca (Santa Giusta). The Phoenician-Punic presence, which was also marked by conflicts with the indigenous Sardin- ians, concluded at the end of the first punic war (264 BC-241 BC) when Rome, on defeating Car- thage, took control of Sardinia in 238BC, making it a province to which, 2 years later, Corsica was joined. Romans Despite the tenacious resistance of the indigenous people, barricaded in the mountainous interior of the Island, the Island became progressively and deeply Romanised. Some cities developed, in particolar Karalis, Nora, Olbia while others such as Forum Traiani (For- dongianus) e Turris Libisonis (Porto Torres) were founded. -

Giovanni Maria Angioy, Precursore Della Moderna “Autonomia”Della Sardegna O Uomo Del Suo Tempo?”
Progetu realizadu cun sa partitzipatzioni de sa Regioni Autònoma de Sardigna L.R. 44/93 Sa Die de sa Sardigna 4 de Meseidas 2014, Seddori Istitutu Tècnicu “Colli Vignarelli”, h.9,00 MURALE - ORGOSOLO Giuanne Maria Angioy, antitzipadore de s’Autonomia moderna de sa Sardigna o òmine de su tempus suo? “Giovanni Maria Angioy, precursore della moderna “autonomia”della Sardegna o uomo del suo tempo?” ATOS DE SU CUNVEGNU / “Atti del Convegno” Summàriu Presentada Dae sa Dispedida de Sos Piemontesos a Angioy “Alternos” – Prof. Francesco Casula ............................................................................................................................................. 1 Dae sa Dispedida de Sos Piemontesos a Angioy “Alternos” – Pro comintzare......... 3 1. Cando nc’ant bogadu sos piemontesos Su fatu ............................................................................................................................ 3 Su significadu simbòlicu de Sa die de sa Sardigna ................................................... 8 2. Sa post dispedida ........................................................................................................ 10 3. Sa figura de Zuanne Maria Angioy ........................................................................... 13 4. Angioy cultivadore e imprendidore, professore de diritu canònicu e giùighe de sa Reale Udièntzia. ...................................................................................................... 14 5. Angioy e sos motos de su 1795 .................................................................................. -

Sa Die De Sa Sardigna
Sa Die de sa Sardigna Su 28 de Arbìli est sa festa de su populu sardu, istituìa cun lei regionali n.44 de su 14 de Cabudanni de su 1993 e arregordat sa cumbata anti piemontesa de su 28 de Arbili de su 1794 . “Nara cixìri ” est sa trassa linguistica, is fueddus impreaus po arreconnosci is piemontesus e nci ddus bogai de sa Sardigna. Sa limba est fatu e sinnu identitàri. Cun sa limba sua unu pópulu si connoscit, s’arreconnoscit e si fait connosci a is àterus comenti pópulu, de unu logu, cun una língua. Ca is foresus , is stràngius, no arrennescint a spricai su sonu de sa scèscia, chi in sardu non bessit comenti “ x, ics”, ma “x, sc”, comenti sa “j” in frantzesu, sonat che “abat jour”. 1 Sa rivolutziòni Sarda In su 1718 cun su Tratau de Londra, sa Sardigna est in is manus de is Savoia, perou non nc’est diaderus una mellorìa, unu cambiaméntu po su chi pertocat s’economía e s’ísula sighit a abarrai a suta de unu sistema feudali de apétigu. Nc’est un’economía sceti de sustentu, e sa genti depit pagai impostas grais a is Feudatàrius, a su Rei, e a sa Crèsia, e is incàrrigus de prus importu ddus tenit is piemontesus. In pobiresa e scuntentesa nascint is primus brigas, e is moviméntus populàris antifeudàlis, intzullaus finas de sa Rivolutzioni Frantzesa noa (1789- 1799). In su 1793 biddas medas si furriant refudendisì de pagai is impostas feudalis e intzullendi certus contras a is feudatarius e is faidoris. S’AFRACADA FRANTZESA E SA BÍNCIDA SARDA (1792-1793) Is frantzesus afracant, cumbintus ca fiat cosa fàcili a binci contras a sa frachesa de s’amparu de is sardus ca, in prus, fiant pagus. -

SCA NEWSLETTER Vol 10 No 2
Sa Oghe The voice of the Sardinian Cultural Association Victoria Vol 10 No 2 June 2015 Sa Die De Sa Sardigna celebrated La giornata di festività Sa die de sa Sardigna (il giorno della Sardegna), la festività che ricorda la sommossa dei vespri sardi del 28 aprile del 1794 a Cagliari, che costrinse alla fuga il viceré sabaudo Vincenzo Balbiano, istituita dal Consiglio regionale della Sardegna nel 1993 nominan- dola Giornata del popolo sardo, la comunità di Melbourne l’ha celebrata con una formula già collaudata con grande successo in occasione della conclusione dell’appello per le alluvioni del novembre 2013: un ottimo pranzo presso il Club Italia di Sunshine, diretto dal Leo Vargiu (presidente), con la preziosa collaborazione di Margaret Giudice. Questa volta in cucina non c’erano i ‘4 mori’ della gastrono- mia sarda in Australia, ma i cuochi quel culturale nel titolo ha una del club hanno dato prova di funzione ben precisa e anche in essere grandi interpreti, in quella questa occasione si è offerta una che è diventata una perfetta dimostrazione delle traduzioni sinergia tra la Sardinian Cultural culturali sarde, grazie a Stefano Association e il Club Italia di Sun- Rassu, titolare del ristorante shine cucinando impeccabilmente Pomodoro Sardo e di suo cugino gli splendidi ‘malloreddus’, gli Marco Frau, entrambi originari di gnocchetti sardi, preparati come Aritzo, un comune di 1.300 abitanti in provincia di Nuoro, sempre con maestria dalla gentilis- detti ‘Niargios’ durante i mesi situato nell’antica regione della sima signora Tonina Nolis. estivi. Nel vecchio centro sopravvi- Barbargia di Belvi. Durante la parte ufficiale della vono ancora i resti delle ‘domos de giornata il presidente del circolo Aritzo oggi è noto soprattutto nie’, le case della neve. -

17A-Sa Die De Sa Sardigna 20/04/20 13:37
17a-Sa die de sa Sardigna 20/04/20 13:37 In nome de Sa Die e dell'Onu, dire no a "sa limba sarda comuna”. Non è comune ma soltanto autoritaria. (titolo redazionale) di Marinella Lőrinczi Va di moda - a quanto pare - da qualche tempo, forse da qualche anno, la cosiddetta "storia controfattuale" ovvero la "storia alternativa o virtuale". Dico "a quanto pare", perché quanto sia fashionable o trendy questo tipo di far storia, lo dichiarano i mezzi di comunicazione di massa, ai quali importa, come si sa, la cattura del pubblico, con qualsiasi mezzo: uno consiste nel convincere che ciò che i media fanno e offrono è importante, d'attualità, il meglio del meglio, è ciò che il popolo vuole, è imprescindibile, non plus ultra, affinché chi ascolta o guarda si illuda di essere a sua volta importante, à la page, informatissimo, al top (de che?), e via dicendo ma facendo le dovute eccezioni. Infatti la "storia controfattuale" ha molto a che fare coll'intrattenimento, anche di buon livello, per carità!; con i giochi di società, anche sofisticati, per carità!; soprattutto con la spettacolarizzazione e mediatizzazione della storia passata, lecita e utile, sempre "per carità!". Per chi non lo sapesse, e fosse dunque vergognosamente disinformato su alcune tendenze intellettuali dei nostri tempi, la "storia controfattuale" è un gioco, nel senso logico e speculativo del termine, per immaginare come si sarebbe svolta la storia (sociale, politica) se un determinato evento avesse avuto un esito diverso, se fosse quindi andato in un'altra direzione. L'importanza di quest'evento deve essere, obbligatoriamente, fuori discussione (i bei nasini delle varie Cleopatre sono perciò irrilevanti); deve trattarsi sempre di una causa determinante, ancorché valutata retrospettivamente. -
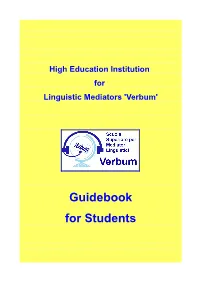
Guidebook for Students Contents
High Education Institution for Linguistic Mediators 'Verbum' Guidebook for Students Contents General Information about SSML Verbum.............................................................................5 Enrollment..........................................................................................................................6 Entrance exam to check the competences.......................................................................6 Students already holding a degree....................................................................................6 Transfer from other University Courses.............................................................................7 European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS)..........................................7 Information about the study course........................................................................................9 Degree in Translation and Interpreting..................................................................................9 General Description ..........................................................................................................9 Study Course Profile........................................................................................................10 Expected learning outcomes...........................................................................................10 Job profiles with examples...............................................................................................10 Study opportunities..........................................................................................................11 -

La “Sarda Rivoluzione”
Volume I Alessandra ZEDDA Anthony MURONI Danilo LAMPIS Gianni MARILOTTI M assimo DADEA Nicolò MIGHELI Omar ONNIS Paolo FRESU Vito BIOLCHINI Elvira SERRA A ldo ACCARDO M ariangela SEDDA Federico FRANCIONI Tonino MULAS Ottavio OLITA Mario SEGNI Luigi ZANDA Enzo CUGUSI ALESSANDRA ZEDDA Assessora Regionale del Lavoro, Formazione e Cooperazione Sociale. Laureata in Economia e commercio, ha militato nei massimi campionati nazionali di serie A e B come giocatrice e allenatrice di basket. PREFAZIONE Colgo con favore la significativa iniziativa promossa dall’Associazione Sardi Gramsci di Torino finalizzata a celebrare, nonostante l’emergenza in corso, Sa Die de Sa Sardigna attraverso un fotolibro digitale da socializzare e condividere con il mondo dell’emigrazione, dell’informazione e della politica. Particolarmente apprezzabile è la creatività con cui si intende non rinunciare ad un evento importante e un momento decisivo per la nostra Sardegna. Ad animare i moti de Sa Die fu proprio il coraggio e il rifiuto della rassegnazione, in forza della dignità dei sardi e del senso di appartenenza alla Sardegna. Credo che a buona ragione quei sentimenti possano essere richiamati oggi, per respingere la paura del contagio e fuggire dalla tentazione di arrendersi, pur nelle pesanti e gravi conseguenze economiche e sociali che la nostra isola, insieme all’Italia e al mondo intero, vivono. Per questi motivi plaudo alla brillante e coinvolgente idea che ci aiuta a vivere e festeggiare questo giorno consapevoli che pian piano riprenderemo in tutti i settori della vita, auspicando una maggiore consapevolezza della necessità di sentirci uniti al di là dei confini e nonostante le avversità, per essere e rappresentare in ogni luogo e in ogni istante l’orgoglio e la passione di essere sardi e d i onorare con ogni mezzo la bellezza della nostra Sardegna. -

SARDAIGNE 2014 En Numérique Ou En Papier En 3 Clics
LA VERSION COMPLETE DE VOTRE GUIDE SARDAIGNE 2014 en numérique ou en papier en 3 clics à partir de 4.99€ Disponible sur EDITION Directeurs de collection et Auteurs : Dominique AUZIAS et Jean Paul LABOURDETTE Benvenuti Auteurs : Marie-Isabelle CORRADI, Nicolas LANDRU, Juliana HACK, François Xavier DELISSE, Cauli TIZIANA Jean-Paul LABOURDETTE, Dominique AUZIAS et alter Directeur Editorial : Stéphan SZEREMETA in Sardegna ! SERVICE REDACTION France : François TOURNIE, Jeff BUCHE, Grégoire DECONIHOUT, Perrine GALAZKA La Sardaigne est un monde à part. C’est une de ces îles Monde : Patrick MARINGE, Caroline MICHELOT, Morgane VESLIN, Julien BERNARD, Pierre-Yves SOUCHET méditerrannéennes au caractère marqué, qui réserve FABRICATION d’innombrables merveilles à ses visiteurs. A commencer Responsable Studio : Sophie LECHERTIER par son littoral avec ses caps, ses îles et ses criques aux assistée de Romain AUDREN eaux turquoise, l’eau y est chaude et limpide, la côte est Maquette et Montage : Julie BORDES, Élodie CLAVIER, Sandrine MECKING, Delphine PAGANO, Laurie PILLOIS variée, abritant falaises, grottes sous-marines et des Iconographie et Cartographie : Robin BEDDAR myriades de plages de sable fin. De la Costa Smeralda, point de rencontre de la Jet Set internationale, aux petits WEB ET NUMERIQUE Directeur technique : Lionel CAZAUMAYOU coins les plus confidentiels du Golfe di Orosei, il y en Chefs de projet et développeurs : Jean-Marc REYMUND a pour toutes les envies : nature préservée, stations assisté de Florian FAZER, Anthony GUYOT, Cédric balnéaires chics ou populaires, villages de vacances, petits MAILLOUX, Christophe PERREAU Animatrice Web : Caroline LOLLIEROU ports... L’intérieur des terres est plus étonnant encore. Il réserve des paysages à la diversité surprenante, en PUBLICITÉ grande partie de moyenne montagne à l'exception de la DIRECTION COMMERCIALE plaine de la Campina. -

Tesi Definitiva
SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI (Decreto Ministero dell’Università 31/07/2003) Via P. S. Mancini, 2 – 00196 - Roma TESI DI DIPLOMA DI MEDIATORE LINGUISTICO (Curriculum Interprete e Traduttore) Equipollente ai Diplomi di Laurea rilasciati dalle Università al termine dei Corsi afferenti alla classe delle LAUREE UNIVERSITARIE IN SCIENZE DELLA MEDIAZIONE LINGUISTICA L’INDIPENDENTISMO SARDO RELATORE CORRELATORI Prof.ssa Adriana Bisirri Prof.ssa Maria Nocito Prof. Wolfram Kraus Prof.ssa Claudia Piemonte CANDIDATO: MASSIMO MASCIA ANNO ACCADEMICO 2017/2018 1 Indice Introduzione ............................................................................................................................. 7 I. L’Indipendentismo sardo, o Sardismo ................................................................................ 10 I.1 Che cos’è l’Indipendentismo sardo? ............................................................................. 10 I.2 Differenza tra autonomismo e indipendentismo ........................................................... 10 I.3 L’insofferenza verso il “dominatore”, dall’Impero Romano ai Savoia ........................ 12 II. La perdita di autonomia della Sardegna sabauda .............................................................. 14 II.1 L’assegnazione del Regno di Sardegna al Duca di Savoia .......................................... 14 II.2 La Sarda Rivoluzione .................................................................................................. 17 II.2.a L’insurrezione cagliaritana del -

Sa Die De Sa Sardigna
IL MESSAGGERO SARDO Speciale Emigrazione 17 Secondo il programma il tema della promuovere il turismo senza parlare povertà è stato quindi trattato dal di agricoltura, di produzioni di Presidente delle ACLI Sardegna, eccellenza, di artigianato, di cultura. Ottavio Sanna, il quale ha fornito Oggi avrei dovuto parlare del G8, dati preoccupanti: “In Sardegna – ha ma purtroppo questo evento, come detto – 370 mila persone vivono in sapete non si svolgerà più in una situazione di povertà”. Sardegna e questo indubbiamente Sanna ha poi illustrato i contenuti ci penalizza perché erano previste della Carta di Zuri contro la povertà a La Maddalena 42 delegazioni (Zuri è una frazione di Ghilarza con straniere, 6 mila giornalisti appena 130 abitanti) ricordando che è accreditati, oltre 20 mila persone in nata da quattro anni di marce e rappresentanza dei vari Paesi. manifestazioni promosse dalle ACLI, La realizzazione delle opere e delle dalla CARITAS e dalle forze sindacali. infrastrutture ricettive comunque “Quest’anno il 15 maggio la marcia sono a buon punto e saranno la faremo a La Maddalena. completate – ha confermato Sannitu – Siamo solidali con l’Abruzzo – ha affermato – . L’auspicio è che possano ospitare in autunno il ma anche con i sardi della Maddalena”. G8 dell’Ambiente. La Maddalena e le 60 isole I temi della crisi, della disoccupazione dell’Arcipelago avevano un deficit strutturale di e le nuove povertà e del sostegno allo sviluppo ricettività, ma ora avranno alberghi a 5 stelle, il sono stati affrontati nei successivi interventi porto