01 Fabrique Di Gignod Valutazione D'impatto Archeologico DW REVCDD
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
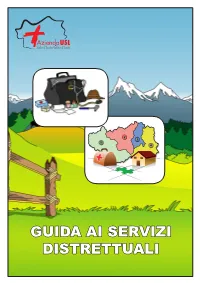
Guida Ai Servizi Distrettuali
GUIDA AI SERVIZI DISTRETTUALI 1. INTRODUZIONE I Distretti sono gli ambiti organizzativi territoriali per l’effettuazione di attività e l’erogazione di prestazioni di assisten- za sanitaria, di tutela e di promozione della salute, di prestazioni socio sanita- rie, di erogazioni dei servizi e delle prestazioni socio as- sistenziali, di integrazione tra servizi sanitari e servizi socio assistenziali. IL DISTRETTO È COSTITUITO AL FINE DI GARANTIRE: • l’assistenza primaria, ivi compresa la continuità assistenzia- le mediante il necessario coordinamento tra medici di medi- cina generale, pediatri di libera scelta, servizi di continuità assistenziale notturna e festiva, medici specialistici ambula- toriali • Il coordinamento dei medici di medicina generale e dei pe- diatri di libera scelta con le strutture operative a gestione diretta, nonchè con i servizi specialistici ambulatoriali ed i presidi ospedalieri ed extra ospedalieri accreditati • l’erogazione delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, connotate da specifica ed elevata integrazione • l’assistenza specialistica ambulatoriale • l’attività per la prevenzione e la cura delle tossicodipendenze • l’attività consulenziale per la tutela della salute dell’infan- zia, della donna e della famiglia • l’attività ed i servizi rivolti ai disabili e agli anziani 3 • l’attività ed i servizi di assistenza domiciliare integrata • l’attività ed i servizi per le patologie da HIV e per le patolo- gie terminali Al fine di garantire le attività ed i servizi sopradescritti i Distretti fanno capo ad un Direttore coadiuvato dai coordina- tori dei seguenti profili professiona- li: amministrativi, infermieri, direttore fisioterapisti, logopedisti, assistenti sanitari, oste- triche. L’integrazione fra le attività svolte dagli operatori afferenti al Distretto con gli al- tri servizi sanitari e sociali, caratterizza l’attività distrettuale. -
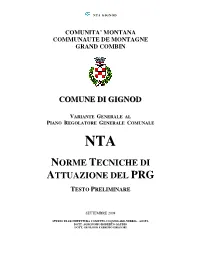
Norme Tecniche Di Attuazione Del Prg
NTA GIGNOD COMUNITA’ MONTANA COMMUNAUTE DE MONTAGNE GRAND COMBIN CCOOMMUUNNEE DDII GGIIGGNNOODD VARIANTE GENERALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE NTA NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PRG TESTO PRELIMINARE SETTEMBRE 2008 STUDIO DI ARCHITETTURA COMETTO-COQUILLARD-NEBBIA - AOSTA DOTT. AGRONOMO ROBERTO GAUDIO DOTT. GEOLOGO FABRIZIO GREGORI NTA GIGNOD TITOLO I - DISPOSIZIONI DIRETTIVE.........................................................5 Capo I- Fonti ............................................................................................................5 Art. 1 (Terminologia).................................................................................................................... 5 Art. 2 (Modalità di lettura del PRG) ............................................................................................ 5 Art. 3 (Piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico - PRG) ....................... 6 Art. 4 (Contenuti del PRG)........................................................................................................... 6 Art. 5 (Elaborati costituenti il PRG) ............................................................................................ 6 Capo II- Disposizioni generali ................................................................................. 9 Art. 6 (Infrastrutture e servizi ).................................................................................................... 9 Art. 7 (Strumenti attuativi del PRG)......................................................................................... -

Allegato a – Esenzione Per I Terreni Agricoli Ricadenti in Aree Montane O Di Collina Delimitate Ai Sensi Dell’Art.15 Della Legge 27 Dicembre 1977, N.984
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTA REGION AUTONOME DE LA VALLEE D’AOSTE COMUNE DI COMMUNE DE VALPELLINE ICI INDIVIDUAZIONE VALORE MEDIO DEI TERRENI EDIFICABILI AI FINI DEL PAGAMENTO DELL’ICI Sindaco Geom. Claudio RESTANO Tecnico incaricato Arch. Edi VUILLERMOZ Sett. 2010 Comune di Valpelline – Stima dei terreni ai fini ICI - arch. E. Vuillermoz SOMMARIO 0. Premessa ................................................................................................................................. 3 1. Riferimenti Legislativi .............................................................................................................. 4 2. Analisi della situazione urbanistica del Comune e degli ambiti inedificabili ................................ 12 a. Descrizione sommaria del territorio Comunale .................................................................. 12 Inquadramento geografico-fisico del territorio ...................................................................... 12 Inquadramento geomorfologico, geologico ed idrologeologico ............................................. 13 Inquadramento dei valori paesaggistici, naturalistici, monumentali ed archeologici .............. 14 Inquadramento urbanistico e territoriale (PTP) ..................................................................... 17 b. Individuazione delle zone considerate edificabili dal piano regolatore ............................... 18 c. Norme tecniche d’attuazione ............................................................................................ 20 -
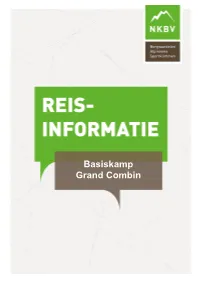
Basiskamp Grand Combin
Basiskamp Grand Combin GEBIED Aan de noordkant van het Valle d’Aosta liggen langs de grens met Zwitserland de Penninische Alpen, ook wel Italiaanse Walliser Alpen genoemd. Van west naar oost liggen een zestal dalen die aan de noordkant telkens worden afgesloten door vierduizenders. Het Valpelline is vanuit het westen gezien het tweede dal, een schitterend en weinig toeristische vallei, aan de voet van de Dent d’Herens. Iets westelijker en snel te bereiken ligt de Valle del Gran San Bernardo aan de voet van de Grote Sint- Bernardpas. De Alta Via 1, bijgenaamd het pad der giganten loopt door het Valpelline en verbind Gressoney-Saint-Jean in het oosten en Courmayeur in het westen. CAMPING Dit basiskamp wordt gehouden op: Camping Grand Combin R. Ansermin ‘DoDo’ Loc. Prailles 12 I-11010 Valpelline. Valle d'Aosta www.grandcombin.com De terrascamping (1000 m), is schitterend en rustig gelegen in een boomgaard 12 kilometer van Aosta. Het terrein is geschikt voor caravans en bij tijdige reservering is er stroomaansluiting te krijgen. De sanitaire voorzieningen zijn goed. Warme douches en wasmachine zijn aanwezig. Op de camping bevindt zich een winkeltje, een recreatieruimte met tv en een bar. Op ons veld is er gratis WiFi beschikbaar. Op het terrein is speelgelegenheid voor de kinderen waaronder tafeltennis en tafelvoetbal. Sinds enkele jaren heeft de camping een eigen openluchtzwembad met ligweide. Auto’s worden buiten de camping geparkeerd. Voor winkels en restaurants kun je terecht in het dorp Valpelline of in Aosta. In Aosta vind je ook een openlucht- en overdekt zwembad. REISROUTE Auto: Door Zwitserland via Basel – Bern - Freiburg langs het meer van Genève naar Martigny. -

Episodio Di Col Du Mont Fornet, Valgrisenche, 26.01.1945
EPISODIO DI COL DU MONT FORNET, VALGRISENCHE, 26.01.1945 Nome del compilatore: MARISA ALLOID I. STORIA Località Comune Provincia Regione Col du Mont Valgrisenche Valle d’Aosta / Vallée Fornet d’Aoste Data iniziale: 26 Gennaio 1945 Data finale: 26 Gennaio 1945 Vittime decedute: Totale U Ba Ragaz Adult Anzia s.i. D. Bambi Ragazze Adult Anzian S. Ig mbi zi (12- i (17- ni (più ne (0- (12-16) e (17- e (più i n ni 16) 55) 55) 11) 55) 55) (0- 11) 35 35 35 Di cui Civili Partigiani Renitenti Disertori Carabinieri Militari (RSI) Sbandati 33 2 Prigionieri di guerra Antifascisti Sacerdoti e religiosi Ebrei Legati a partigiani Indefinito Elenco delle vittime decedute I dati si riferiscono al momento della tragedia sotto al Col du Mont e sono desunti dalla schede personali dell’Archivio della Cogne di Aosta, controllati, laddove possibile, con quelli delle Anagrafi dei Comuni. 1. Giovanni ALLONZI, nato a Lonigo (Vicenza) il 26 giugno 1905. Residente a Sarre, Fochat, n. 30. Operaio Cogne, gruista ai servizi elettrici. Coniugato, padre di quattro figli (due femmine, due maschi) 2. Pietro ANGIARI, nato a San Germano dei Berici (Vicenza) il 22 agosto 1907. Residente a Quart, Villair, n. 93. Operaio Cogne, aiuto fonditore nelle acciaierie. Coniugato, padre di quattro figli (due femmine, due maschi) 3. Emiro BIANQUIN, nato a Pollein (Valle d’Aosta) il 14 maggio 1910. Residente a Pollein, n. 39. Operaio Cogne, manovratore arrivi e spedizioni. Coniugato, padre di un ragazzo e di una ragazza. 4. Sylvain BICH, nato a Die (Francia) il 22 agosto 1925. -

La VIOLENZA Sulle DONNE
Giornata Internazionale contro la VIOLENZA sulle DONNE 25 N O V E M B R E 2019 PROGRAMMA Progetto grafico di Margherita Cosentino, Gaia Crecca e Miriam Slaviero • Liceo Artistico di Aosta Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne Dal 1° al 30 novembre Aymavilles ILLUMINAZIONE DEL CASTELLO Zonta Club Aosta Valley Novembre e dicembre 2019 - marzo 2020 Tutto il territorio regionale POUR LES FEMMES Il progetto è indirizzato a tutti i Comuni valdostani e prevede un’azione simbolica di posizionamento contro ogni tipo di violenza di genere. Ogni Comune, secondo modalità da concordare con l’Associazione Donne Lati- no-Americane, sarà invitato ad individuare una specifica panchina sul pro- prio territorio, che sarà dipinta di rosso da una delegazione del Consiglio comunale e dai bambini delle scuole. Seguirà un percorso di sensibilizza- zione sul tema della violenza di genere in cui potranno essere coinvolti gli studenti delle scuole secondarie di primo o secondo grado, le proloco o altri attori presenti sul territorio Celva – Consorzio degli Enti Locali Valle d’Aosta in collaborazione con: Stati Generali delle Donne, Stati Generali delle Donne Valle d’Aosta, Assessorato regionale all’Istruzione, Università, Ricer- ca e Politiche giovanili, Ufficio Consigliera regionale di Parità, Associazione Donne Latino-Americane Valle d’Aosta “Uniendo Raices” Onlus Dal 6 all’11 novembre Aosta • Biblioteca regionale/Foyer, via Torre del Lebbroso, 2 100 DONNE PER LA STORIA - mostra fotografica Iniziativa itinerante per le celebrazioni del Centenario -

CAMPIONATO VALDOSTANO INDIVIDUALE "L'omo" N° Vittorie Atleta 8 Bruno 1957 CURTAZ RENZO 7 Renzo 1958 CURTAZ RENZO 4 Or
CAMPIONATO VALDOSTANO INDIVIDUALE "L'OMO" n° vittorie Atleta 8 Bruno 1957 CURTAZ RENZO Chevrot 7 Renzo 1958 CURTAZ RENZO Chevrot 4 Orlando 1959 CURTAZ RENZO Chevrot 4 Riccardo 1960 CURTAZ RENZO Chevrot 4 Paolo 1961 BONDAZ ALBERTO Valpelline 2 Fabrizio 1962 CURTAZ RENZO Chevrot 2 Vilmo 1963 COTTINO FRANCESCO Gressan 2 Rudy 1964 CURTAZ RENZO Chevrot 2 David 1965 CURTAZ RENZO Chevrot 1 Alberto 1966 COTTINO EZIO Gressan 1 Francesco 1967 TRUC SILVIO Gressan 1 Ezio 1968 BORNAZ RICCARDO Chevrot 1 Silvio 1969 FRACHEY ORLANDO Gressan 1 Onorato 1970 MONTROSSET ONORATO Jovencan 1 Aurelio 1971 BIANQUIN AURELIO Charvensod 1 Martino 1972 BRUN MARTINO Charvensod 1 Aldo 1973 BORNAZ RICCARDO Chevrot 1 Tivo 1974 BORNAZ RICCARDO Chevrot 1 Mario 1975 BORNAZ RICCARDO Chevrot 1 Ovidio 1976 FRACHEY ORLANDO Gressan 1 Pierangelo 1977 FRACHEY ORLANDO Gressan 1 Alex 1978 NEX BRUNO Doues Jovencan 1 Andrea 1979 NEX BRUNO Doues Charvensod 1980 COTTINO ALDO Gressan 159/15 Chevrot 1981 FRACHEY ORLANDO Gressan Gressan/chiesa 1982 NEX BRUNO Doues Ollomont 49 1983 VOYAT TIVO Chevrot Autoporto 1984 VEVEY MARIO Ollomont 193/15 Cogne/S.Orso 1985 NEX BRUNO Doues 196/15 Pollein/Grand place 1986 GLASSIER OVIDIO Ollomont 207/15 Aymavilles/Ozein 1987 NEX BRUNO Doues 139/10 Gressan/Iles 1988 VIERIN FABRIZIO Charvensod 132 Doues/sospesa/campi regionali 1989 IMPERIAL VILMO Chevrot 149 campi regionali Brissogne 1990 NEX BRUNO Doues 144 1991 NEX BRUNO Doues 142 1992 PIEROPAN PAOLO Gressan 147 1993 NEX BRUNO Doues 134 1994 IMPERIAL VILMO Chevrot 146 1995 PIEROPAN PAOLO Gressan 140 1996 -

Lacommunautédu Grand-Combin Adresse
lacommunautédu Grand-Combin Adresse Anno 28 – Numero 3 – maggio-giugno 2011 – Aut.Trib.di Aosta n.12/85 del 29-11-85 Spedizione in Abbonamento Postale 70% – Legge 662/96DBC lacommunautédugrand-combin 1 NUMERI UTILI COMUNITÀ MONTANA La Festa della Natura Comunità Montana Ufficio del Turismo Communauté de Montagne di Etroubles Espressione della collaborazione Grand-Combin Strada Nazionale del G. S. Bernardo, 13 - Etroubles Chez Roncoz, 29/I - Gignod tel. 0165 78 559 - fax 0165 78 568 fra Istituzione scolastica e Corpo Forestale tel. 0165 25 66 11 - fax 0165 25 66 36 [email protected] - [email protected] [email protected] www.lovevda.it www.grancombin.vda.it COMUNI Gignod Cuaz Damiano ...................................................tel. 348 8724555 Allein .................................................................................................tel. 0165.78266 Ollomont Créton Claudio ..............................................tel. 338 3290059 Bionaz ..............................................................................................tel. 0165.730106 Oyace Chenal Valter .........................................................tel. 339 8521749 Doues ..............................................................................................tel. 0165.738042 Roisan Falconero Davide .............................................tel. 329 2106268 Etroubles .......................................................................................tel. 0165.789101 Saint-Oyen Proment Natalino .................................tel. -

1.ORIGINE DEI RUS E DEI LORO SENTIERI La
Studio di fattibilità per la valorizzazione del percorso lungo l’antico “Ru – Neuf” nei Comuni di Gignod e Etroubles 1.ORIGINE DEI RUS E DEI LORO SENTIERI La Valle d’Aosta, con le sue cime e i suoi ghiacciai perenni, possiede una straordinaria ricchezza idrica ma, paradossalmente a causa della sua struttura geomorfologica molto complessa non permette a tale elemento di raggiungere territori esposti a sud o in alcune zone collinari. Circa l’ottanta per cento del territorio è al di sopra dei 1500 metri , dato molto significativo, e che la dice lunga sul fatto che l’agricoltura in Valle è notevolmente penalizzata dall’altitudine e dai suoi versanti molto acclivi. Ecco perchè i cosidetti ruscelli più conosciuti da noi col termine francese “Ru” sono il mezzo e la soluzione con cui i valdostani hanno potuto creare zone fertili che altrimenti oggi sarebbero aride e di conseguenza abbandonate dalla popolazione locale. Oltre ai “Ru” stessi furono e sono di fondamentale importanza le piste o i sentieri che li costeggiano il più delle volte originati dal deposito dei materiali ricavati durante gli scavi per realizzazioni dei canali, e che in passato con la necessità di un controllo diretto sulle strutture irrigue o di prevenzione per eventuali furti d’acqua furono battute dai continui passaggi dei “garde ruisseaux” ovvero coloro che garantivano servizi di guardianeria. Oltre a facilitare tale servizio la pista serviva all’ordinaria manutenzione che avveniva tramite le “corvées” , ovvero forme di lavoro collettive atte al buon mantenimento e scorrimento dell’acqua all’interno del piccolo alveo. 2.SENTIERO “RU-NEUF” - OBIETTIVI E VALORIZZAZIONE In questo studio si vuole descrivere l’importanza di riqualificazione del sentiero che costeggia e accompagna il “Ru Neuf” nei Comuni di Gignod e Etroubles, . -

Table S1. List of the Monitored Municipalities in Aosta Valley in 2015–2019
Supplementary Table S1. List of the monitored municipalities in Aosta Valley in 2015–2019. 2015 2016 2017 2018 2019 No. No. No. No. No. Municipality Altitude Altitude Altitude Altitude Altitude Village Pheromone- Village Pheromone- Village Pheromone- Village Pheromone- Village Pheromone- (m asl) (m asl) (m asl) (m asl) (m asl) baited traps baited traps baited traps baited traps baited traps Allein 1 1310 1 1 1310 1 1 1310 1 1 1310 1 Antey - Saint - Andre 5 760 - 1340 5 5 760 - 1340 5 5 760 - 1340 5 5 760 - 1340 5 Aosta 3 878 - 1287 42 6 878 - 1535 45 7 932 - 1535 28 7 932 - 1535 28 7 932 - 1535 28 Arnad 3 495 - 1122 3 3 495 - 1122 3 3 495 - 1122 3 3 495 - 1122 3 Arvier 4 847 - 1306 4 4 847 - 1306 4 4 847 - 1306 4 4 847 - 1306 4 Avise 3 798 - 1265 3 3 798 - 1265 3 3 798 - 1265 3 3 798 - 1265 3 Aymavilles 6 753 - 1022 6 6 753 - 1022 6 6 753 - 1022 6 6 753 - 1022 6 Brusson 1 1127 1 1 1127 1 1 1127 1 1 1127 1 Challand - Saint - Anselme 5 926 - 1337 5 5 926 - 1337 5 5 926 - 1337 5 5 926 - 1337 5 Challand - Saint - Victor 4 838 - 1056 4 4 838 - 1056 4 4 838 - 1056 4 4 838 - 1056 4 Chambave 1 500 1 1 500 1 1 500 1 1 500 1 Champdepraz 5 395 - 1242 5 5 395 - 1242 5 5 395 - 1242 5 5 395 - 1242 5 Charvensod 1 690 1 1 690 1 1 690 1 1 690 1 Chatillon 6 724 - 1138 6 6 724 - 1138 6 6 724 - 1138 6 6 724 - 1138 6 Donnas 1 580 1 1 580 1 1 580 1 1 580 1 Doues 1 1125 1 1 1125 1 1 1125 1 1 1125 1 Emarese 3 911 - 1288 3 3 911 - 1288 3 4 911 - 1288 4 4 911 - 1288 4 Etroubles 1 1325 1 1 1325 1 1 1325 1 Fenis 1 1031 1 2 1031 - 1085 2 2 1031 - 1085 2 2 1031 - 1085 -

09-Cyclotour-Fietsroutes.Pdf
PONT-SAINT-MARTIN , CICLOTOUR 01 Pont-Saint-Martin – Gressoney-La-Trinité Recommended Period: 1st May - 31 October Departure: Pont-Saint-Martin (Piazza IV Novembre) Arrival: Gressoney-La-Trinité (End of road - Staffal) Difference in level: 1473 m Length 38,2 Km Duration going there: 2h10 The Val de Gressoney is the first you meet as you enter Val d’Aosta if you are coming from the Po Valley. The Valley starts at Pont-Saint-Martin and is wedged into a narrow corridor which then opens out in the sight of Monte Rosa, a spectacular mountain with 28 peaks above 4,000 metres and which is the natural boundary with Switzerland. Places you go through on the route: - Pont-Saint-Martin (345 m) - Lillianes 6.1 km (650 m) - Fontainemore 9.1 km (785 m) - Issime 12 km (950 m) - Gaby 17.4 (1,045 m) - Gressoney-Saint-Jean 25.2 km (1,420 m) - Gressoney-La-Trinité 33.3 km (1,640 m) - Stafal 38.2 km (1,800 m) Route included in a stage of the Giro d'Italia in 1995 (Briançon/Gressoney). Stage won by Ouchakov (UCR) VERRÈS , CICLOTOUR 02 Verrès – Saint-Jacques (Ayas) Recommended Period: 1st May - 31 October Departure: Verrès (Roundabout on the SS26 road) Arrival: Saint-Jaques (Ayas, end of road) Difference in level: 1301 m Length 31,6 Km Duration going there: 2h08 From Verrès you make your way upwards along the wide, sunny Valle d'Ayas which climbs 32 km alongside the mountain river of Evançon. The first town you come to is Challand-Saint-Victor where you can visit the remains of Villa Castle from the 10th century. -

Châteaux De La Vallée D'aoste
CHÂTEAUX DE LA VALLÉE D AOSTE A journey through’ history, art and nature The castles From the twelfth century, the local of the lords constructed fortified buildings for defensive purposes, such as the castles Aosta Valley: of Graines, Châtel-Argent and Cly, which perfectly exemplify the oldest style a thrilling journey of castle architecture. through time However, from the fourteenth century onwards, the architectural features serving to defensive purposes were superseded by monolithic structures, such as those of the castles of Ussel and Verrès, which were then gradually embellished with decorative features, as can be observed at the famous A significant and rich cultural heritage Fénis Castle among others. made up of castles, strongholds The stylistic evolution of the fortressin and historic buildings welcomes to a fine manor house is evident in the those visiting the Aosta Valley castles of Aymavilles and Issogne, whereas or travelling through. the abodes of Sarre and Savoy Castle of Indeed, the many castles scattered Gressoney-Saint-Jean are testimonies to along the region’s central valley the presence of the Savoy dynasty in the are of outstanding Aosta Valley and the artistic taste in vogue beauty and cultural interest. in that court. Built in strategic places to defend ancient lands, these castles In the summer, the magic of this places with their variety of styles is even greater as the castles become and architectural features are spectacular scenery for emotionally a valuable testimony to the history charged musical events. Guests are treated of the Aosta Valley. to refined and exclusive evenings as the events feature artists of national and international caliber.