Imp. La Mafia Imprenditrice 25-09-2007 12:26 Pagina 1
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

STRUTTURE Cosa Nostra E 'Ndrangheta a Confronto
STRUTTURE Cosa Nostra e ‘ndrangheta a confronto Francesco Gaetano Moiraghi Andrea Zolea WikiMafia – Libera Enciclopedia sulle Mafie www.wikimafia.it Strutture: Cosa Nostra e ‘ndrangheta a confronto, di Francesco Gaetano Moiraghi e Andrea Zolea La mafia dura da decenni: un motivo ci deve essere. Non si può andare contro i missili con arco e frecce: in queste vicende certe intemperanze si pagano duramente. Con il terrorismo, con il consenso sociale, potevi permettertele: con la mafia non è così. Nella società c’è un consenso distorto. Altro che bubbone in un tessuto sociale sano. Il tessuto non è affatto sano. Noi estirperemo Michele Greco, poi arriverà il secondo, poi il terzo, poi il quarto. Giovanni Falcone 1 www.wikimafia.it Strutture: Cosa Nostra e ‘ndrangheta a confronto, di Francesco Gaetano Moiraghi e Andrea Zolea PREMESSA Questo lavoro ha lo scopo di offrire uno sguardo d’insieme sulle articolazioni strutturali delle organizzazioni mafiose denominate Cosa nostra e ‘ndrangheta . La prima sezione, curata da Francesco Gaetano Moiraghi, si concentra sull’analisi di Cosa nostra. La seconda sezione, che sposta il focus sulla ‘ndrangheta, è curata da Andrea Zolea. Come si potrà notare, le due sezioni non sono state realizzate secondo uno stesso modello, ma analizzano le due organizzazioni con un approccio differente. Ad esempio, la parte su Cosa nostra avrà un orientamento maggiormente diacronico, diversamente da quella sulla ‘ndrangheta, basata su un approccio sincronico. Il presente testo ha infatti l’obiettivo di offrire due proposte di analisi differenti che riescano a mettere in luce le analogie e le differenze delle strutture delle due organizzazioni mafiose. -

Mafie a Milano E in Lombardia
LIBERA. ASSOCIAZIONI, NOMI E NUMERI CONTRO LE MAFIE COORDINAMENTO PROVINCIALE DI MILANO Via della Signora, 3 - 20122 Milano Tel. 02/7723210 - Fax 02/780968 E-mail: [email protected] Web: www.libera.it e www.liberamilano.it www.facebook.com/LiberaMi LIBERA. ASSOCIAZIONI, NOMI E NUMERI CONTRO LE MAFIE Presenta Mafie a Milano e in Lombardia un sintetico report aggiornato al 19 ottobre 2013 settima edizione A cura del Coordinamento provinciale di Milano 1 La presente documentazione del fenomeno mafioso a Milano e in Lombardia dalle origini ai giorni nostri vuol essere uno strumento che favorisca la riflessione sul fatto che la criminalità organizzata (in particolare la ’ndrangheta) è profondamente radicata nel nostro territorio contribuendo in modo massiccio a fenomeni quali minacce, estorsioni, riciclo di denaro, gioco d’azzardo, usura, racket, appalti e subappalti illegali. LIBERA auspica che i docenti, gli studenti delle Scuole superiori e delle Università, i commercianti, gli imprenditori, i liberi professionisti e i cittadini ne ricevano uno stimolo alla conoscenza del fenomeno e alla responsabilità nella prospettiva di un'Italia più civile e aperta al futuro Avvertenza Nel presente documento vengono citate alcune inchieste giudiziarie concluse e altre non ancora passate al vaglio giudiziario. Tutte le persone coinvolte e/o citate a vario titolo, anche se condannate in primo grado sono da ritenersi innocenti fino a sentenza definitiva. Nata nel 1995, LIBERA è un’associazione di associazioni che, ad oggi, raccoglie più di 1500 adesioni, tra le grandi associazioni nazionali ed i piccoli gruppi locali ed ha riferimenti in tutte le regioni d’Italia. Elemento unificante è la consapevolezza che per sconfiggere le mafie l’azione repressiva dei Corpi dello Stato è necessaria ma non sufficiente. -

Commissione Parlamentare Di Inchiesta Sul Fenomeno Della Mafia in Sicilia 1976: La Relazione
Storia e memoria COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA 1976: LA RELAZIONE DI MINORANZA DI PIO LA TORRE E CESARE TERRANOVA* a cura di Sarah Mazzenzana Abstract For the ninetieth anniversary of the birth of Pio La Torre, the Review proposes in this section the minority report dated 4 February 1976. The report was drawn up by the deputy La Torre, together with the judge Terranova and it was endorsed by deputies Benedetti, Malagugini and by senators Adamoli, Chiaromonte, Lugnano e Maffioletti by the end of the legislature. The Review publishes the report fully, excluding the annexes. The document highlights limits, inconsistencies and reticence present within the majority report of the parliamentary Antimafia Commission, chaired by senator Carraro. The minority report focused in particular on the topic omitted by the majority: the interchange between mafia and politics. Furthemore, the report contains the legislative proposals that have become law in 1982 (Law Rognoni-La Torre), just after the murders of Pio La Torre and Carlo Alberto dalla Chiesa. Keywords: Pio La Torre; Sicily, mafia and politics, 1976, parliamentary Antimafia Commission In occasione del novantesimo anniversario dalla nascita di Pio La Torre, e in sintonia con numerose celebrazioni istituzionali, la Rivista propone, all’interno di questa sezione, un documento il cui valore storico, politico e giudiziario è stato riconosciuto solo a distanza di anni. Si tratta della Relazione di minoranza datata 4 febbraio 1976, redatta dall’onorevole Pio La Torre, insieme al giudice Cesare Terranova e sottoscritta dai deputati Benedetti, Malagugini, e dai senatori Adamoli, Chiaromonte, Lugnano e Maffioletti alla fine della VI Legislatura. -

Società E Cultura 65
Società e Cultura Collana promossa dalla Fondazione di studi storici “Filippo Turati” diretta da Maurizio Degl’Innocenti 65 1 Manica.indd 1 19-11-2010 12:16:48 2 Manica.indd 2 19-11-2010 12:16:48 Giustina Manica 3 Manica.indd 3 19-11-2010 12:16:53 Questo volume è stato pubblicato grazie al contributo di fondi di ricerca del Dipartimento di studi sullo stato dell’Università de- gli Studi di Firenze. © Piero Lacaita Editore - Manduria-Bari-Roma - 2010 Sede legale: Manduria - Vico degli Albanesi, 4 - Tel.-Fax 099/9711124 www.lacaita.com - [email protected] 4 Manica.indd 4 19-11-2010 12:16:54 La mafia non è affatto invincibile; è un fatto uma- no e come tutti i fatti umani ha un inizio e avrà anche una fine. Piuttosto, bisogna rendersi conto che è un fe- nomeno terribilmente serio e molto grave; e che si può vincere non pretendendo l’eroismo da inermi cittadini, ma impegnando in questa battaglia tutte le forze mi- gliori delle istituzioni. Giovanni Falcone La lotta alla mafia deve essere innanzitutto un mo- vimento culturale che abitui tutti a sentire la bellezza del fresco profumo della libertà che si oppone al puzzo del compromesso, dell’indifferenza, della contiguità e quindi della complicità… Paolo Borsellino 5 Manica.indd 5 19-11-2010 12:16:54 6 Manica.indd 6 19-11-2010 12:16:54 Alla mia famiglia 7 Manica.indd 7 19-11-2010 12:16:54 Leggenda Archivio centrale dello stato: Acs Archivio di stato di Palermo: Asp Public record office, Foreign office: Pro, Fo Gabinetto prefettura: Gab. -

Archivio Nisseno N. 3
Associazione “Officina del libro Luciano Scarabelli” - Caltanissetta ARCHIVIO NISSENO Rassegna di storia, lettere, arte e società Anno II - N. 3 Luglio-Dicembre 2008 Paruzzo Printer editore - Caltanissetta 1 ARCHIVIO NISSENO Rassegna semestrale di storia, lettere, arte e società dell’Associazione “Officina del libro Luciano Scarabelli” di Caltanissetta Anno II - N. 3 Luglio-Dicembre 2008 2 Torniamo a parlare dei Fasci dei Lavoratori. La drammatica vicenda dei Fasci dei Lavoratori in Sicilia rappresenta la fase conclusiva di un lungo processo di crisi che si manifestò nel distorto svi- luppo dell’economia siciliana dell’Ottocento e nelle forme che assunse la politica a livello delle amministrazioni locali ma anche a livello nazionale. Se si guarda bene alle cause di questa crisi, molte di esse vanno individua- te nel mancato “governo” dei processi che determinarono una aberrante ridi- stribuzione della grande proprietà fondiaria. L’idea che fu alla base dell’ever- sione delle terre feudali (1812) e delle ricorrenti confische delle terre eccle- siastiche, cioè che si potesse creare una piccola proprietà contadina attraver- so la quotizzazione delle proprietà divenute demaniali, fallì miseramente a causa dell’ingordigia dei proprietari terrieri che aggirarono in tanti modi la legge, grazie anche alla connivenza del potere politico. Si andò così determinando, specialmente dal 1860 in poi, una situazione paradossale: la ridistribuzione delle terre, che era una delle grandi aspirazio- ni dei contadini siciliani alimentata anche dalle promesse di Garibaldi, non solo non si realizzò nei modi sperati, ma divenne un grande inganno che determinò un progressivo impoverimento del mondo contadino e braccianti- le, fino a giungere alle condizioni di estremo degrado e di miseria dei primi anni ‘90. -

Organizovaný Zločin V První Polovině 20. Století
Západo česká univerzita v Plzni Fakulta filozofická Diplomová práce Organizovaný zlo čin v první polovin ě 20. století Kokaislová Lucie Plze ň 2014 Západo česká univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra historických v ěd Studijní program Historické v ědy Studijní obor Moderní d ějiny Diplomová práce Organizovaný zlo čin v první polovin ě 20. století Kokaislová Lucie Vedoucí práce: PhDr. Roman Kodet, Ph.D. Katedra historických v ěd Fakulta filozofická Západo české univerzity v Plzni Plze ň 2014 Prohlašuji, že jsem práci vypracoval(a) samostatn ě a použil(a) jen uvedených pramen ů a literatury. Plze ň, duben 2014 ......................................... Obsah Úvod .................................................................................................................. 5 1 Italská mafie................................................................................................ 11 1.1. Sicilská mafie ........................................................................................................... 13 1.1.1. Pojem, struktura a inicia ční rituál ..................................................................... 14 1.1.2. Otázka vzniku a p ůvodu, a dokumenty popisující uskupení podobná mafii ...... 17 1.1.3. Vývoj .................................................................................................................. 20 1.2. Camorra ................................................................................................................... 25 1.2.1. P ůvod, pojem, inicia ční rituál a struktura -
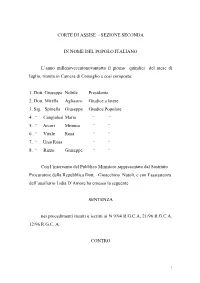
Processo Lima
CORTE DI ASSISE - SEZIONE SECONDA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO L’anno millenovecentonovantotto il giorno quindici del mese di luglio, riunita in Camera di Consiglio e così composta: 1. Dott. Giuseppe Nobile Presidente 2. Dott. Mirella Agliastro Giudice a latere 3. Sig. Spinella Giuseppe Giudice Popolare 4. “ Cangialosi Maria “ “ 5. “ Arceri Mimma “ “ 6. “ Vitale Rosa “ “ 7. “ Urso Rosa “ “ 8. “ Rizzo Giuseppe “ “ Con l’intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Sostituto Procuratore della Repubblica Dott. Gioacchino Natoli, e con l’assisstenza dell’ausiliario Lidia D’Amore ha emesso la seguente SENTENZA nei procedimenti riuniti e iscritti ai N 9/94 R.G.C.A, 21/96 R.G.C.A. 12/96 R.G.C. A. CONTRO 1 1) RIINA Salvatore n. Corleone il 16.11.1930 Arrestato il 18.01.1993 - Scarcerato il 05.05.1997 LIBERO- Detenuto per altro - Assente per rinunzia Assistito e difeso Avv. Cristoforo Fileccia Avv. Mario Grillo 2) MADONIA Francesco n. Palermo il 31.03.1924 Arrestato il 21.04.1995 - Scarcerato il 05.05.1997 LIBERO - Detenuto per altro - Assente per Rinunzia Assistito e difeso Avv. Giovanni Anania Avv. Nicolò Amato del foro di Roma 3) BRUSCA Bernardo n. San Giuseppe Jato il 09.09.1929 Arrestato il 21.10.1992 - Scarcerato il 05.05.1997 LIBERO - Detenuto per altro - Assente per Rinunzia Assistito e difeso Avv. Ernesto D’Angelo 4) BRUSCA Giovanni n. San Giuseppe Jato il 20.02.1957 Arrestato il 23.05.1996 - Scarcerato il 10.04.1998 LIBERO - Detenuto per altro - Assente per Rinunzia Assistito e difeso Avv. Luigi Li Gotti del foro di Roma Avv. -

Leggi, Scrivi E Condividi Le Tue 10 Righe Dai Libri
leggi, scrivi e condividi le tue 10 righe dai libri http://www.10righedailibri.it Cuori rossi contro cuori neri 1-576_Cuori rossi contro cuori neri 1-576 07/02/12 17.32 Pagina 3 I volti della storia 224 Cuori rossi contro cuori neri 1-576_Cuori rossi contro cuori neri 1-576 07/02/12 17.32 Pagina 4 Titolo originale: The Evolution of God Copyright © 2009 by Robert Wright This edition published by arrangement with Little, Brown and Company, New York, USA All rights reserved Traduzione dall’inglese di Valeria Leotta Prima edizione: febbraio 2012 © 2012 Newton Compton editori s.r.l. Roma, Casella postale 6214 ISBN 978-88-541-3577-2 www.newtoncompton.com Realizzazione a cura di Corpotre, Roma Stampato nel febbraio 2012 da Puntoweb s.r.l., Ariccia (Roma) su carta prodotta con cellulose senza cloro gas provenienti da foreste controllate e certificate, nel rispetto delle normative ecologiche vigenti Cuori rossi contro cuori neri 1-576_Cuori rossi contro cuori neri 1-576 07/02/12 17.32 Pagina 5 Paolo Sidoni - Paolo Zanetov Cuori rossi contro cuori neri Storia segreta della criminalità di destra e di sinistra Newton Compton editori Cuori rossi contro cuori neri 1-576_Cuori rossi contro cuori neri 1-576 07/02/12 17.32 Pagina 7 Introduzione Con un aforisma Bertolt Brecht si chiedeva se fosse più criminale fondare una banca oppure rapinarla. Il quesito del drammaturgo tedesco, insignito nel 1954 del premio Lenin per la pace, era ovviamente retorico: costituire un istituto finanziario, simbolo e strumento dell’oppressione del grande ca - pitale sui lavoratori, era a suo parere mille volte più delinquenziale. -

Zerohack Zer0pwn Youranonnews Yevgeniy Anikin Yes Men
Zerohack Zer0Pwn YourAnonNews Yevgeniy Anikin Yes Men YamaTough Xtreme x-Leader xenu xen0nymous www.oem.com.mx www.nytimes.com/pages/world/asia/index.html www.informador.com.mx www.futuregov.asia www.cronica.com.mx www.asiapacificsecuritymagazine.com Worm Wolfy Withdrawal* WillyFoReal Wikileaks IRC 88.80.16.13/9999 IRC Channel WikiLeaks WiiSpellWhy whitekidney Wells Fargo weed WallRoad w0rmware Vulnerability Vladislav Khorokhorin Visa Inc. Virus Virgin Islands "Viewpointe Archive Services, LLC" Versability Verizon Venezuela Vegas Vatican City USB US Trust US Bankcorp Uruguay Uran0n unusedcrayon United Kingdom UnicormCr3w unfittoprint unelected.org UndisclosedAnon Ukraine UGNazi ua_musti_1905 U.S. Bankcorp TYLER Turkey trosec113 Trojan Horse Trojan Trivette TriCk Tribalzer0 Transnistria transaction Traitor traffic court Tradecraft Trade Secrets "Total System Services, Inc." Topiary Top Secret Tom Stracener TibitXimer Thumb Drive Thomson Reuters TheWikiBoat thepeoplescause the_infecti0n The Unknowns The UnderTaker The Syrian electronic army The Jokerhack Thailand ThaCosmo th3j35t3r testeux1 TEST Telecomix TehWongZ Teddy Bigglesworth TeaMp0isoN TeamHav0k Team Ghost Shell Team Digi7al tdl4 taxes TARP tango down Tampa Tammy Shapiro Taiwan Tabu T0x1c t0wN T.A.R.P. Syrian Electronic Army syndiv Symantec Corporation Switzerland Swingers Club SWIFT Sweden Swan SwaggSec Swagg Security "SunGard Data Systems, Inc." Stuxnet Stringer Streamroller Stole* Sterlok SteelAnne st0rm SQLi Spyware Spying Spydevilz Spy Camera Sposed Spook Spoofing Splendide -

Nel Triangolo Mafia-Bische-Polizia Un Cadavere
l'Unità / demanica 6 luglio 1969 PAG. 7 / cronache Di i per maturità t abilitaiiom Lo scandalo delle roulette protette dai questori porta alla luce oscuri e sanguinosi retroscena Il banco Nel triangolo mafia-bische-polizia un cadavere di prova «suicidato» per la guerra fra le cosche rivali Illuminanti rapporti della Finanza - Il gioielliere Ortona aveva una dei colloqui stanza insieme ad Angelo La Barbera - Il boss visto entrare nel ne Fiori di Borman a Gagarin gozio della vittima accompagnato da Rosario Mancino - Una revol verata durante il « vertice » dei mafiosi - Il « barone »: si è sparato 3355 commissioni e 232 mila candidati Il procuratore: è stato un delitto - Riaperte le indagini sul caso? allo prese con i nuovi criteri degli orali Un triangoli»: malia-bische-poliria. Uno scandalo enorme fra arresti, dimis sioni, bustarelle di milioni e affari di miliardi. Anche un morto. E ora, dopo setta Mancano poche ore all'inizio dei colloqui che competeranno anni, si torna a parlare di quella revolverata, e di tutte le circostanze che allora gli esami di maturità e di abilitazione. Domani mattina la legarono a uno stesso filo 1 personaggi che adesso sono sul banco degli accusati Gli maggior parte delle 3355 commissioni sparse in tutti i licei stessi nomi: manosi, poliziotti e biscazzieri. Il morto è Corrado Ortona, il gioielliere • gli istituti tecnici e magistrali d'Italia daranno il \ia ai amante della Naccarato trovato ucciso con un proiettile nel cuore, il 27 aprile del € nuovi orali > secondo criteri diramati dal ministero appena «2. I mafiosi sono alcuni l'aprile acorso. -

LA MAFIA PALERMITANA Fazioni, Risorse, Violenza (1943-1993)
EDIZIONI LA MAFIA PALERMITANA Fazioni, risorse, violenza (1943-1993) di Vittorio Coco Coco, Vittorio <1980-> La mafia palermitana / Vittorio Coco – Palermo : Centro di studi ed iniziative culturali Pio La Torre, 2010. (Collana studio e ricerca) 1. Mafia - Palermo - 1943-1993. 364.10609458231 CDD-21 SBN Pal0224465 CIP – Biblioteca centrale della Regione siciliana “Alberto Bombace” Comitato Scientifico: Prof. Guido Corso, Prof. Alessandra Dino e Prof. Salvatore Lupo. 5 Nota editoriale di Vito Lo Monaco, Presidente Centro Pio La Torre 7 Prefazione di Salvatore Lupo, storico 9 Introduzione 11 Il contesto La Piana dei Colli e lo sviluppo urbano di Palermo dal secondo dopoguerra Parte Prima Tra gli anni Cinquanta e Sessanta. Al centro della ripresa postbellica 23 Mafia ed edilizia: il costruttore Francesco Vassallo 31 L’ascesa di Angelo La Barbera 39 Da una guerra all’altra Parte Seconda Tra gli anni Settanta e Ottanta. Ai margini dopo l’antimafia 45 La perdita della centralità 51 Al fianco dei corleonesi 55 Dal maxi-processo alla riconquista dell’autonomia 61 Indice dei nomi 65 Indice dei luoghi di Vito Lo Monaco La ricerca di Vittorio Coco, a seguito di un bando pubblico del Centro Studi Pio La Torre che ha impegnato parte del contributo finanziario della Regione Sicilia, fa parte di un insieme di studi in via di pubblicazione. Per un anno tra il 2008 e il 2009 sei giovani ricercatori, guidati volontariamente da rispettivi comitati scientifici e tutor di alto profilo, hanno lavorato con tanto profitto da convincere il Centro a proseguire la ricerca nel 2010. L’idea generale della ricerca riguarda l’esplorazione della complessità del fenomeno ma- fioso tramite l’osservazione della storia e del rapporto col territorio di “famiglie” le cui relazioni interne ed esterne circoscrivono la natura specifica dell’organizzazione mafiosa e il suo rapporto organico con le classi dirigenti. -

STUDI STORICI SICILIANI LUGLIO 2015 Documento In
STUDI STORICI SICILIANI SEMESTRALE DI RICERCHE STORICHE SULLA SICILIA Anno II n. II - Fasc. II Luglio 2015 SOMMARIO L'occhio sinistro di Pietro d'Asaro di Gero Difrancesco pag. 3 La Cirenaica “greca”: storia, arte, archeologia di Mario Siragusa pag. 8 La verità su El Alamein - Operazioni di controspionaggio di Maria R. Sinatra pag. 14 Mussomeli terra di feudo. Lotte del movimento democratico mussomelese e gli appunti di Giuseppe Palumbo di Filippo Falcone pag. 18 Filippo Scroppo da Riesi a Torre Pellice… e ritorno di Attilio Gerbino pag. 37 Liberali e clericali in due collegi della profonda Sicilia: Le Petralie e Cefalù di Mario Siragusa pag. 45 Anticipazione: La caduta del governo Parri e l'autunno della Resistenza di Michelangelo Ingrassia pag. 55 Li Destri e Ventimiglia a Gangi Il CREM pag. 57 Recensione: Il nuovo libro di Gero Difrancesco “Storie Scordate” di Filippo Falcone pag. 60 ARCHEOCLUB D’ITALIA STUDI STORICI SICILIANI SEMESTRALE DI RICERCHE STORICHE SULLA SICILIA Anno II n. II - Fasc. II Luglio 2015 Disegno di Giuseppe A. Scarpa ARCHEOCLUB D’ITALIA COMITATO SCIENTIFICO: Gero Difrancesco (Presidente), Mario Siragusa, Gabriella Portalone, Filippo Falcone, Gaetano La Placa DIRETTORE RESPONSABILE: Filippo Falcone DIRETTORE EDITORIALE: Mario Siragusa SEDE: Archeoclub d’Italia sede di Gangi, C.da Montededero, Geraci Siculo (Pa) CONTATTI: 339 2032093 - comitatoenginomadonita.altervista.org/CREM/ STUDI STORICI SICILIANI - Semestrale di ricerche storiche sulla Sicilia L’OCCHIO “SINISTRO” DI PIETRO D’ASARO di Gero Difrancesco n pomeriggio trascorso a Racalmuto a pas- Useggiare in compagnia di Enzo Sardo, stu- dioso di storia locale ma anche politico impegnato nelle fila del movimento cattolico, riempie sempre e piacevolmente la mente di dilemmi, specialmente se, come è successo nei giorni passati, si chiama a “testimonial” delle discussioni e delle divagazioni “l’uomo della strada“, quello che (ormai statua di bronzo) si affianca sul marciapiede davanti al circo- lo “Unione”, in procinto di dirigersi verso la chiesa Madre che gli si staglia di fronte.