La Rappresentazione Del Griko Di Sternatia La
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Dpgr 23 04 2018
REGIONE PUGLIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA N. 2\A? del Registro OGGETIO: Autorizzazione alla A.S.D. C. "Amici del Velodromo" di Monteroni di Lecce (LE) ad effettuare la manifestazione ciclistica in mountain bike specialità Marathon denominata: "2~ Marathon Cicli Manca- Punto Rosso Wilier", che si terrà il 29 aprile 2018. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE: VISTO il decreto legislativo 15/1/2002 n· 9 art. 2; VISTA la Legge l agosto 2002, n· 168; VISTO l'Art. 9 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n· 285; VISTO il disciplinare delle Scorte Tecniche alle competizioni ciclistiche su strada approvato con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27 novembre 2002 (G.U. n· 29 del 5 febbraio 2003); VISTA l'istanza acquisita agli atti prot. n. 1173 del 20/03/2018 con la quale la A.S.D. C. Amici del Velodromo, con sede in Monteroni di Lecce (LE) Via Unità d'Italia n. 50, chiede l'autorizzazione ad effettuare una manifestazione ciclistica in mountain bike specialità Marathon per il giorno 29 aprile 2018, denominata "2~ Marathon Cicli Manca- Punto Rosso Wilier"; PRESO ATIO che la suddetta gara interesserà i Comuni di Martignano, Calimera, Sternatia, Caprarica di Lecce e San Donato di Lecce; VISTI i nulla asta/autorizzazioni degli Enti proprietari delle strade interessate dal percorso: Comune di Martignano, Comune di Calimera, Comune di Sternatia, Comune di Caprarica di Lecce, Comune di San Donato di Lecce e Provincia di Lecce; VISTO il certificato di assicurazione della società organizzatrice della manifestazione per la R.C. allegato all'istanza di cui sopra; www.regione.puglia.it •••••• REGIONE PUGLIA RITENUTA l'opportunità di consentire lo svolgimento della suddetta gara, non sussistendo motivi ostativi, subordinata mente alla osservanza delle sottoindicate prescrizioni; AUTORIZZA La A.S.D. -

AMQ 31(1) 05-19 Mecozzi Proof Copy
Available online http://amq.aiqua.it ISSN (print): 2279-7327, ISSN (online): 2279-7335 Alpine and Mediterranean Quaternary, 31 (1), 2018, 5 - 19 https://doi.org/10.26382/AMQ.2018.01 LATE PLEISTOCENE MAMMAL FAUNAL ASSEMBLAGE FROM CAVA SPAGNULO (GROTTAGLIE, APULIA, SE ITALY) Beniamino Mecozzi 1-2, Amel Chakroun 3-4, Henry Baills 5-6, Dawid Adam Iurino 1-2, Raffaele Sardella 1-2, Donato Coppola 7 1 Dipartimento di Scienze della Terra, Sapienza, Università di Roma, Roma, Italy 2 PaleoFactory, Sapienza, Università di Roma, Roma, Italy 3 Département de géologie, Faculté des Sciences de Tunis, Universitaire Tunis El Manar, Tunis, Tunisie 4 Centre européen de recherches préhistoriques, UMR 6569 du CNRS, Tautavel, France 5 UMR 7194 du Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris, France 6 Université Perpignan, Perpignan, France 7 Dipartimento di Scienze dell’Antichità e del Tardoantico, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Bari, Italy Corresponding author: B. Mecozzi <[email protected]> ABSTRACT: The Quaternary sedimentary succession exposed at Cava Spagnulo, nearby the town of Grottaglie (Apulia, Southern Italy), is described for the first time. A preliminary list of the mammal remains from the upper part of the succession, has been compared with other Pleistocene Apulian sites. The identified taxa are represented by cranial and postcranial fragments and isola- ted teeth of bovids, cervids, equids, canids and lagomorph. In the same deposit also few Mousterian stone tools have been found. The study of the mammal assemblage and the lithic tools suggest that the upper part of the succession exposed at Cava Spagnu- lo could be referred to the second part of the marine isotopic stage 3. -

Valori Agricoli Medi Della Provincia Annualità 2015
Ufficio del territorio di LECCE Data: 13/04/2016 Ora: 9.11.26 Valori Agricoli Medi della provincia Annualità 2015 Dati Pronunciamento Commissione Provinciale Pubblicazione sul BUR n. del n. del REGIONE AGRARIA N°: 1 REGIONE AGRARIA N°: 2 PIANURA DI COPERTINO PIANURA DI LECCE Comuni di: ARNESANO, CAMPI SALENTINA, CARMIANO, Comuni di: LECCE, CALIMERA, CANNOLE, CARPIGNANO COPERTINO, GUAGNANO, LEVERANO, MONTERONI DI LECCE, SALENTINO, CASTRI DI LECCE, CAVALLINO, LIZZANELLO, NOVOLI, SALICE SALENTINO, SAN PIETRO IN LAMA, VEGLIE MELENDUGNO, SQUINZANO, SURBO, TREPUZZI, VERNOLE COLTURA Valore Sup. > Coltura più Informazioni aggiuntive Valore Sup. > Coltura più Informazioni aggiuntive Agricolo 5% redditizia Agricolo 5% redditizia (Euro/Ha) (Euro/Ha) AGRUMETO 25000,00 23900,00 BOSCO D`ALTO FUSTO 13500,00 13500,00 BOSCO MISTO 11000,00 CANNETO 5300,00 FICHETO 7900,00 6800,00 FRUTTETO 18200,00 16000,00 INCOLTO PRODUTTIVO 5500,00 MANDORLETO 10000,00 ORTO 18200,00 14100,00 PASCOLO 4500,00 4500,00 PASCOLO CESPUGLIATO 4800,00 4800,00 SEMINATIVO 7900,00 6800,00 SEMINATIVO ARBORATO 8700,00 7600,00 SEMINATIVO IRRIGUO 15600,00 13300,00 Pagina: 1 di 8 Ufficio del territorio di LECCE Data: 13/04/2016 Ora: 9.11.26 Valori Agricoli Medi della provincia Annualità 2015 Dati Pronunciamento Commissione Provinciale Pubblicazione sul BUR n. del n. del REGIONE AGRARIA N°: 1 REGIONE AGRARIA N°: 2 PIANURA DI COPERTINO PIANURA DI LECCE Comuni di: ARNESANO, CAMPI SALENTINA, CARMIANO, Comuni di: LECCE, CALIMERA, CANNOLE, CARPIGNANO COPERTINO, GUAGNANO, LEVERANO, MONTERONI DI LECCE, SALENTINO, CASTRI DI LECCE, CAVALLINO, LIZZANELLO, NOVOLI, SALICE SALENTINO, SAN PIETRO IN LAMA, VEGLIE MELENDUGNO, SQUINZANO, SURBO, TREPUZZI, VERNOLE COLTURA Valore Sup. -
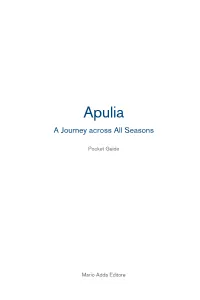
Apulia a Journey Across All Seasons
Apulia A Journey across All Seasons Pocket Guide Mario Adda Editore Regione Puglia AreA Politiche Per lA Promozione del territorio, dei sAPeri e dei tAlenti Servizio Turismo – Corso Sonnino, 177 – cap 70121 Bari Tel. +39 080.5404765 – Fax +39 080.5404721 e-mail: [email protected] www.viaggiareinpuglia.it Text: Stefania Mola Translation: Christina Jenkner Photographs: Nicola Amato and Sergio Leonardi Drawings: Saverio Romito Layout: Vincenzo Valerio ISBN 9788880829362 © Copyright 2011 Mario Adda Editore via Tanzi, 59 - Bari Tel. e fax +39 080 5539502 www.addaeditore.it [email protected] Contents A Journey across All Seasons ....................................................pag. 7 A History ............................................................................................ 9 Buried Treasures ....................................................................................... 11 Taranto’s Treasure ........................................................................ 12 Egnazia ....................................................................................... 12 The Bronzes of Brindisi ............................................................... 13 The Vases of Ruvo ....................................................................... 13 Between Legend and Reality on the Hill of Cannae ....................... 14 Ostuni – Pre-Classical Civilizations ............................................... 14 Caves and Prayers ....................................................................... -

Istituto Comprensivo Statale “G
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. FALCONE e P. BORSELLINO” SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA 1° GRADO Sedi nei comuni di SOLETO, STERNATIA, ZOLLINO Sede centrale Via Isonzo, n. 1 - 73010 SOLETO (LE) tel. 0836/667425 - C.F. 80012400752 - Codice Univoco UF0MPM email: [email protected] - PEC: [email protected] Sito Web: https://www.comprensivosoleto.edu.it/ All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Bari All’Ufficio VI - Ambito Territoriale di Lecce Al Comune di Soleto Al Comune di Sternatia Al Comune di Zollino Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della provincia di Lecce Ai Genitori degli alunni Al personale docente e ATA All’Albo online Al Sito Web di Istituto Oggetto: DISSEMINAZIONE Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. CUP G42G20000860007 – Codice Identificativo progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-345 IL DIRIGENTE SCOLASTICO VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 - 2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR); VISTA la nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale, Ufficio IV – Autorità di Gestione Prot. -

Ambito Di Martano
AMBITO DI MARTANO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI http://www.ambitodimartano.it - mailto: [email protected] Sede legale in Martano - Piazzetta Giacomo Matteotti n. 12 – info: 0836.575272 – fax: 0836.572347 Martano lì 26/03/2012 Spett.le REGIONE PUGLIA SERVIZIO POLITICHE DI BENESSERE SOCIALE E PARI OPPORTUNITA’ UFFICIO POLITICHE PER LE PERSONE E LE FAMIGLIE E LE PARI OPPORTUNITA’ VIA CADUTI DI TUTTE LE GUERRE,15 70126 B A R I Oggetto: progetto Studio di fattibilità “I tempi e gli spazi della città”. Relazione. Questo Ambito ha ottenuto il finanziamento del progetto “I Tempi e gli Spazi della Città” per un importo di € 40.000,00. Il progetto di che trattasi è stato avviato, come da Ns comunicazione del 21/01/2011 prot. n. 916, individuando, in primis, le figure professionali e le procedure per la selezione dei componenti dell’Ufficio “I tempi e gli spazi della città”. Con deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 10 del 22/03/2011, è stata sostituita la referente Assistente Sociale Anna Rotundo con l’Assistente Sociale Luigi Costa, componente dell’Ufficio di Piano. Nel mese di Aprile, attraverso l’affissione di manifesti pubblicitari, in tutti i Comuni dell’Ambito, sono state invitate tutte le associazioni del terzo settore a dare la propria adesione per contribuire allo studio. Sono pervenute n. 14 adesioni, descritte nell’unito allegato. Dopo aver pubblicato sul sito dell’Ambito l’avviso pubblico per la selezione delle seguenti figure professionali: Assistente Sociale con funzioni di coordinamento; Sociologo; Ingegnere urbanista; Ingegnere informatico; Laureato in Scienze della Comunicazione; la commissione esaminatrice preposta, ha valutato i curriculum pervenuti e a, seguito di colloquio,è stata pubblicata la graduatoria con i candidati risultati vincitori della selezione. -

United Nations
UNITED NATIONS UNEP/MED WG.468/Inf.21 UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME MEDITERRANEAN ACTION PLAN 9 August 2019 Original: English Meeting of the MAP Focal Points Athens, Greece, 10-13 September 2019 Agenda Items 3 and 4: Progress Report on Activities Carried Out during the 2018–2019 Biennium and Financial Report for 2016–2017 and 2018–2019 Agenda Item 5: Specific Matters for Consideration and Action by the Meeting, including Draft Decisions Draft Feasibility Study for a Transboundary CAMP Project between Albania and Italy (Otranto Strait area) For environmental and cost-saving reasons, this document is printed in a limited number. Delegates are kindly requested to bring their copies to meetings and not to request additional copies UNEP/MAP Athens, 2019 UNEP/MED WG.468/Inf.21 Page 1 Table of Contents List of Acronyms .................................................................................................................................................... 2 List of Figures ......................................................................................................................................................... 2 List of Tables .......................................................................................................................................................... 2 I. Introduction .................................................................................................................................................... 3 II. Definition of the area for CAMP ................................................................................................................... -

Nella Puglia Che Parla Griko
ITINERARI SALENTO Nella Puglia che parla griko Un’isola culturale nel cuore del Salento, un microcosmo che racconta millenni di storia: è la Grecìa Salentina, dove i Greci furono di casa dall’epoca micenea a quella di Bisanzio. Lasciando in eredità una lingua usata ancora oggi in nove antichi borghi TESTO DI GIANNA TESTA • FOTO DI ALFIO GAROZZO Nella foto. Il complesso dell’ex Convento degli Agostiniani di Melpignano con la Chiesa del Carmine. Fu costruito tra il 1573 e il 1662, insieme ad altre chiese e monasteri, per indirizzare verso la confessione cattolica gli abitanti della Grecìa Salentina, tradizionalmente di fede ortodossa. Ogni agosto fa da sfondo al concertone della Notte della Taranta. QUANDO: T U T TO L’A N N O DURATA: 2-3 GIORNI IL CONSIGLIO: ALTERNARE LA VISITA A CHIESE E MUSEI AL MARE DELLE VICINE SPIAGGE DI OTRANTO E TORRE DELL’ORSO inviaggio 92 inviaggio 93 l territorio – il Salento – è ben noto, eppure c’è qualcosa di strano. Le persone che s’incontrano parlano un idioma fitto e veloce che non si capisce, eccetto forse Iuna parola più familiare all’udito: kalimera (buongiorno). Ma cos’è che non torna? Semplice, siamo in Puglia ma sembra di essere in Grecia. La lingua è, appunto, una delle caratteristiche della Grecìa Salentina, dove si parla il griko, idioma neogreco tutelato da una legge del 1999 a favore delle Sopra. Il campanile della Chiesa Madre minoranze linguistiche storiche. In questa di San Brizio, a zona a sud di Lecce, infatti, si sono mantenute Calimera, sullo sfondo di Via Costantini. -

Allegato 1B) Lotti Territoriali Della Provincia Di Lecce PROCEDURA
Allegato 1b) Lotti territoriali della Provincia di Lecce PROCEDURA DI GARA APERTA PER L’INDIVIDUAZIONE DI PIU’ OPERATORI ECONOMICI CON I QUALI SOTTOSCRIVERE UN ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI LECCE DEL SERVIZIO DI TEMPORANEA ACCOGLIENZA ED ASSISTENZA DI CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE PER IL PRESUNTO PERIODO 01.07.2017 – 31.12.2017. GARA N. 6719831 Lotto n.1 – Comuni di: (13) Calimera, Copertino, Guagnano, Lecce, Martignano, Porto Cesareo, Salice Salentino, San Cesario di Lecce, San Donato di Lecce, San Pietro in Lama, Sternatia, Surbo, Veglie Lotto n. 2 – Comuni di: (17) Alezio, Alliste, Aradeo, Casarano, Galatone, Gallipoli, Matino, Melissano, Nardò, Neviano, Racale, Sannicola, Seclì, Supersano, Taviano, Tuglie, Ugento Lotto n. 3 - Comuni di: (37) Acquarica del Capo, Alessano, Bagnolo del Salento, Botrugno, Cannole, Castrignano del Capo, Castro, Collepasso, Corigliano d’Otranto, Corsano, Cursi, Cutrofiano, Diso, Gagliano del Capo, Giuggianello, Giurdignano, Maglie, Miggiano, Minervino di Lecce, Montesano Salentino, Morciano di Leuca, Nociglia, Ortelle, Otranto, Palmariggi, Poggiardo, Presicce, Ruffano, Salve, Santa Cesarea Terme, Scorrano, Soleto, Specchia, Spongano, Surano, Taurisano, Tricase I Comuni di: (5) Caprarica di Lecce, Cavallino, Martano, Sanarica e Tiggiano hanno avviato procedura per servizio SPRAR Comuni esclusi dal bando per strutture CAS perché sede di SPRAR al completo: (25) Andrano, Arnesano, Campi Salentina, Carmiano, Carpignano Salentino, Castrì di Lecce, Castrignano de’ Greci, Galatina, Lequile, Leverano, Lizzanello, Melendugno, Melpignano, Monteroni di Lecce, Muro Leccese, Novoli, Parabita, Patù, San Cassiano, Sogliano Cavour, Squinzano, Trepuzzi, Uggiano La Chiesa, Vernole, Zollino Per i Comuni sopraindicati, sede di CAS (centri di accoglienza straordinaria) e SPRAR, si precisa che per i seguenti n. -

133 Km Da Lecce a De Finibus Terrae
™ 133 km da Lecce a De Finibus Terrae by FEM SRLS FEM Passo dopo passo, per 133 km, alla scoperta del Salento più autentico. Il Cammino del Salento può essere pensato come l’unione di due parti: la prima, nell'entroterra, da Lecce ad Otranto, e la seconda, costiera, da Otranto a Santa Maria di Leuca. La prima parte è principalmente su asfalto, su strade secondarie e vie di campagna e si snoda tra i vari borghi dell'entroterra Salentino. Il cammino transita davanti a tutti i maggiori punti di interesse, valorizzando quindi i borghi attraversati e rendendo non necessari dei “fuori percorso”. LECCE OTRANTO SANTA MARIA 39 3 DI LEUCA La seconda parte del cammino è per la maggior parte sterrata, con qualche piccolo tratto su asfalto: il mare sarà il compagno di viaggio per gli ultimi 60 km di cammino! Percorsi costieri mozzafiato, sentieri a picco sul mare, antichi tratturi, oltre alle più belle località balneari del Salento. 5 PRIMA TAPPA: LECCE – STERNATIA Distanza: 21 km Terreno: Asfalto Tempo di percorrenza: 5 h E’ Porta Napoli a Lecce il punto iniziale del Cammino del Salento, primo timbro sul Pas- saporto del Pellegrino. Porta Napoli è un arco di trionfo che segna l’entrata nel centro storico della città, dove si potrà ammirare il Palazzo dei Celestini e la Basilica di Santa Croce, piazza Sant’Oronzo e l’Anfiteatro romano, Chiesa Santa Chiara e Porta San Biagio. Sul cammino anche la Foresta Urbana di Lecce, visitabile con le guide del WWF. Usciti dalla città, tramite vie secondarie, si arriva a San Cesario, con le sue distillerie e il Palazzo Ducale con il frontale ricco di statue mitologiche. -

COMUNE DI STERNATIA (Provincia Di Lecce)
COMUNE DI STERNATIA (Provincia di Lecce) PIANO FINANZIARIO DI RIEQUILIBRIO PLURIENNALE AI SENSI DELL’ART. 243 BIS E SEGUENTI DEL D. LGS. N. 267/2000 - PERIODO 2019 / 2023 - 1.A. PRONUNCE DELLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI 1.1. La Corte dei Conti, Sez. Reg. Controllo per la Puglia ha emesso deliberazione n. 191/PRPS/2015 , depositata il 24.09.2015 (comunicata via PEC a questo Comune il 25.09.2015 e acquisita in pari data al prot. n. 0004636), con la quale, in relazione agli esiti del controllo sul rendiconto dell’esercizio 2012 del Comune di Sternatia, ha così concluso: 1) “Dichiara che costituiscono violazione di norma finalizzata a garantire la regolarità della gestione finanziaria o irregolarità suscettibile di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari dell’Ente: la tardiva approvazione del rendiconto 2012, il superamento del parametri di deficitarietà strutturale n.4 e n.9, il risultato negativo della gestione di competenza; il pagamento oltre i termini previsti dalla legge e l’errata imputazione di voci di spesa nei servizi per conto terzi. 2) Dichiara che costituiscono situazione suscettibile di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari dell’Ente: lo squilibrio di cassa di parte corrente; l’ampio ricorso alla anticipazione di tesoreria non interamente rimborsata al termine dell’esercizio; l’insufficiente riscossione delle entrate; la scarsa e tardiva attività di riscossione della evasione tributaria e la presenza di residui attivi di dubbia esigibilità o sussistenza. 3) Prescrive che l’ente adotti tempestivamente ogni misura correttiva idonea a superare definitivamente le criticità rilevate nella presente deliberazione. -

La Rappresentazione Del Griko Di Sternatia La
Romano A. (2011). “La rappresentazione del griko di Sternatia in testi scritti: dalla « Novella del Re di Cipro » a « La tramontana e il sole ». In: G. Caramuscio & F. De Paola (a cura di), ΦΊΛΟΙ ΛΌΓΟΙ : Studi in memoria di Ottorino Specchia a vent’anni dalla scomparsa (1990-2010) , Galatina: EdiPan (Grafiche Panico), 167-184 (ISBN 978-88-96943-22-9 [ISSN 2038-0313]). La rappresentazione del griko di Sternatia in testi scrittiscritti:::: dalldallaa “““Novell“NovellNovellaa del Re di Cipro” a “La tramontana e il sole”sole” Antonio Romano* Io son nato in quella parte extrema de Italia, la quale altra volta fo chiamata Iapygia o Magna Gretia (hogie se dice Terra de Otranto), nella quale son dui lengue, greca et latina. Nell’una e l’altra havemo certi vocabuli crassi, li quali offendeno le orecchie di quelli chi non son usi a udirli. Oso dire che tanto nella greca quanto nella latina lengua di quello paese multi vocaboli so’ che se accostono più che nisciuna de l’altre lengue alla greca e alla latina semplicità antiqua. (Antonio de Ferrariis il Galateo , “Expositione”, 1504: 5) 1. Premessa Ho aperto questo mio breve contributo con le suggestive parole del Galateo per testimoniare dell’antico plurilinguismo delle comunità salentine e per ribadire la profonda incidenza che hanno avuto nelle lingue di queste terre – oltre alla decisiva caratterizzazione romanza ricevuta lungo tutto il Medioevo e alle molteplici innovazioni portate dalle genti che le hanno attraversate – i potenti fari linguistici sempre offerti dal Latino e dal Greco. In questi