Lanza, Cento Anni Fa La Prima Auto Italiana
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

RAPID Ceirano & C., Welleyes, F.Lli Ceirano
RAPID Ceirano & C., Welleyes, F.lli Ceirano, STAR Rapid, Matteo C. & C., Itala, Ceirano-Ansaldo, SPA, Junior, SCAT, S.A.Giovanni Ceirano: sono undici aziende, accomunate da due denominatori, sono tutte nate a Torino e sono tutte sorte per iniziativa di uno o dell'altro dei fratelli Ceirano. Addentrarsi nelle vite e nelle frenetiche attività dei quattro fratelli, distinguendo l'apporto di ciascuno, non è facile. I Ceirano sono una famiglia piemontese, originaria di Cuneo, composta da padre, madre e quattro fratelli: Giovanni Battista, nato nel 1860, Giovanni, nato nel 1865, Matteo, il viveur della famiglia, di cinque anni più giovane, ed Ernesto, nato dopo altri cinque anni. A questi si aggiunge in un secondo tempo il figlio di Giovanni che, con una certa mancanza di fantasia, è battezzato Giovanni e chiamato Ernesto. Come si vede, ci sono già i presupposti per una bella confusione, anche a prescindere dai rispettivi caratteri, che sicuramente devono essere stati piuttosto determinati, per non dire litigiosi e testardi, anche perché uno dopo l'altro si consacrano al medesimo mestiere: fondare aziende automobilistiche. Fondare, per poi andarsene, o fonderle con altre, o scioglierle, o rilevarle, in un caleidoscopio di società che vivacizzarono ed arricchirono molto il panorama industriale torinese ed italiano. Il primo a muoversi è naturalmente Giovanni Battista, il più anziano. Fonda la Ceirano & C. nel 1898 e la Welleyes nel 1899; quindi nel 1901, insieme a Matteo, la F.lli Ceirano, in corso Vittorio Emanuele 9. Liquidata questa nel 1903, nel 1904 trasforma la Ceirano & C. in STAR, Società Torinese Automobili Rapid, oggetto di questa breve indagine. -

San Salvario Il Quartiere Della Nascita Dell'auto a Torino
San Salvario Il quartiere della nascita dell'auto a Torino A cura di Enrico Miletto, Fondazione Vera Nocentini e Donatella Sasso, Istituto di studi storici Gaetano Salvemini 1 Origini e topografia del quartiere Il quartiere deriva il proprio nome dalla chiesa di San Salvatore in Campagna (da qui la popolare denominazione di San Salvario), edificata da Amedeo di Castellamonte tra il 1646 e il 1653, per volontà della Madama Reale Cristina di Francia. Da un punto di vista topografico, l’area di San Salvario è delimitata dai corsi Massimo d’Azeglio, Vittorio Emanuele II, Bramante e dalla via Nizza. Il borgo vero e proprio inizia a prendere forma soltanto a partire dalla metà dell’Ottocento, quando sorgono i primi insediamenti urbani, attigui alla campagna circostante. Orti, giardini, campi e vivai definiscono la porzione di territorio che dalla strada reale di Nizza (l’attuale via Nizza) arriva fino al Valentino. 2 Porta Nuova e commercio 1848-1852 Viene inaugurato il primo tratto ferroviario che collega Torino a Moncalieri seguito, nel 1853, da quello con Genova. Lo sviluppo dello scalo ferroviario di Porta Nuova, la cui direttrice divide San Salvario dai vicini rioni della Crocetta e di San Secondo, favorisce la crescita nel quartiere di attività commerciali. Sorgono così botteghe e aziende artigianali che contribuiscono a disegnare un’immagine di un quartiere dai ritmi concitati, una piccola city, operosa e indaffarata, le cui strade, ricche di negozi e botteghe, sono percorse, a partire dalla seconda metà dell’Ottocento, da carri trainati da cavalli, tramways e carretti. San Salvario conta all’epoca 50 isolati, circa 200 abitazioni ed è sede di una delle 10 preture cittadine. -

I Camion Italiani Dalle Origini Agli Anni Ottanta
I camion italiani dalle origini agli anni Ottanta AISA Associazione Italiana per la Storia dell’Automobile MONOGRAFIA AISA 124 I I camion italiani dalle origini agli anni Ottanta AISA - Associazione Italiana per la Storia dell’Automobile Brescia, Fondazione Negri, 19 ottobre 2019 3 Prefazione Lorenzo Boscarelli 4 I camion italiani Massimo Condolo 15 Nasce l’autocarro italiano Antonio Amadelli Didascalia MONOGRAFIA AISA 124 1 Prefazione Lorenzo Boscarelli l camion è nato pochi anni dopo l’automobile e se di rado frutto di progetti originali, ma fruitori in buo- Ine è ben presto differenziato, per soluzioni costrut- na parte di componenti – innanzitutto il motore – di tive, dimensioni e quant’altro. Potremmo chiederci origine camionistica. Un comparto particolare sono perché si ebbe quel sia pur breve “ritardo”; un motivo le macchine movimento terra, per l’iniziale sviluppo con ogni probabilità fu che per i pionieri dell’auto- dei quali tra i paesi europei un ruolo importante ha mobile era molto più attraente fornire un mezzo di avuto l’Italia. trasporto a persone, suscitando curiosità e di diverti- La varietà degli utilizzi dei camion, da veicolo com- mento, piuttosto che offrire uno strumento per il tra- patto per consegne cittadine o di prossimità a mezzo sporto di cose. Un secondo motivo fu senza dubbio la per trasporti di grande portata, da veicolo stradale a limitatissima potenza che avevano i primi motori per mezzo da cantiere, da antincendio a cisterna aeropor- automobili, a fine Ottocento, a stento in grado di por- tuale, e chi più ne ha più ne metta, ha prodotto una tare due o quattro passeggeri, di certo non un carico varietà di soluzioni tecniche e progettuali senza pari, significativo. -
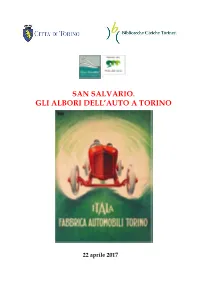
San Salvario. Gli Albori Dell'auto a Torino
SAN SALVARIO. GLI ALBORI DELL’AUTO A TORINO 22 aprile 2017 Il testo e le immagini derivano dal progetto didattico “ Torino e le fabbriche ” che si rivolge alle scuole secondarie di primo e secondo grado torinesi ed è mirato alla lettura della storia industriale del territorio e a una riflessione sull’evoluzione industriale e sociale della città. Il progetto è realizzato dall’ISMEL (Istituto per la Memoria e la Cultura del Lavoro, dell’Impresa e dei Diritti Sociali). San Salvario: gli albori dell’auto a Torino. A cura di Enrico Miletto TORINO E L’INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA. DA FINE OTTOCENTO ALLA SECONDA GUERRA MONDIALE Le principali tappe dello sviluppo dell’industria automobilistica torinese e italiana, con un riferimento costante al contesto internazionale. Conferenze a cura di Aldo Enrietti, volontario del progetto Senior civico . SAN SALVARIO. GLI ALBORI DELL’AUTO A TORINO Sabato 22 aprile, ore 10.30 Una camminata nel quartiere avvia un percorso in più tappe sulla storia dell’industria automobilistica a Torino da fine Ottocento alla Seconda Guerra Mondiale, in programma presso la Biblioteca centrale a partire dal 26 aprile. A cura di Enrico Miletto ( Fondazione Nocentini – Polo del ‘900) e Aldo Enrietti , volontario del progetto Senior civico. INCONTRI PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA CENTRALE Mercoledì 26 aprile, ore 17.30 Dalla carrozza all’automobile Storia del progressivo passaggio da un mezzo di trasporto all’altro, con particolare attenzione all’industria automobilistica torinese dalla fine dell’Ottocento alla Prima Guerra Mondiale. Mercoledì 10 maggio, ore 17.30 I protagonisti dell’automobile a Torino Le imprese storiche in città: i fratelli Ceirano, Giovanni Agnelli, Vincenzo Lancia. -

TECNICHE E TECNOLOGIE INNOVATIVE NELLE VETTURE ITALA Conferenza Di Carlo Otto Brambilla Milano, 8 Ottobre 1994 Museo Nazionale Della Scienza E Della Tecnologia
TECNICHE E TECNOLOGIE INNOVATIVE NELLE VETTURE ITALA Conferenza di Carlo Otto Brambilla Milano, 8 ottobre 1994 Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia ALESSANDRO COLOMBO Il nostro socio, Carlo Brambilla, che sta ultimando un libro sull’Itala, ha aderito alla mia richiesta su alcune anticipazioni su quello che sarà detto in questo libro, in particolare per quello che riguarda le soluzioni tecniche innovative che l’itala ha posto in alcune sue vetture, quindi questo è il tema della conferenza, diamo inizio senz’altro. Grazie a tutti. CARLO OTTO BRAMBILLA L’argomento è vastissimo perché l’Itala ha avuto una produzione estremamente diversificata di vetture e di motori, che variavano molto rapidamente. Premetterò quindi dei cenni generali sull’Itala, da un punto di vista tecnico e industriale, e poi cercherò di focalizzare l’attenzione su alcuni fatti particolarmente interessanti, ciò perché fare una trattazione con un minimo di approfondimento sui temi tecnici sviluppati dell’Itala, sostanzialmente 25 anni di produzione automobilistica, e anche di più se si considerano i derivati della ’61, sarebbe impossibile in così poco tempo, oppure sarebbe troppo superficiale e poco interessante. La prima cosa da dire è sicuramente che questa conferenza, e il libro che sto preparando ormai da molti anni, è possibile esclusivamente grazie al lavoro del Conte Carlo Biscaretti di Ruffia. Carlo Biscaretti di Ruffia, fu negli anni dal ’16 al ’30, il capo ufficio stampa dell’Itala, però la sua attività non fu solo quella di capo ufficio stampa, fu un’attività un po’ particolare, un’attività di consulente, sia dell’Itala sia di una serie di altre case automobilistiche, in qualità di libero professionista. -

P Programme and the FIA’S Portfolio Strategy Aimed at Modernising the FIA Championships
04 05 P MaaS: Connecting P The material the new network concerns aecting of urban travel alternative energy / Mobility as a Service is / AUTO looks at how new COVER set to change the way CHARGING forms of mobility are STORY we move by making THE EARTH putting strain on supplies journeys seamless of rare earth minerals 05 06 P Germany’s racing P ‘I’m not slowing giants charge into down now – I’m just Formula E going to go for it ’ / After dominating in F1 and / How F1 legend Mika ssue CLASH OF the WEC, Mercedes and MAXIMUM Häkkinen came back from #28 THE TITANS Porsche are ready to make ATTACK a life-threatening crash to sparks fly in electric racing take two world titles INTERNATIONAL JOURNAL OF THE FIA Editorial Board: Jean Todt, Gerard Saillant, THE FIA THE FIA FOUNDATION Saul Billingsley, Olivier Fisch Editor-In-Chief: Luca Colajanni Executive Editor: Justin Hynes The Fédération Internationale de The FIA Foundation is an Contributing Editor: Marc Cutler l’Automobile is the governing body independent UK-registered charity Dear reader, Chief Sub-Editor: Gillian Rodgers Art Director: Cara Furman of world motor sport and the that supports an international The third issue of Auto 2019 is packed with interesting and Contributors: Ben Barry, François Fillon, Edoardo Nastri, federation of the world’s leading programme of activities promoting Anthony Peacock, Gaia Pelliccioli, Luke Smith, motoring organisations. Founded road safety, the environment and thought-provoking in-depth articles on many topics. Tony Thomas, Kate Turner, Matt Youson Repro Manager: Adam Carbajal in , it brings together sustainable mobility. -

Storia. Piemonte Nicola Crepax
Storia. Piemonte Nicola Crepax Giugno 2005 Testo per Storiaindustria.it 1 Ad esclusivo uso didattico. Gli altri diritti riservati. Storia. Piemonte 1. Prima dell’industrializzazione La Fiat viene fondata nel 1899, la Olivetti nel 1908: durante la belle époque l’economia piemontese si trasforma con l’irrompere di un sistema di grandi imprese impegnate in produzioni di nuovo tipo, come la moderna industria meccanica e quella elettrica. Anche le industrie di prodotti tradizionali come le stoffe di cotone e di lana o quelle alimentari mutano il proprio assetto diventando più grandi e complesse. Le città, intanto, cambiano volto: fabbriche e uffici; case operaie e tramway; biciclette e illuminazione elettrica. Questo sviluppo, che nell’arco di pochi anni pone l’economia piemontese alla testa dell’industrializzazione del paese, è l’esito di due diversi stimoli: da un lato, la nascita delle nuove imprese rappresenta una positiva reazione all’evoluzione economica e sociale in atto, nello stesso periodo, oltre le Alpi; dall’altro, si presenta come il frutto di un lunghissimo, secolare processo di modernizzazione delle strutture produttive regionali. Questo processo di lungo periodo si articola in due sequenze principali: l’ampia fase, tra il sedicesimo e il diciottesimo secolo, in cui anche il Piemonte, pur non del tutto isolato, sconta il progressivo allontanamento della penisola dalle grandi correnti europee di sviluppo economico e sociale; una seconda fase ottocentesca, quando nel Regno di Sardegna, soprattutto durante il decennio cavouriano, e, in seguito, durante i primi anni dello stato unitario, iniziano a ripercuotersi le dinamiche innescate dalla rivoluzione industriale europea e si pongono le basi per l’industrializzazione dell’economia regionale; è l’avvio di un percorso accidentato e contraddittorio, che vede tra l’altro Torino perdere definitivamente il ruolo di capitale. -

Cartina 12 Layout 1
CCCM70%YYCMY B M M CY MY CMY CMY B CMY 70%CMY B C M Y SLURCMY B C M YCMY 2B4 2C4 2M4 2Y470% 70%CMY B C M Y 70%CMY B C M Y SLUR CMY SLURCMY BC70%CMM YCMY B Y SLURCMY B C M Y CMY 1B41C41M41Y4 70% 70%CMY B C M Y 70% CMY B CM Y CM CY MY CMY CMY BBCM70%YYCMY C M SLUR 12 COMPONENTI PER IMPIANTI DI TERMOVENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO Via Mondovì, 63 - 12040 MOROZZO (CN) Tel. 0171 772044 - Fax Ufficio Tecnico 0171 772468 Fax Ufficio Amministrativo 0171 771240 [email protected] - www.rossoofficine.it Scuderia Veltro: la storia dal 1997 L’idea di far rivivere una scuderia che negli anni ’70 era il punto di riferimento per i rallisti cuneesi è venuta ad un gruppo di appassionati che dismessi i panni di rallisti si cimentavano in gare di regolarità con auto storiche alcune delle quali avevano preso parte alle competizioni rallistiche del passato. Il momento era STORE DI BORGO SAN DALMAZZO - Via Cuneo 90 - Tel. 0171.902304 STORE DI CUNEO - Piazza Galimberti 10 - Tel.0171.66933 propizio anche per il rinascere di gare di regolarità Aperto tutti i giorni dalle 6.00 alle 19.30… che rievocavano rally del passato come appunto la anche vendita on line: www.storeorsobianco.com Ruota d’Oro che nel 1995 veniva proposta la prima edizione revival. Lo spirito aggregativo l’amicizia la condivisione della passione per i motori sono stati i catalizzatori di questo sodalizio che ha avuto una pro- gressione continua sino ad oggi con l’affiliazione al- l’ASI (Automotoclub Storico Italiano) ottenuta nel 2006 che ha portato oltre alla possibilità di iscrivere e certificare i veicoli storici ad ottenere la partecipa- La Scuderia Veltro presenta zione della Ruota d’Oro storica al Super Trofeo ASI la XVI Ruota d’Oro Storica 2011 Gino Munaron, prestigioso circuito di gare di regolarità a livello nazionale. -

PROGRAMME the 5G Path of Vehicle-To–Everything Communication: from Local to Global
5G Automotive Association PROGRAMME The 5G Path of Vehicle-to–Everything Communication: From Local to Global Conference and Live Demonstrations 14 November 2019, Turin–Italy Programme > 5G Automotive Association The 5G Path of Vehicle-to–Everything Communication: From Local to Global Conference and Live Demonstrations Thursday, 14 November 2019 I 09:00-14:00 (Conference), 14:00-17.30 (Demonstrations) Conference 5GAA Conference I 09:00 – 14:00 Agenda Museo Nazionale dell’Automobile, Congress Center “Carlo Biscaretti di Ruffia” 09:00 –09:30 Opening Remarks Address: 09:30 –10:30 First Session Corso Unità d’Italia 40, 11:00 –12:40 Second Session Turin 12:40 –13:00 Closing Remarks 13:00 –14:00 Lunch 08:30 Registration & Welcome Coffee Opening Remarks Paola Pisano, Italian Minister for Innovation and Digitalisation 09:00–09:30 Connecting the Mobility World with 5G-V2X Johannes Springer, Director-General, 5G Automotive Association First session C-V2X: A Global Standard for the Automotive Connected Revolution Gilberto Ceresa, Head of the Global Connectivity Team & Head of Information and Communication Technology EMEA region, Fiat Chrysler Automobiles (FCA) Followed by Q&A C-V2X path: from LTE-V2X to 5G-V2X 09:30 –10:30 Jim Misener, Senior Director, Product Management, Qualcomm Followed by Q&A Future Automotive Services over Today’s 5G Networks: A Global Perspective on Technology Evolution Stefano Sorrentino, Principal Researcher, Ericsson Followed by Q&A 10:30 –11:00 Coffee Break Second session Digital Roads: The Italian Vision Prof. Vito Mauro, -

La Storia Del Logo Fiat
La storia del logo Ceirano Accomandita Ceirano & C. Nazione Italia Fondazione 1898 a Torino Fondata da Giovanni Battista Ceirano, Emanuele di Bricherasio, Attilio Calligaris, Pietro Fenoglio e Cesare Goria Gatti Chiusura 1923 Sede principale Torino Settore casa automobilistica Prodotti autovetture La accomandita Ceirano GB & C fu una storica azienda automobilistica, fondata nell'ottobre del 1898 da Giovanni Battista Ceirano, Emanuele di Bricherasio, Attilio Calligaris, Pietro Fenoglio e Cesare Goria Gatti. La storia La sede della neonata azienda fu fissata a Torino in corso Vittorio Emanuele 9, dove nel 1899 si cominciò a costruire una piccola autovettura a due posti, la Welleyes, progettata dall'ingegnere Aristide Faccioli. Quando la Welleyes fu messa in produzione ci fu un grandissimo successo commerciale per la Ceirano, però i dirigenti si ritrovarono incapaci a far fronte alle ordinazioni della vetturetta. Allora nel mese di Luglio dello stesso anno il proprietario della Casa torinese, Giovanni Battista Ceirano, decise di cedere gli impianti e brevetti della sua azienda a Giovanni Agnelli. Per questo, Ceirano dovette lavorare per un periodo in Fiat, ma nel 1901 lasciò la Casa per rimettersi a lavorare in proprio, insieme a suo fratello Matteo. La collaborazione tra i fratelli termina già nel 1903 quando Matteo lascia l'azienda e Giovanni Battista insieme all'altro fratello Giovanni fonda la G.G. Fratelli Ceirano. Anche questa avventura dura poco, infatti Giovanni lascia il fratello il quale nel 1904 trasforma la società in Ceirano & C. che in seguito sarà ribattezzata STAR o Rapid. Questa è l'ultima trasformazione in quanto Giovanni Battista muore nel 1912. La fabbrica verrà rilevata dal fratello Giovanni che proseguirà l'attività ancora per qualche anno. -

Lezione 6 Industria Dell'auto File
L’evoluzione dell’industria dell’automobile in Italia: Il caso di Torino Si ringraziano Aldo Enrietti e Ken Simons per l’utilizzo dei loro lucici Aldo Geuna Indice Gli albori dell’auto: fine ottocento primi del novecento, nasce un industria. – USA, Italia, Torino I principali attori dello sviluppo dell’auto a Torino: – Ceirano, Lancia, FIAT L’evoluzione dell’industria dell’auto negli USA: Il Fordismo, il modello T L’evoluzione dell’ industria dell’auto in Italia ed a Torino L’evoluzione dell’industria dell’auto e lo Shakeout Gli albori dell’auto GLI ALBORI DELL’AUTO: fine ‘800, Inizio del ‘900 1.1 L’AUTO COME PRODOTTO 1.2 L’INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA NEGLI USA E IN EUROPA 1.3 L’INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA IN ITALIA E A TORINO 1.1 L’AUTO COME PRODOTTO Nasce per sostituire la trazione animale e si è servita, di volta in volta, di motori diversi a seconda dei sistemi di alimentazione Il primo prototipo funzionante è del 1769 ed ha un motore a vapore: il carro di CUGNOT era in grado di trainare 4 ton. di peso Gli sviluppi del motore a vapore furono tali che già nel 1828 le città di Londra e Bath erano collegate da autobus, appunto a vapore Durante il 1800 si svilupparono ricerche sia per il motore endotermico che per quello elettrico: quest’ultimo si dimostrava assai performante, al punto che nel 1899 Camille Jenatzy superava i 100 km/h con La Jamais Contente Bisogna aspettare la fine del secolo XIX per vedere le prime vetture circolanti Un salto in avanti nella motorizzazione avvenne nel 1876 grazie a Nikolaus August Otto, inventore del primo motore a combustione interna a quattro tempi. -
UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR JAVIER Baccalaureate in Science
UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR JAVIER Baccalaureate in Science MONOGRAPH “History and evolution of Italian automobiles and its possible influence on the Ecuadorian automobile Industry” STUDENT: Omar Adrián Zambrano Segarra TUTOR: LCDA. Laura Ortuño de Baquerizo III BACH. - B 2017 – 2018 ACKNOWLEDGEMENTS First of all, I would like to express my sincerest gratitude and love from the bottom of my heart to all those that have always supported me ever since I was a child. To my family, for all that which you have done for me. It is important for me that I know that all that was given to me was always the best and for the best, I had all that I ever needed or ever could have ever wanted. I am thankful for being raised to be a strong, healthy, conscientious person, yet most importantly, for becoming the kind of man you could be proud. I would like to express that I am grateful for all the experiences I have had throughout my lifetime, both good and bad. These experiences have allowed me to become the man I am today. They have formed and molded my character, allowing me to see the big picture, envisioning a wider scope, and opening my eyes to the goals I have set for myself in the future In addition, I am thankful for my friends who has always been there for me throughout all the crazy things we have done together, as well as for all the hour we spent laughing. In addition, yet not less important, I want to express my thanks to Ms.