Sommario 1.2.11 Le Progettualità
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Il Vostro Giornale - 1 / 4 - 27.09.2021 2
1 Notte di neve in Valbormida, alberi caduti e disagi alla viabilità di Redazione 15 Novembre 2019 – 7:48 Il Vostro Giornale - 1 / 4 - 27.09.2021 2 Agg. ore 10: Come riferito dal consigliere provinciale delegato alla viabilità, Luana Isella, al momento le strade sono “tutte transitabili. Rimane chiusa la Sp33 di Dego Santa Giulia. Stiamo intervenendo su tutte le strade per eliminare le alberature cadute” (nella foto sotto i lavori di rimozione della frana di Rialto). Il Vostro Giornale - 2 / 4 - 27.09.2021 3 Agg. ore 8: La Sp51 da Murialdo a Calizzano è stata riaperta al transito. Le scuole a Cosseria rimarranno chiuse. Valbormida. Sono sei le squadre dei vigili del fuoco in questo momento al lavoro in Valbormida per far fronte ai disagi causati dalla nevicata di questa notte. Oltre 40 finora gli interventi già effettuati, quasi tutti legati alla viabilità: alberi caduti, auto rimaste bloccate o strade diventate intransitabili. I disagi maggiori si sono registrati lungo le strade di Cairo Montenotte e Dego (in località Santa Giulia). Alberi caduti anche su alcune strade in località Millesimo, Plodio, Piana Crixia e lungo la strada che da Cengio porta verso Savona. Al momento risultano chiusi al traffico alcuni tratti della Sp33 nella zona di Santa Giulia a Dego, la Sp11 Marghero-Plodio, la Sp51 tra Murialdo e Calizzano e la Sp42 tra San Giuseppe di Cairo e Cosseria (all’altezza del bivio per la località Valle Bar del Bac). “Alberi sulle strade ovunque – scrive il sindaco di Cosseria Roberto Molinaro – Chi ha una motosega è ben accetto”. -

Anno 2013 Nr.3
NOTIZIARIO DEL GRUPPO “Camminare nel bello ESCURSIONISTICO della natura e dell’arte” I MONTAGNIN periodico di informazione SOMMARIO quadrimestrale REDAZIONE 85 e 60 anni della nostra vita Pag. 1 Via S. Benedetto 11/3 16126 Genova Quando la TV non c'era " 3 Tel 010 252250 Lo scarpone ferito " 4 Fax 010 8597527 A Natûa " 6 e.mail: [email protected] Ricordo di Ruggero " 7 Sito internet: www.montagnin.it Addio Carnacina, orso buono " 8 Monte Carmo di Loano " 9 DIRETTORE Aiuto, mi sono persa (Racconto del mese) " 10 RESPONSABILE Riepilogo attività Nov '13 - Apr. '14 " 12 Umberto Torretta Trekking nelle Dolomiti di Sesto " 15 SEGRETARIA DI Spigolature sul soggiorno a San Cassiano 22 REDAZIONE Quest'estate una domenica " 23 Francesca Milazzo Cronaca Montagnin: terza pagina di copertina REDAZIONE Hanno collaborato a questo numero: Nadia Bottazzi - Elisa Benvenuto Alessandra Bruzzi - Silvana Maestroni Angela Gaglione - Luigi Capelli Paola Poddioli Gianfranco Robba DELEGATO DEL C.D. Gianfranco Robba STAMPA Status s.r.l. Via Paleocapa 67r Genova Autorizzazione n° 8/1991 del Tribunale di Genova. Diffusione gratuita ai Soci e ai simpatizzanti, non commercializzata. Pubblicità inferiore al 70% ANNO 2013 N° 3 85 e 60 anni della nostra vita e 25 della mia. Un’anno importante questo 2013 per la nostra Società: i Montagnin compiono 85 anni e il Notiziario, che ne riporta gli avvenimenti e i ricordi, raggiunge i 60. Pare solo ieri quando festeggiavamo gli allora ottant’anni, con amici e parenti nel teatro della chiesa in via Bologna, con l’intervento del Coro Monte Cauriol, le associazioni genovesi della FIE, con tante torte, tanta allegria e qualche amico in più che in questi cinque anni ci ha purtroppo lasciato. -

Autorità Di Bacino Regionale
AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE PIANO DI BACINO STRALCIO SUL RISCHIO IDROGEOLOGICO (ai sensi dell’art.1, comma 1, del D.L. 180/1998 convertito in L. 267/1998) Caratteristiche idrauliche e geologiche del territorio Valutazione del rischio idraulico e geomorfologico RELAZIONE Ambito di Bacino di rilievo regionale: PORA Bacino: MAREMOLA Comuni: MAGLIOLO PIETRA LIGURE TOVO S. GIACOMO GIUSTENICE APPROVAZIONE Delibera del Consiglio Provinciale di Savona n. 47 del 25/11/2003 ULTIMA MODIFICA DELL'ELABORATO Decreto digitale del Direttore Generale n. 50 del 27/02/2018 ENTRATA IN VIGORE Pubblicazione sul BURL n. 12 del 21/03/2018 - parte II PIANO DI BACINO STRALCIO SUL RISCHIO IDROGEOLOGICO (ai sensi dell’art.1, comma 1, del D.L. 180/1998 convertito in L. 267/1998) Caratteristiche idrauliche e geologiche del territorio Valutazione del rischio idraulico e geomorfologico bacino: MAREMOLA 1 QUADRO GENERALE DI RIFERIMENTO .................................................. 4 1.1 Quadro istituzionale, normativo e amministrativo di riferimento ..... 4 1.2 Strumenti di pianificazione vigenti ...................................................... 5 1.2.1 Altri strumenti di pianificazione ............................................................... 6 1.3 Dati utilizzati ........................................................................................... 6 2. CARATTERISTICHE DEL BACINO ........................................................... 9 2.1 Geografia ............................................................................................... -

Allegato C Al Rapporto Ambientale Studio Di Incidenza
ALLEGATO C AL RAPPORTO AMBIENTALE FINALIZZATO ALLA FASE DI VAS AI SENSI DELLA LR 32/2012 e s. m. e i. STUDIO DI INCIDENZA Proponente: Dipartimento TERRITORIO, AMBIENTE, INFRASTRUTTURE E TRASPORTI Vicedirezione Generale TERRITORIO Settore TUTELA DEL PAESAGGIO, DEMANIO MARITTIMO E ATTIVITÀ ESTRATTIVE PTRAC 1 Rapporto Ambientale VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL PIANO TERRITORIALE REGIONALE DELLE ATTIVITÀ DI CAVA Gruppo di lavoro: Settore TUTELA DEL PAESAGGIO, DEMANIO MARITTIMO E ATTIVITÀ ESTRATTIVE LIGURIA RICERCHE S. p. A. Autorità Competente Dipartimento TERRITORIO, AMBIENTE, INFRASTRUTTURE E TRASPORTI TERRITORIO Vicedirezione Generale TERRITORIO Settore PIANIFICAZIONE E VAS PTRAC 2 Rapporto Ambientale Sommario BIODIVERSITÀ IN LIGURIA .................................................................................................................... 6 1.1 Biodiversità inquadramento ed elementi di valutazione di incidenza ............................................ 6 1.2 Biodiversità e Atlante degli habitat ................................................................................................ 6 1.3 Rete Natura 2000 in Liguria ........................................................................................................... 8 1.4 Caratterizzazione dei siti ............................................................................................................. 12 2. ELEMENTI DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA ........................................................................... 18 2.1 Introduzione ............................................................................................................................... -

TOPONIMI DEL COMUNE DI PALLARE Progetto Toponomastica Storica
TOPONIMI DEL COMUNE DI PALLARE a cura di Furio Ciciliot, Stefano Mallarini, Francesco Murialdo, Carmelo Prestipino Progetto Toponomastica Storica - 2 SOCIETÀ SAVONESE DI STORIA PATRIA onlus Savona - edizione digitale 2013 Progetto Toponomastica Storica 2 TOPONIMI DEL COMUNE DI PALLARE a cura di Furio Ciciliot, Stefano Mallarini, Francesco Murialdo, Carmelo Prestipino CON IL CONTRIBUTO DI: CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI PALLARE SOCIETÀ SAVONESE DI STORIA PATRIA onlus Savona 2013 1a edizione digitale © Copyright 2011. Società Savonese di Storia Patria onlus 1° edizione digitale 2013 È permesso scaricare e stampare gratuitamente una copia di questo fascicolo per uso personale o a fini di studio e ricerca. È vietato l’utilizzo, anche parziale, di testi ed immagini tratti dal presente volume per fini commerciali, salvo autorizzazione scritta della Società Savonese di Storia Patria e citando la fonte. Per le foto è altresì necessaria l’autorizzazione degli autori o possessori delle stesse. Avvertenze: pur avendo individuato complessivamente oltre ottocento toponimi, la ricerca non può essere esaustiva della toponomastica dell’attuale territorio comunale di Pallare. Per questo saremo grati per tutte le osservazioni che giungeranno e di cui si terrà conto in successive eventuali edizio- ni, così come saranno positivamente valutate proposte di implementazione con ulteriori fonti stori- che od orali. Direzione scientifica del Progetto Toponomastica Storica: Consiglio Direttivo della Società Savonese di Storia Patria. Ideazione, direzione ed organizzazione del Progetto Toponomastica Storica: Furio Ciciliot e Francesco Murialdo. Ricerche principali e contatti con gli informatori per il presente volume: Stefano Mallarini e Carmelo Prestipino. Fotografia di copertina: gli abeti bianchi (Abies alba) dei boschi del Ronco di Maglio erano, tra gli altri usi, destinati fin dal Medioevo a diventare alberi di nave della flotta genovese e ligure. -

La Battaglia Di Loano 1795
La Battaglia di Loano 1795 ITINERARI NELLA PROVINCIA DI SAVONA IL PROGETTO BONESPRIT La Provincia di Savona, partner nella realizzazione del progetto Bonesprit “Esperienze di rete culturale transfrontaliera per la valorizzazione del pa- trimonio napoleonico”, promuove, insieme a Lucca, Massa Carrara, Livorno, Pisa, Sarzana, Carloforte ed Ajaccio, un sistema comune di itinerari, volti a potenziare e migliorare la conoscenza e la fruizione delle testimonianze materiali e immateriali legate a Napoleone, ai Bonaparte e più in generale a “l’esprit nouveau” che ha pervaso i territori coinvolti nel progetto. Il patrimonio napoleonico presente sul nostro territorio è assai cospicuo e spesso inserito in ambiti paesaggistici di pregio, tanto che la Federazione Europea delle Città Napoleoniche annovera, tra i propri associati, diverse città e comuni del territorio savonese. La provincia di Savona è stata teatro di azioni che hanno mutato l’assetto geopolitico dell’intera Europa. Le proposte degli itinerari turistico – cultura- li sviluppati dal progetto prendono spunto proprio dalle azioni militari che si sono svolte in questi luoghi. Tutto ebbe inizio con la “Battaglia di Loano”, novembre 1795, prima batta- glia ancor oggi riportata sull’Arco di Trionfo di Parigi: fu uno scontro fron- tale tra le Armate Rivoluzionarie Francesi, le Armate Imperiali Austriache e Reali Sarde. La vittoria francese in territorio italiano darà l'inizio, cinque mesi dopo, alla Prima Campagna d’Italia, comandata dal giovane generale Napoleone Bonaparte e combattuta proprio sulle alture savonesi e nella Val Bormida. I presenti itinerari sono quindi, per la Provincia di Savona, una felice occa- sione per rileggere un periodo che ha profondamente segnato la storia e la cultura del nostro Paese e, al contempo, offrire l’opportunità di fruire della nostra bellissima costa e del nostro suggestivo entroterra in tutte le stagioni dell’anno. -

Rivista Dell'associazione “Emanuele Celesia” Amici Della Biblioteca E
NUMERO STAMPATO CON IL CONTRIBUTO DEL PREMIO "RENATO TESTA" Rivista dell’Associazione “Emanuele Celesia” Amici della Biblioteca e del Museo del Finale Anno VI - 2016 - Numero 15 L’ambiente come storia di Giuseppe e Mario Berruti Una parte consistente dell’am- antropica: Edoardo Boncinelli biente che ci circonda, e che ha scritto: «La nostra società ha convenzionalmente consideria- molti problemi, e molti ne avrà. mo e defniamo «naturale» – per Vivendo meglio, siamo più nu- distinguerla da tutto ciò che è merosi. Essendo più numerosi, chiaramente da attribuirsi all’o- consumiamo e imbrattiamo pera dell’uomo: come gli edifci, di più». Viene così introdotto le strade e i «manufatti» in gene- un tema di rilievo: storia del rale –, in realtà non è afatto na- popolamento umano e storia turale (o forse lo era all’origine, dell’ambiente vengono proposti spesso solo in parte), in quanto come elementi in confitto, sen- è stata costruita, o modifcata, o za alcun dubbio reciproco, di adattata dall’uomo: è, in sostan- un processo che tende ad accen- za, un artefatto. È ampiamente tuarsi nel corso del tempo. Il Quadrifoglio noto che una quota apprezzabi- Per dare un senso preciso ai ter- | le del mondo vegetale, in forte mini del tema in questione, è 01 misura nei paesi a economia utile riferirci ad un dato di fatto. avanzata e a civiltà «matura», La popolazione di Finale Ligure, è il prodotto dell’invenzione tra l’inizio del 1500 (secondo le umana: non possono esserci rilevazioni eseguite da Agostino dubbi sul fatto che, da quando Giustiniani) e il 2011 (secondo i forme di vita si sono manifestate dati del censimento di quell’an- su questo pianeta intorno a tre no), in un’area territoriale che miliardi e mezzo di anni prima ha conservato più o meno le d’ora, la specie che ha maggior- medesime dimensioni tra le due Evoluzione urbanistica della Marina mente inciso sugli assetti am- date, è salita da 5.350 abitanti a bientali originari (preferiamo 11.867. -

Alessandra Frondoni, Fabrizio Benente, Giovanni Murialdo, Paolo Palazzi, Laura Pellegrineschi Indagini Archeologiche a Varigotti (Savona)
Alessandra Frondoni, Fabrizio Benente, Giovanni Murialdo, Paolo Palazzi, Laura Pellegrineschi Indagini archeologiche a Varigotti (Savona). Il castrum e la chiesa di San Lorenzo [A stampa in Atti I° Congresso Nazionale di Archeologia Medievale, Pisa 1997, pp. 102-108 © degli autori – Distribuito in formato digitale da “Reti medievali”, www.retimedievali.it]. INDAGINI ARCHEOLOGICHE A VARIGOTTI fasi d’uso databili dalla fine del VI al X secolo (F RONDONI (SAVONA). IL CASTRUM E LA CHIESA 1992; F RONDONI 1995). Notevole è una fase con strati di DI SAN LORENZO crollo ed incendio delle travature lignee delle abitazioni, datate al C14 alla metà dell’VIII secolo (+/-120 anni). Ipo- di tetico ma suggestivo diventa il riferimento all’età della “con- quista” longobarda e l’aggancio storico archeologico con ALESSANDRA F RONDONI , F ABRIZIO B ENENTE , G IOVANNI Varigotti, da meglio vagliare. Già il Lamboglia (L AMBOGLIA MURIALDO , P AOLO P ALAZZI , L AURA P ELLEGRINESCHI 1946) proponeva che le due località potessero far parte di uno stesso “distretto” amministrativo, pertinente alla “ civi- tas ” nominata dal cronista franco. 1. INTRODUZIONE Gli scavi nel castrum di Varigotti si inquadrano, inol- tre, in un esteso programma di indagine degli insediamenti Il promontorio di Varigotti conserva numerosi resti di fortificati di origine bizantina della Liguria di Ponente, par- fortificazioni medievali, in parte nascosti dalla fitta coltiva- te appena avviate, parte ormai quasi alla conclusione (M U- zione ad oliveto. Alcuni tratti della cinta muraria furono RIALDO -M ANNONI 1990; B OSELLI 1990, pp. 229-271). Tra que- attribuiti dal Lamboglia ad un più antico insediamento di- sti si segnala per importanza il castrum tardo-antico di S. -

Valutazione Ambientale Del Piano Di Sviluppo 2011
Valutazione Ambientale del Piano di Sviluppo 2011 Rapporto Ambientale Volume Regione LIGURIA INDICE 1 Introduzione 4 3.3 Paesaggio e beni culturali, architettonici, monumentali e archeologici 13 1.1 Struttura del rapporto regionale 4 3.3.1 Siti UNESCO 13 1.2 Modalità di collaborazione attivate per la VAS 4 4 Contesto Economico 14 1.3 Fonti dati disponibili 4 5 Contesto Tecnico 15 2 Contesto Ambientale 5 5.1 Pianificazione energetica regionale 15 2.1 Caratterizzazione geografica 5 5.2 Stato della rete di trasmissione nazionale nell’area 2.2 Biodiversità ed aree protette 5 del Nord Ovest d’Italia 15 2.2.1 Aree naturali protette 5 6 Interventi 17 2.2.2 Rete Natura 2000 6 2.2.3 Aree Ramsar 9 6.1 Nuove esigenze 17 2.3 Assetto del territorio 9 6.2 Interventi presenti in Piani precedenti già approvati 31 2.4 Pianificazione territoriale 10 6.3 Sintesi degli indicatori regionali 33 3 Contesto Sociale 12 3.1 Demografia 12 3.2 Uso del suolo 12 Indice | 3 1 Introduzione dell’economia regionale, anche in relazione a 1.1 Struttura del rapporto regionale dati nazionali; − Il Rapporto Regionale relativo al Piano di Sviluppo Contesto Tecnico, che descrive lo stato della rete (PdS) 2011 riporta i principali interventi previsti, a livello regionale; suddivisi tra interventi in corso di concertazione, da − Interventi, che sono oggetto della VAS, proposti avviare alla concertazione, privi di potenziali effetti sul territorio regionale. significativi sull’ambiente, al di fuori dell’ambito VAS (in fase autorizzativa, autorizzati, in 1.2 Modalità di collaborazione attivate per la realizzazione, ecc.). -

Megalithism in VAL CERESIO
Megalithism in Ceresio Valley (N.-W. Lombardy, Italy) Alfredo Pirondini*, Gian Paolo Bocca, Filippo Pirondini* and Cecilia Pirondini* Summary The Authors describe the megalithic findings and petroglyphs, their orientation with the possible correlations that may indicate an archaeologic and archaeoastronomic attendance pre-and/or protohistoric of described places. Following an analysis of possible future research. Introduction The described findings are located in Porto Ceresio (Varese District, North-Western Lombardy, Italy), belonging to the current "Regio Insubrica" (a Cross-Border Community: Euroregion established in 1995), on the border with Canton Ticino (TI), belonging to the Swiss Confederation (CH), on the South-Western slopes of Monte San Giorgio (i.e. Mount St. George), UNESCO World Heritage. The resort is located on Southern coast of Lugano Lake (or Ceresio), a pre-Alpine lake formed between 18,000 and 15,000 years ago, at the end of the last ice age. The name “Ceresio” has unclear origins. Some derives from the Latin “cerasus” (i.e. Cherry), but from deeper linguistic analysis, lemmas “keres”, “krres”, “kar”, “ker”, the roots *krs and, above all, *kr are related to the concepts of altitude and elevation. Hence the Celtic - Insubric “kar”, meaning: rock, prominence, horn. By further linguistic analysis (4), "Ceresio" is not a toponym, but a hydronym, derived from the root *shr, related to "current" (s) of "water" (hr). Since prehistory, Porto Ceresio was a harbour for lake trades between Po Valley, North and Central Europe. The flat area, currently occupied by relatively recent buildings, was, until the Late Middle Ages, a swamp known as "Palude Ceresia". -
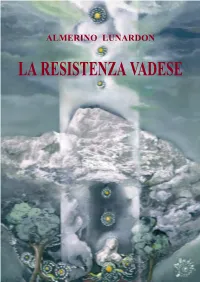
LA RESISTENZA VADESE a Giovanni E Sara ISREC
ALMERINO LUNARDON LA RESISTENZA VADESE A Giovanni e Sara ISREC Istituto Storico della Resistenza COMUNE DI e dell’Età Contemporanea VADO LIGURE della provincia di Savona ALMERINO LUNARDON LA RESISTENZA VADESE VADO LIGURE 2005 LA RESISTENZA VADESE di Almerino Lunardon Pubblicazione promossa da: Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea della provincia di Savona Comune di Vado Ligure Sponsor Provincia di Savona Cassa di Risparmio di Savona Unione Industriali della Provincia di Savona Contributo di Guido Malandra: cap. VI “I Volontari della libertà vadesi” Collaborazioni per alcune ricerche d’Archivio e trascrizione di documenti: Donatella Ventura, Paolo Ramagli, Luca Bottaro Collaborazioni per alcune interviste: Roberto Costagli e Luca Bottaro Hanno fornito alcuni materiali e notizie: Piero Morachioli, Giorgio Preteni, Sergio Leti, Sergio Istello, Enrico Vigneto, Giancarlo Esposito, Don Nicola Lorini In copertina: dipinto di Sergio Palladini “Le Rocce Bianche”. Progetto grafico: Almerino Lunardon e Mario Lorenzo Paggi Foto utilizzate: Arch. Personale pp. 47,48,49,65,158,161,301; Arch. Esso Italiana pp. 48,49 (in basso) S.O.M.S. Pace e Lavoro - Valle pp. 95,101,132,148,161 (in basso),166,210,227,228 Ciarlo Beppe pp.66,232,233,245,274,294,303,314, 378, 395; Vigneto Enrico p.156,198,306,396,422 (in basso); Faccio Silvio pp. 194,195, 491; Esposito Giancarlo pp. 171,176,181,183; Leti Sergio p.269; Preteni Giorgio pp.105,242,386,422; Fulvio Scotto p. 234; Babboni Giancarlo p. 50; Cabiati Vincenzo pp.382,389; Bressano Mara p. 399; dal “Catalogo A.Cabiati” p.384; dal libro “Non dimentichiamo” p.284; dal libro “Bergeggi: un’isola…” p. -

Altare (SV) 17045 Mallare (SV) Tel
IT EN FR L’HARDALPITOUR compie dieci anni HARDALPITOUR celebrates ten years L’HARDALPITOUR célèbre dix ans Sanremo - Sestriere PREFAZIONE Il y a tellement de façons d’aller en moto. L’Adventouring è uno di questi. Dove si lascia la strada principale per quella meno battuta, verso luoghi sperduti, naturali, incontaminati. E per questo ancor più affascinanti. Con l’Adventouring si scoprono luoghi minori che, tuttavia, spesso presentano una loro bellezza nascosta e sconosciuta ai più. La Hardalpitour vuole essere il modello ideale dell’Adventouring, proponendo in questa sua 10^ edizione il passaggio su tantissimi di questi luoghi speciali, sulle strade che dal mare ai monti uniscono Sanremo a Sestriere. Un evento originale che richiama ogni anno motociclisti appassionati da tutto il mondo! E anche in questa storica edizione, siamo certi, ci saranno tutti gli ingredienti per divertire, emozionare e The only impossible appassionare sempre più. Buona strada! PREFACE journey is the one There are so many ways to ride. Adventouring is one of these. Where you leave the main road for the less traveled, towards remote, natural, uncontaminated places. And for this reason even more fascinating. With the Adventouring you discover smaller places that, however, often present their hidden beauty unknown to most people. The Hardalpitour wants to be the ideal model of Adventouring, proposing in its 10th edition the passage on many of these special places, on the roads that from the sea to the mountains join Sanremo to Sestriere. An you never begin! original event that attracts passionate motorcyclists from all over the world every year! And even in this histori- cal edition, we are sure, there will be all the ingredients to amuse and excite more and more.