Piante Di Città
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

La Piana Fiorentina, Potenzialità E Progetti Per Il Futuro
Corso di Laurea magistrale (ordinamento ex D.M. 270/2004) in Sviluppo interculturale dei sistemi turistici Tesi di Laurea La piana fiorentina, potenzialità e progetti per il futuro Relatore Prof. Francesco Vallerani Correlatore Prof. Carlo Giupponi Laureando Elisa Bellini Matricola 855618 Anno Accademico 2015 / 2016 Ringraziamenti Ringrazio innanzitutto la mia famiglia, che mi ha sempre sostenuta ed appoggiata nelle mie scelte e desideri, standomi costantemente accanto. Lorenzo, punto fermo ed ancora, pronto ogni volta ad aiutarmi ed a camminare insieme. Gli amici di una vita, sempre disponibili ad accogliermi ad ogni mio ritorno a casa e con i quali condivido ogni esperienza. Alle amicizie che ho instaurato durante gli anni di università, con le quali non ho spartito solo stress e studio, ma veri momenti di vita di quotidiana ricchi di emozioni ed avventure. Agli amici dell’Erasmus, che nonostante abbia condiviso con loro solo 5 mesi, sono diventati una vera e propria familia madrileña. A tutti coloro che mi hanno aiutato a portare a termine il mio progetto di tesi, con il loro contributo e saggezza. 1 2 Indice Indice delle figure……………………………………………………………………. pag.5 Abstract………………………………………………………………………………..pag.9 Introduzione………………………………………………………………………….pag.11 Capitolo 1: Individuazione del luogo e peculiarità geo-storiche……………………...pag.13 1.1 Ombrone: caratteri geostorici…………………………………………….pag.15 1.1.1 Il contesto idrografico………………………………………………pag.16 1.1.2 Biodiversità…………………………………………………………pag.18 1.1.3 Cenni storici………………………………………………………...pag.19 -

Florence Florence Can Boast Many Histories – Artistic, Financial, Religious, the Central Point of the City’S Political and Cultural Development
AGENZIA PER IL TURISMO FIRENZE florence Florence can boast many histories – artistic, financial, religious, the central point of the city’s political and cultural development. cultural, political. These are so rich that it is impossible to sum By virtue of its geographic position and social climate, Florence them up in a few short lines. One word, however, has always dis- exercised a function of equilibrium in the history and art of the pe- tinguished the city in the eyes of the world: the Renaissance. riod known as the Renaissance. After various vicissitudes involving the Florentine Republic and history Medici restorations, another historic era started for Florence in a brief 1530 with the establishment of the Grand Duchy of Tuscany. The The early Etruscan settlements sprang up on the hill of Fiesole, power of the city grew, reaching a peak with the defeat of arch-ri- while the Romans established themselves (in 59 BC) on the plain val Siena in 1555. The House of the Medici died out in the 18th around the Arno. The Forum of Roman Florentia was situated where century, giving way to the rule of the Habsburg-Lorraine, under Piazza della Republica stands today, and the inner circle of walls whom Florence also conquered Lucca (1847). Finally, the Duchy ran along today’s Via Tornabuoni, Via Cerretani and Via del Pro- entered the Kingdom of Italy in 1859 following a plebiscite. consolo. Florence was the capital of unified Italy from 1865 to 1870, dur- Miniato and Reparata were the first patron saints of Florence, ing which time Giuseppe Poggi produced an urban planning proj- which became an episcopal see in the 4th century. -

Florence Fall & Winter Guide 2011 – 2012
FLORENCE FALL & WINTER GUIDE 2011 – 2012 The best places to eat, sleep and play in Florence this fall and winter With more than 50 million reviews and opinions, TripAdvisor makes travel planning a snap for the 50 million travelers visiting our site each month. Think before you print. And if you do print, print double-sided. INTRODUCTION TripAdvisor, the most trusted source for where to eat, sleep and play in thousands of destinations around the world, has collected the best insider tips from its 50 million monthly visitors to produce a unique series of travel guides. In addition to the best hotels, restaurants and attractions for every type of traveler, you’ll get great advice about what to pack, how to get around and where to find the best views. Be sure to check out the guides at www.tripadvisor.com. You’ll find reviews for more than 520,000 hotels, 125,000 vacation rentals, 155,000 attractions and 715,000 restaurants on Inside TripAdvisor.com. Learn from other travelers what to expect before you make your plans. FLORENCE Michelangelo’s famed statue of David, a huge presence (literally and figuratively) in the Galleria dell’Accademia in Florence, is nearly synonymous with the city itself. And for good reason. PACKING TIPS Florence is a city of art, and this 17-foot-tall marble sculpture .1 “Carry small packets of Kleenex for the is an undisputed masterpiece. Florence is the “City of Stone,” bathrooms…’nuff said.”—TripAdvisor from its sidewalks to its doorjambs, and David elevates stone Member to an art form. -
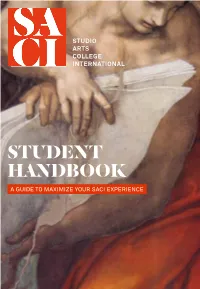
STUDENT HANDBOOK a GUIDE to MAXIMIZE YOUR SACI EXPERIENCE Front and Back Cover Images: Details of Michelangelo’S Sistine Chapel
STUDIO ARTS COLLEGE INTERNATIONAL STUDENT HANDBOOK A GUIDE TO MAXIMIZE YOUR SACI EXPERIENCE Front and back cover images: details of Michelangelo’s Sistine Chapel. SACI STUDENT HANDBOOK A Guide to Maximize Your SACI Experience Studio Arts College International Palazzo dei Cartelloni Via Sant’Antonino 11 50123 Florence - ITALY T (+39) 011 055 289948 F (+39) 011 055 2776408 [email protected] www.saci-florence.edu 4 CONTENTS Welcome..................................................7 SACI Mission Statement............................8 SACI Facilities.............................................9 School Regulations and Policies.............10 Housing................................................14 Other SACI Services..................................17 Visitors...............................................18 SACI Academic Information.....................20 Course Information....................20 Financial Information...............22 SACI Field Trips.........................................24 Florence’s Schedule.................................26 Health and Safety ...................................27 Fitness Facilities.......................27 Medical Information.................28 Safety Information....................31 Communication.....................................35 Telephone...............................35 Faxes, Photocopies, and IDs......37 Email and Internet....................37 Mail.....................................38 Money Transactions.................................39 Getting Around in Florence.....................41 -

Management Plan Men Agement Plan Ement
MANAGEMENTAGEMENTMANAGEMENTEMENTNAGEMENTMEN PLAN PLAN 2006 | 2008 Historic Centre of Florence UNESCO WORLD HERITAGE he Management Plan of the His- toric Centre of Florence, approved T th by the City Council on the 7 March 2006, is under the auspices of the Historic Centre Bureau - UNESCO World Heritage of the Department of Culture of the Florence Municipality In charge of the Management Plan and coordinator of the project: Carlo Francini Text by: Carlo Francini Laura Carsillo Caterina Rizzetto In the compilation of the Management Plan, documents and data provided di- rectly by the project managers have also been used. INDEXEX INDEX INTRODUCTIONS CHAPTER V 45 Introduction by Antonio Paolucci 4 Socio-economic survey Introduction by Simone Siliani 10 V.1 Population indicators 45 V.2 Indicators of temporary residence. 46 FOREWORD 13 V.3 Employment indicators 47 V.4 Sectors of production 47 INTRODUCTION TO THE MANAGEMENT 15 V.5 Tourism and related activities 49 PLANS V.6 Tourism indicators 50 V.7 Access and availability 51 FIRST PART 17 V.8 Traffi c indicators 54 GENERAL REFERENCE FRAME OF THE PLAN V.9 Exposure to various sources of pollution 55 CHAPTER I 17 CHAPTER VI 56 Florence on the World Heritage List Analysis of the plans for the safeguarding of the site I.1 Reasons for inclusion 17 VI.1 Urban planning and safeguarding methods 56 I.2 Recognition of Value 18 VI. 2 Sector plans and/or integrated plans 60 VI.3 Plans for socio-economic development 61 CHAPTER II 19 History and historical identity CHAPTER VII 63 II.1 Historical outline 19 Summary -

FLORENCE Streets Athousandtalesofthepast:Medievaldyers Coloured Evokes Woolin Eve Beinghurledoutofparadise
© Lonely Planet Publications 92 lonelyplanet.com FLORENCE •• History 93 FLORENCE FLORENCE HISTORY and tact in dealing with artists saw the likes of Florence’s history stretches to the time of the Alberti, Brunelleschi, Luca della Robbia, Fra Florence Etruscans, who based themselves in Fiesole. Angelico, Donatello and Filippo Lippi flourish FLORENCE FLORENCE Julius Caesar founded the Roman colony of under his patronage. Florentia around 59 BC, making it a strate- In 1439 the Church Council of Florence, gic garrison on the narrowest crossing of the aimed at reconciling the Catholic and East- Arno so he could control the Via Flaminia ern churches, brought to the city Byzantine Return time and again and you still won’t see it all. Stand on a bridge over the Arno several linking Rome to northern Italy and Gaul. scholars and craftsmen, who they hoped After the collapse of the Roman Empire, would impart the knowledge and culture of times in a day, and the light, the mood and the view change every time. Surprisingly small Florence fell to invading Goths, followed by classical antiquity. The Council, attended as it is, this city is like no other. Cradle of the Renaissance and of the masses of globe- Lombards and Franks. The year AD 1000 by the pope, achieved nothing in the end, trotting tourists who flock here to feast on world-class art and extraordinary architecture, marked a crucial turning point in the city’s but it did influence what was later known as Florence (Firenze) is magnetic, romantic, unrivalled and too busy. A visit here is madness, fortunes when Margrave Ugo of Tuscany the Renaissance. -

October 2019 P&F Newsletter LONG
WELCOME The morning air now has a distinct chill, but coats and sweaters are still shed by noon and the warmth of afternoon sun feels like a gift. The last of the grapes are being pulled from their vines and wine is fermenting in the cellars. Ripening olives hang heavy on the groves of trees. Our thoughts turn to truffles, mushrooms, and chestnut sweets. Enjoy the calendar full of music, exhibitions, concerts, dance, and especially the return of our favourite Cultural Program at the British Institute, which has returned more abundant than ever… With best wishes from SUZANNE, CORSO, BEI, LESLIE, VANNI, ANNA PIA, RAFFAELLA, AND MARISA. JUMP TO YOUR FAVOURITE SECTION PITCHER AND FLACCOMIO PICKS BEST OF THE REST EXHIBITIONS DANCE AND THEATRE FILMS, LECTURES, AND PRESENTATIONS MUSIC EXHIBITIONS OUTSIDE OF FLORENCE FUN, FESTIVALS, AND FOOD OUTSIDE OF FLORENCE CLASSIFIEDS !1 Pitcher & Flaccomio Newsletter Copyright 2017 Direttore responsabile Raffaella Galamini - Pubblicazione con iscrizione n. 5697 del 23\01\09 presso il Tribunale di Firenze. Pitcher & Flaccomio - Lungarno della Zecca Vecchia 30 - 50122 - Florence - Italy • Phone +39 055 2343354 • Fax +39 055 5609916 Office Hours: 9am - 5pm (+1.00 GMT) PITCHER & FLACCOMIO PICKS FOR SEPTEMBER BEST EVENT: AUTUMN SHOW MARKET OF PLANTS AND FLOWERS BY THE TUSCAN HORTICULTURAL SOCIETY, October 5 and 6 From the first weekend in October, meet at the Horticultural Garden of Florence for the Autumn Show Market of plants and flowers, organised by the Tuscan Horticultural Society, a non-profit association, with headquarters and library at Villa Bardini in Costa San Giorgio, 2. The entrance is free with 50 exhibitors including the best Tuscan nurserymen and beyond. -
Intorno a Firenze
intorno a Firenze di Elena Abbatemaggio e Sara Fontani con la collaborazione di Silvano Amerini e Claudio Badiali Testi e foto © UISP Comitato Regionale Toscano – via Bocchi 32, Firenze tel 055.6583501 Cartografia © Edizioni Multigraphic – via Corelli 55, Firenze tel 055.412908 Ogni riproduzione di testi, foto e cartografia è vietata Questa guida è stata redatta nel modo più accurato e attendibile, raccogliendo le informazioni più aggiornate. È comunque possibile che parte dei contenuti risulti superata nel tempo nel caso di spostamento delle fermate delle autolinee, cambia- menti di viabilità e percorribilità, variazioni delle caratteristiche del fondo stradale, carenze di segnaletica. Prima della partenza è importante informarsi sulle condizio- ni meteorologiche e tenere conto dei suggerimenti riportati in ogni scheda per poter percorrere gli itinerari con la preparazione adeguata e con un abbigliamento adatto. Geopoli – Pubblicazione periodica semestrale – Reg. Trib. Firenze n° 3709 del 18/05/1988 – Direttore responsabile: Fallani Giulio – Supplemento n° 14/2007 INDICE Presentazione pag. 5 Introduzione “ 7 La guida Bus + Trekking “ 9 ITINERARIO 1. Fra olivi e cipressi: Calenzano, Sommaia “ 13 ITINERARIO 2. L’acqua e la montagna: Colonnata - Castello “ 16 ITINERARIO 3. Monte Morello tra arte e storia: Serpiolle - Castello “ 20 ITINERARIO 4. Dal poggio alla pieve: Poggio Garena - Cercina “ 24 ITINERARIO 5. La valle del Mugnone e la via Faentina: La Querciola - Caldine “ 27 ITINERARIO 6. Dalla pietra alla città: Maiano - Fiesole “ 30 ITINERARIO 7. Sulle strade del Boccaccio: Ponte a Mensola - Compiobbi “ 34 ITINERARIO 8. Il sentiero della pietra bianca: Villamagna - La Fonte “ 38 ITINERARIO 9. Le colline a sud di Firenze: Antella “ 42 ITINERARIO 10. -
You Can Do in the City
FLORENCE CITY GUIDE ® SEPTEMBER 2020 WWW.WHEREITALIA.COM/FLORENCE AUTUMN TIPS ON LUXURY SHOPPING, DINING AND SIGHTSEEING GET A TOUR OF THE BEST DESTINATIONS IN ITALY JOURNEY TO THE CENTRE OF THE ART All you can do in the city SIGHTSEEING | MUSEUMS | SHOPPING | DINING | ENTERTAINMENT | MAPS DISCOVER MORE DISCOVER DISCOVER MORE Florence September 2020 VIA SESTESE ENTERTAINMENT CASTELLO SESTO 48 the guide apertura SIGHTSEEING FIORENTINO SVINCOLO SESTO FIORENTINO V I A 32 SHOPPING S AUTOSTRADA FIRENZE-MARE E S VI VIA XXV APRILE T A E VIA DEL CHIUSO DEI PAZZI G S E Antica Occhialeria is a . DUPRÈ VIA REGINALDO GIULIANI VIA DELLE PANCHE little gem for vintage VIA ANDREA COSTA glasses enthusiasts, VIA ANDREA COSTA VIA G. DUPRÈ Teatro Romano but also for lovers VIA FAENTINA VIA DE' PERFETTI RICASOLI VIA CARLO DEL GRECO Museo Bandini VIA MARINI VIA PORTIGIANI Cattedrale di San Romolo of models with SCONI BO STRAD A PROV INCIALE 54 DEI PIAZZA PIAZZA G.GARIBALDI MINO DA FIESOLE contemporary designs. VIA MASSICINI V. LUCCHESE A VIALE XI AGOSTO LUC V VIA SANT’APPOLINAR AUTOSTRADA FIRENZE-MARE I VIA S.CHIARA A E VIA SALVADOR ALLENDE F R À VIALE SAN G VIALE GAETANO PIERACCINI I VIA GI 42 DINING O ULI AENTINA V O CACCIN A N I N VIA F SOLANA I PONTE D A The full range of VIA DELLA BADIA DEI ROCCETTINI F I NUOVO E VIA REGINALDO GIULIANI S H I A F I E VIA DELLE PANCHE O FIESOLE L ALLA CC E D PIAZZA E Aeroporto Marchesi Antinori T Amerigo V I A V E T ENRICO O Vespucci PIGNONE BADIA L MATTEI VIA MANTELLINI ' A N G E VIA PRATESE L I C wines, accompanied by PIZZERIA O V I A U G O C O R S I SAN DOMENICO V. -
Scarica Il Booklet
1 UN GIARDINO IN PALAZZO Gli orti pensili della Reggia medicea Terrazzo di Saturno, Museo di Palazzo Vecchio 23 maggio - 25 settembre 2016 2 3 Il giardino pensile proposto sul Terrazzo di Saturno in Palazzo Vecchio rievoca gli orticini presenti a metà Cinquecento nella reggia ducale di Cosimo I de’ Medici e di Eleonora di Toledo. Vi invitiamo a leggere le pagine seguenti per comprendere il come e il perché di questo “apparato effimero” dedicato alla natura e alle piante, sperando di offrire un ulteriore spunto per la visita di questo meraviglioso palazzo. Per ragioni di sicurezza sarà possibile fruire del terrazzo e del giardino in massimo 30 persone contemporaneamente. Si raccomanda di non toccare le piante. 4 IL PALAZZO DUCALE Serena Pini Era […] il Duca con tutta la famiglia sua, con la corte dalla residenza di famiglia in lasciando la Casa de’ Medici, andato ad habi- via Larga (oggi via Cavour) al palazzo già tare nel Palagio publico Seggio proprio già della sede del governo repubblicano della città, Signoria, e dello Stato di Firenze, havendo si avvenuto nel maggio del 1540. Il giovane fatto adagiare ad uso di Principe quelle stan- Cosimo era subentrato ad Alessandro de’ ze, che già erano state de’ Priori, e del Gonfa- Medici, primo duca di Firenze, da poco più loniere; e seggio d’alcuni Magistrati […]. E di tre anni, ma era già riuscito ad assicurare quello fece volendo mostrare che era Principe stabilità al suo governo sconfiggendo i assoluto, e arbitro del Governo, e torre l’animo fuoriusciti repubblicani nella battaglia a coloro, che presumessero, come altre volte era di Montemurlo. -

April 2018 P&F Newsletter LONG
WELCOME The rain lingers on but it doesn’t matter, we will hide easter eggs in the garden and celebrate with our raincoats on! Easter is a time of colour and pageantry in Italy, as the Spring flowers reflect the honouring of rebirth and renewal. Enjoy sharing the special easter bread, eggs with surprises inside, and music and art returning all over the city as Tuscany warms up with sights on the coming summer. With best wishes from SUZANNE, CORSO, BEI, LESLIE, VANNI, ANNA PIA, RAFFAELLA, AND MARISA. PITCHER & FLACCOMIO PICKS FOR APRIL BEST EVENT FOR APRIL: SCOPPIO DEL CARRO ON EASTER SUNDAY April 1 Don’t miss the annual Easter tradition that has been celebrated in Florence for more than 350 years, dating back to the First Crusade. On the morning of Easter Sunday in Piazza del Duomo is the Scoppio del Carro, The Explosion of the Cart. Marking both Easter and Spring, the successful ignition of the cart guarantees good crops, a successful harvest, stable civic life and bountiful trade, as well as signifying the passage of new holy fire to light those extinguished on Good Friday. A thirty-foot carved and painted wooden cart (the present version is over 150 years old) is pulled by flower-bedecked white oxen from Porta al Prato to Piazza del Duomo. A very special Easter Sunday mass is held, a ritual that includes one of the best daytime fireworks displays in the world. It was during the pontificate of Leo X (Giovanni de'Medici, 1513-1521), that the ‘colombina’ - a mechanical bird shaped like a dove with an olive branch in its beak, representing the Holy Spirit - was used for the first time. -

Guida Agli Archivi Di Architetti E Ingegneri Del Novecento in Toscana
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER LA TOSCANA Guida agli archivi di architetti e ingegneri del Novecento in Toscana a cura di Cecilia Ghelli ed Elisabetta Insabato edizioniedifir firenze GUIDA © Copyright 2007 by Edifir-Edizioni Firenze s.r.l. Via Fiume, 8 - 50123 Firenze Tel. 055289639 - Fax 055289478 http://www.edifir.it - [email protected] Responsabile del progetto editoriale Simone Gismondi Responsabile editoriale Massimo Piccione Editing Elena Mariotti Progetto grafico Michele Gasparello Impaginazione Fabrizio Sodini Fotolito, impaginazione e stampa Pacini Editore Industrie Grafiche - Ospedaletto (Pisa) In IV di copertina: .... DE SETA, Architettura razionale, disegno tratto dalla rivista «Il travaso delle idee. Organo ufficiale delle persone intelligenti», Roma, anno 33, n. 14, 2 aprle 1933 Fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall’art. 68, comma 4, della legge 22 aprile 1941 n. 633 ovvero dall’accordo stipulato tra SIAE, AIE, SNS e CNA, ConfArtigianato, CASA, CLAAI, ConfCommercio, ConfEsercenti il 18 dicembre 2000. Le riproduzioni per uso differente da quello personale sopracitato potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata dagli aventi diritto/dall’editore. Photocopies for reader’s personal use are limited to 15% of every book/issue of periodical and with payment to SIAE of the compensation foreseen in art. 68, codicil 4, of Law 22 April 1941 no. 633 and by the agreement of December 18, 2000 between SIAE, AIE, SNS and CNA, ConfArtigianato, CASA, CLAAI, ConfCommercio, ConfEsercenti. Reproductions for purposes different from the previously mentioned one may be made only after specific authorization by those holding copyright/the Publisher.