Vendetta E Parentela Patrizia. Venezia, Inizio XVI Secolo
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Europa E Italia. Studi in Onore Di Giorgio Chittolini
21 CORE VENICE AND THE VENETO Metadata, citation and similar papers at core.ac.uk Provided by Reti Medievali Open Archive DURING THE RENAISSANCE THE LEGACY OF BENJAMIN KOHL Edited by Michael Knapton, John E. Law, Alison A. Smith thE LEgAcy of BEnJAMin KohL BEnJAMin of LEgAcy thE rEnAiSSAncE thE during VEnEto thE And VEnicE Smith A. Alison Law, E. John Knapton, Michael by Edited Benjamin G. Kohl (1938-2010) taught at Vassar College from 1966 till his retirement as Andrew W. Mellon Professor of the Humanities in 2001. His doctoral research at The Johns Hopkins University was directed by VEnicE And thE VEnEto Frederic C. Lane, and his principal historical interests focused on northern Italy during the Renaissance, especially on Padua and Venice. during thE rEnAiSSAncE His scholarly production includes the volumes Padua under the Carrara, 1318-1405 (1998), and Culture and Politics in Early Renaissance Padua thE LEgAcy of BEnJAMin KohL (2001), and the online database The Rulers of Venice, 1332-1524 (2009). The database is eloquent testimony of his priority attention to historical sources and to their accessibility, and also of his enthusiasm for collaboration and sharing among scholars. Michael Knapton teaches history at Udine University. Starting from Padua in the fifteenth century, his research interests have expanded towards more general coverage of Venetian history c. 1300-1797, though focusing primarily on the Terraferma state. John E. Law teaches history at Swansea University, and has also long served the Society for Renaissance Studies. Research on fifteenth- century Verona was the first step towards broad scholarly investigation of Renaissance Italy, including its historiography. -

VENICE Grant Allen's Historical Guides
GR KS ^.At ENICE W VENICE Grant Allen's Historical Guides // is proposed to issue the Guides of this Series in the following order :— Paris, Florence, Cities of Belgium, Venice, Munich, Cities of North Italy (Milan, Verona, Padua, Bologna, Ravenna), Dresden (with Nuremberg, etc.), Rome (Pagan and Christian), Cities of Northern France (Rouen, Amiens, Blois, Tours, Orleans). The following arc now ready:— PARIS. FLORENCE. CITIES OF BELGIUM. VENICE. Fcap. 8vo, price 3s. 6d. each net. Bound in Green Cloth with rounded corners to slip into the pocket. THE TIMES.—" Good work in the way of showing students the right manner of approaching the history of a great city. These useful little volumes." THE SCOTSMAN "Those who travel for the sake of culture will be well catered for in Mr. Grant Allen's new series of historical guides. There are few more satisfactory books for a student who wishes to dig out the Paris of the past from the im- mense superincumbent mass of coffee-houses, kiosks, fashionable hotels, and other temples of civilisation, beneath which it is now submerged. Florence is more easily dug up, as you have only to go into the picture galleries, or into the churches or museums, whither Mr. Allen's^ guide accordingly conducts you, and tells you what to look at if you want to understand the art treasures of the city. The books, in a word, explain rather than describe. Such books are wanted nowadays. The more sober- minded among tourists will be grateful to him for the skill with which the new series promises to minister to their needs." GRANT RICHARDS 9 Henrietta St. -

Le Vite Dei Dogi, 1423-1474 II
MARIN SANUDO IL GIOVANE LE VITE DEI DOGI 1423-1474 II TOMO 1457-1474 Introduzione, edizione e note a cura di ANGELA CARACCIOLO ARICÒ Trascrizione a cura di CHIARA FRISON Venezia 2004 Direttore della collana FERIGO FOSCARI Venezia La Malcontenta 2004 Tutti i diritti riservati INDICE DEL II TOMO Doge Pasquale Malipiero 3 Doge Cristoforo Moro 32 Doge Nicolò Tron 154 Doge Nicolò Marcello 191 Bibliografia del I e del II tomo – Principali studi e strumenti utilizzati 283 – Fonti edite 288 – Fonti manoscritte 290 Indice dei nomi del I tomo (Serena de Pont) 291 Indice dei nomi del II tomo (Elena Bocchia) 345 “VENETIAE GENIO URBIS” perché non tutto vada perduto A Chiara e ai miei studenti MARIN SANUDO IL GIOVANE LE VITE DEI DOGI 1423-1474 II TOMO 1457-1474 |f. 76v|a) [1457] Pasqualb) Malipiero Doxe fo creado per l’absolucion1 fat- ta nel Conseio d’i X con la Zonta di Francesco Foscari Doxe, non potendo più il Duca exercitar per la vechieza.2 A dì 23 ottubrio et a dì 24 fo chiamado Gran Conseio per dar principio alla elecione, et forno a Conseio zentilomeni circha nu- mero 800; et prima fo fatti li cinque Coretori qualli fo: sier Pollo Tron Procurator sier Christoffollo Moro Procurator questi veneno dopij et non sier Orsato Zustignian Procurator funo balotadi sier Michel Venier Procurator sier Nicolò Bernardo Questi Coretori il zorno drio – a dì 25 – meseno le sue parti,c) qual fo prese, zoè: sopra il terzo capittollo, che il Doxe sia obligatto far justicia, sia azonto: etiam alli nostri suditi; sopra il 333 che il Doxe non apri letere dil Papa, -

Patrician Lawyers in Quattrocento Venice
_________________________________________________________________________Swansea University E-Theses Servants of the Republic: Patrician lawyers in Quattrocento Venice. Jones, Scott Lee How to cite: _________________________________________________________________________ Jones, Scott Lee (2010) Servants of the Republic: Patrician lawyers in Quattrocento Venice.. thesis, Swansea University. http://cronfa.swan.ac.uk/Record/cronfa42517 Use policy: _________________________________________________________________________ This item is brought to you by Swansea University. Any person downloading material is agreeing to abide by the terms of the repository licence: copies of full text items may be used or reproduced in any format or medium, without prior permission for personal research or study, educational or non-commercial purposes only. The copyright for any work remains with the original author unless otherwise specified. The full-text must not be sold in any format or medium without the formal permission of the copyright holder. Permission for multiple reproductions should be obtained from the original author. Authors are personally responsible for adhering to copyright and publisher restrictions when uploading content to the repository. Please link to the metadata record in the Swansea University repository, Cronfa (link given in the citation reference above.) http://www.swansea.ac.uk/library/researchsupport/ris-support/ Swansea University Prifysgol Abertawe Servants of the Republic: Patrician Lawyers inQuattrocento Venice Scott Lee Jones Submitted to the University of Wales in fulfillment of the requirements for the Degree of Doctor of Philosophy 2010 ProQuest Number: 10805266 All rights reserved INFORMATION TO ALL USERS The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted. In the unlikely event that the author did not send a com plete manuscript and there are missing pages, these will be noted. -
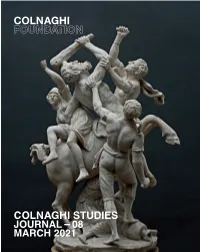
Journal 08 March 2021 Editorial Committee
JOURNAL 08 MARCH 2021 EDITORIAL COMMITTEE Stijn Alsteens International Head of Old Master Drawings, Patrick Lenaghan Curator of Prints and Photographs, The Hispanic Society of America, Christie’s. New York. Jaynie Anderson Professor Emeritus in Art History, The Patrice Marandel Former Chief Curator/Department Head of European Painting and JOURNAL 08 University of Melbourne. Sculpture, Los Angeles County Museum of Art. Charles Avery Art Historian specializing in European Jennifer Montagu Art Historian specializing in Italian Baroque. Sculpture, particularly Italian, French and English. Scott Nethersole Senior Lecturer in Italian Renaissance Art, The Courtauld Institute of Art, London. Andrea Bacchi Director, Federico Zeri Foundation, Bologna. Larry Nichols William Hutton Senior Curator, European and American Painting and Colnaghi Studies Journal is produced biannually by the Colnaghi Foundation. Its purpose is to publish texts on significant Colin Bailey Director, Morgan Library and Museum, New York. Sculpture before 1900, Toledo Museum of Art, Ohio. pre-twentieth-century artworks in the European tradition that have recently come to light or about which new research is Piers Baker-Bates Visiting Honorary Associate in Art History, Tom Nickson Senior Lecturer in Medieval Art and Architecture, Courtauld Institute of Art, underway, as well as on the history of their collection. Texts about artworks should place them within the broader context The Open University. London. of the artist’s oeuvre, provide visual analysis and comparative images. Francesca Baldassari Professor, Università degli Studi di Padova. Gianni Papi Art Historian specializing in Caravaggio. Bonaventura Bassegoda Catedràtic, Universitat Autònoma de Edward Payne Assistant Professor in Art History, Aarhus University. Manuscripts may be sent at any time and will be reviewed by members of the journal’s Editorial Committee, composed of Barcelona. -

Il Doge / the Doge
Fondazione Musei Civici di Venezia — Il Doge / The Doge ITA / ENG Il Doge / The Doge Il Doge è la più antica e potere, tra successioni The Doge was the oldest an elected position la più alta magistratura ereditarie, conflitti e and highest political and became more and della Repubblica di morti violente. position in the Venetian more powerful, with Venezia. A partire dal secolo Republic. hereditary successions, La parola deriva dal XI una Venezia ormai The word comes from conflicts and violent latino dux, che significa indipendente e in the Latin dux, which deaths. By the eleventh guida, capo ed è il titolo pieno sviluppo pone means leader, head and century, developing attribuito ai governatori fine a qualunque was the title given to the rapidly Venice had delle province pretesa dinastica governors of provinces become independent nell’impero bizantino, del doge, stabilisce in the Byzantine and put an end to any di cui il territorio della poi di affiancargli dei Empire, of which the dynastic claims of the laguna di Venezia è consiglieri, limitarne Venice lagoon was a doge. It was decided he parte quando, tra il VII e i poteri e vincolarlo, part in the seventh should be assisted by l’VIII secolo, si ha notizia all’elezione, con il and eighth centuries, councillors and that his Gentile Bellini, Ritratto del doge Giovanni Mocenigo (1478-1485), 1479 ca. dei primi dogi. giuramento della when documentation powers would be limited Tempera su tavola, cm 62 x 45 La sede del Promissione, un of the first doges is to upon his election, when Museo Correr, Venezia ducato è allora meticoloso insieme di be found. -

Stefano Colombo Volume 1 (Text)
A Thesis Submitted for the Degree of PhD at the University of Warwick Permanent WRAP URL: http://wrap.warwick.ac.uk/94209 Copyright and reuse: This thesis is made available online and is protected by original copyright. Please scroll down to view the document itself. Please refer to the repository record for this item for information to help you to cite it. Our policy information is available from the repository home page. For more information, please contact the WRAP Team at: [email protected] warwick.ac.uk/lib-publications The Rhetoric of Celebration in Seventeenth-Century Venetian Funerary Monuments Volume One of two volumes (Text) by Stefano Colombo A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the History of Art at the University of Warwick. This dissertation may not be photocopied. University of Warwick, Department of the History of Art December 2016 Table of Contents Table of Contents ................................................................................................ i Acknowledgements ........................................................................................... iv Declaration ......................................................................................................... v Abstract .............................................................................................................. vi List of Abbreviations ........................................................................................ vii List of Illustrations ......................................................................................... -

271 Bis Cancelleria Inferiore. Doge
271 bis Cancelleria inferiore. Doge Avvertenze L’Archivio del Doge, Cancelleria inferiore, consta complessivamente di 265 pezzi numerati progressivamente da 1 a 266 e copre gli anni che vanno dal 1364 al 1804. E’ suddiviso in cinque sezioni A-E: A) Doge. Lettere (per esecuzione di sentenze), nn. 1-77 B) Doge. Atti, nn. 78 bis-157 C) Doge. Promissioni, nn. 157 A -163 D) Doge. Varia, nn. 164-176 E) Doge. Giurisdizioni, nn. 177-226 È composto generalmente da registri, spesso serviti da alfabeto, buste e, seppur in minore numero, da filze. Di ogni registro, busta, filza sono stati indicati gli estremi cronologici e l’ oggetto; all’interno dei singoli pezzi archivistici è stata individuata e segnalata la presenza di eventuali fascicoli e sottofascicoli. Annotazione a margine illustrano succintamente la natura dell’unità archivistica, la sua consistenza, le particolarità notevoli. Al momento della compilazione del presente inventario non si sono trovati i nn. 77-78, 176. Il presente inventario è stato compilato a cura degli archivisti di Stato dott.ssa Giorgetta Bonfiglio e dott. Franco Rossi. Archivio di Stato di Venezia Ottobre 1979 L'inventario è stato trascritto in formato digitale da Renata Moressa; revisione Monica Del Rio (marzo 2020) Indice generale Avvertenze.................................................................................................................................................................................................................................................2 A. Doge. Lettere (per esecuzione sentenze)..............................................................................................................................................................................................4 -

Venetian Coins
A. H. BALDWIN & SONS LTD. Established 1872 Tel: 020-7930-6879 11 Adelphi Terrace Fax: 020-7930-9450 London WC2N 6BJ e-mail: [email protected] __________________________________________________________________ Coins of Venice For sale at fixed prices August 2005 Pietro Ziani (1205 – 1229) 1. Grosso, +.P.ZIANI. S.M.VENETI D|V|X, S. Marco standing on the right and the Doge on the left, rev. IC XC, Christ enthroned, 2.22g (Paolucci 16.1; Gamberini 20; Biaggi 2766), good very fine £70 Jacopo Tiepolo (1229 – 1249) 2. Grosso, IA.TEV.PL’.X.M VENETI.D|V|X, S. Marco standing on the right and the Doge on the left, rev. IC XC, Christ enthroned, 2.16g (Paolucci 17.1; Gamberini 24; Biaggi 2769), good very fine £60 1 Marino Morosini (1249 – 1253) 3. Grosso, .M.MAVROC. .S.M VENETI.D|V|X, S. Marco standing on the right and the Doge on the left, rev. IC XC, Christ enthroned, 2.13g (Paolucci 18.1; Gamberini 28; Biaggi 2772), scarce, nearly very fine £50 Ranieri Zeno (1253 – 1268) 4. Grosso, .RA.GENO.SM.VENETI DVX, S. Marco standing on the right and the Doge on the left, rev. IC XC, Christ enthroned, 2.14g (Paolucci 19.1; Gamberini 32; Biaggi 2775), toned, very fine £40 Lorenzo Tiepolo (1268 – 1275) 5. Grosso, .LA TEVPL’. .SM. VENETI D|V|X, S. Marco standing on the right and the Doge on the left, rev. IC XC, Christ enthroned, 2.16g (Paolucci 20.1; Gamberini 36; Biaggi 2778), good very fine £75 Jacopo Contarini (1275 - 1280) 6. -

HSSE Online Is Published by the HSSE Academic Group, National Institute of Education (NIE), Singapore
HSSE Online is published by the HSSE Academic Group, National Institute of Education (NIE), Singapore. The overarching purpose of the journal is to energize, inform and improve teaching practice in Humanities and Social Studies education in Singapore and to provide a venue to share ideas, research and resources that will be useful to teachers and scholars. We seek to develop and deepen knowledge and understanding of powerful and innovative research and practice in Humanities and Social Studies education. We hope you will make use of these ideas and resources as well as contribute your own. Copyright © Humanities & Social Studies Education (HSSE) Academic Group 2012 A Note from the Editors It has almost become a cliché to claim that the humanities subjects are integral to education for young people. While many people pay lip service to the importance of subjects such as history, geography, and social studies, in practice, this is not been consistently reflected in the actions and choices of educators, policy makers, parents, and students in Singapore and elsewhere. Thus it is timely that this issue includes an article written by Mark Baildon reminding us of how the humanities subjects are essential for the well-being of both the individual and society. Anecdotal and empirical evidence suggest that teachers frequently deem these subjects to be too challenging for weaker students. As teacher educators, we have heard too many teachers proclaim that this content or these skills are too difficult for their students and make claims that their students will, for example, not be able or willing to engage in thought-provoking inquiry activities or tasks. -

Jacopo Sansovino's Monument to Doge Francesco Venier in San
For Charles Avery 89 Family matters: Jacopo Sansovino’s Monument to Doge Francesco Venier in San Salvador, Venice VICTORIA AVERY AND EMMA JONES 1 After his election as Doge of Venice in June 1554, foretold his election to the dogeship, a prediction in Francesco Venier (1489-1556) changed his modest which the young Francesco firmly believed despite sepulchral plans to something more in keeping with his weak constitution, and a destiny reinforced during his new position as head of state. Instead of a simple his late forties when, as ambassador to Rome, he burial of “little pomp” in the far-flung church of San was dubbed “The Little Doge” by Pope Paul III. A Francesco della Vigna, Venier secured a prominent, wealthy but modest-living and highly devout bachelor, well-located site within the prestigious and centrally- Francesco resided in a rented property in central Venice located church of San Salvador, stipulating that no less with his brother Piero, his eventual chief executor and than 1,000 ducats be spent on his funerary monument. primary beneficiary. Francesco was a gifted orator, The posthumous sepulchral commission – overseen astute diplomat and able administrator with great by Venier’s beloved brother Piero – resulted in the tenacity. On 11 June 1554, just after his sixty-fifth enormous gilded, polychrome marble and stone birthday, he was elected eightieth doge of Venice.4 monument still in situ today (fig. 1), adorned with sculptures by two of Venice’s greatest cinquecento Upon his election, Venier commissioned his official sculptors, Jacopo Sansovino (ca. 1486-1570), and his portrait from Titian, to join those of his predecessors erstwhile assistant, Alessandro Vittoria (ca. -

Long Live the King? Death As a Term Limit on Executives*
Long Live the King? Death as a Term Limit on Executives* Daniel J. Smith† George R. Crowley‡ J. Sebastian Leguizamon§ Abstract Can informal term limits place binding constraints on executives? And, are there conditions under which an electorate would forego formal term limits in favor of informal term limits? Formal term limits face three primary problems: they can be dispensed by powerful executives, they limit electorate discretion on term length, and they artificially shorten an executive’s time horizon. This paper extends the literature on term limits by building a model of informal term limits which overcomes these deficiencies. Our model demonstrates that an electorate could use the death of a lifetime-appointed executive, based on their projected life expectancy, to enforce binding, informal term limits. Informal term limits would enable the electorate to exercise discretion in adjusting tenure lengths when considering the tradeoff between the expected benefits of regime stability, such as experience, and the expected costs of long tenures, including the possibility of tyranny. In addition, this informal term limit would be congruent with an executive’s natural time horizon. Informal term limits would be most advantageous to an electorate fearful of both internal (tyranny) and external (military conquest) threats. A historical case study of ducal elections in late Middle Age and Renaissance Venice provides evidence of an electorate in this circumstance, the patricians of Venice, imposing informal term limits on their executives utilizing the projected life expectancy of ducal candidates at election. Keywords: Term Limits; Public Choice; Venice; Economic History JEL Codes: D7; H2; H7; N4 * The authors thank Christopher J.