Nuove Ricerche Sull'insediamento Islamico Presso Il Garigliano
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Map 44 Latium-Campania Compiled by N
Map 44 Latium-Campania Compiled by N. Purcell, 1997 Introduction The landscape of central Italy has not been intrinsically stable. The steep slopes of the mountains have been deforested–several times in many cases–with consequent erosion; frane or avalanches remove large tracts of regolith, and doubly obliterate the archaeological record. In the valley-bottoms active streams have deposited and eroded successive layers of fill, sealing and destroying the evidence of settlement in many relatively favored niches. The more extensive lowlands have also seen substantial depositions of alluvial and colluvial material; the coasts have been exposed to erosion, aggradation and occasional tectonic deformation, or–spectacularly in the Bay of Naples– alternating collapse and re-elevation (“bradyseism”) at a staggeringly rapid pace. Earthquakes everywhere have accelerated the rate of change; vulcanicity in Campania has several times transformed substantial tracts of landscape beyond recognition–and reconstruction (thus no attempt is made here to re-create the contours of any of the sometimes very different forerunners of today’s Mt. Vesuvius). To this instability must be added the effect of intensive and continuous intervention by humanity. Episodes of depopulation in the Italian peninsula have arguably been neither prolonged nor pronounced within the timespan of the map and beyond. Even so, over the centuries the settlement pattern has been more than usually mutable, which has tended to obscure or damage the archaeological record. More archaeological evidence has emerged as modern urbanization spreads; but even more has been destroyed. What is available to the historical cartographer varies in quality from area to area in surprising ways. -

Le Golfe Gaeta
AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA DELLA PROVINCIA DI LATINA SOMMARIO IL GOLFO DI GAETA Informazioni p. 1 Come arrivare p. 2 Il Golfo di Gaeta p. 4 Le località p. 8 Le Isole Pontine p. 22 Sport e tempo libero p. 24 Stabilimenti balneari p. 26 Locali notturni e ritrovi tipici p. 27 Folklore e manifestazioni p. 28 Gastronomia p. 30 Ambiente e natura p. 32 Per informazioni sull’area e sulle località contenute nella pubblicazione, rivolgersi ai seguenti uffici turistici: Pour tous reinsegnements sur la zone et sur les localités présentées dans cette publication, s’adresser aux bureaux de tourisme suivantes: A.P.T. – Azienda di Promozione Turistica della Provincia di Latina Via Legnano, 42 04100 LATINA – Tel. 0773695404 – Fax 0773661266 www.aptlatinaturismo.it e www.latinaturismo.it - e-mail: [email protected] Ufficio Informazioni: Piazza del Popolo – Tel. 0773480672 I.A.T. – Uffici Informazioni e Assistenza al Turista - Bureaux de renseignements Ideazione Formia Pier Giacomo Sottoriva Viale Unità d’Italia, 30 – 34 (C.A.P. 04023) Tel. 0771771490 - Fax 0771323275 Testi Gaeta Maria Caterina Santini Via E. Filiberto, 5 (C.A.P. 04024) – Tel. 0771461165 – Fax 0771450779 Foto Minturno–Scauri Archivio APT Latina, P. Petrignani, Via Lungomare, 32 (C.A.P. 04028) – Tel. 0771683788 – Fax 0771620829 P. Silvano, L. Orilia, Terracina S. Vannini, Archivio IGDA Via Leopardi (C.A.P. 04019) – Tel. 0773727759 – Fax 0773721173 Coordinamento redazionale Bruno Maragoni, Anna Maria ORGANISMI TURISTICI DI CATEGORIA/ORGANISMES TOURISTIQUES DE CATÉGORIE Mantione Associazione Provinciale Albergatori – c/o Confcommercio Grafica Via dei Volsini, 46 – 04100 Latina – Tel. 0773610678 Alberto Costa, Marco Stingo Traduzioni Confcommercio Latina – Via dei Volsini, 46 – 04100 Latina – Tel. -
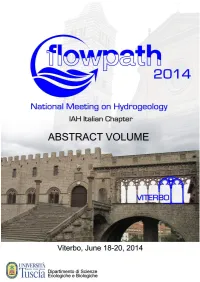
Volume-Abstract-Flowpath-2014.Pdf
Legal Notice Neither the Publisher nor any persons acting on behalf of the Publisher is responsible for the use which may be made of the following information. Abstracts published in this volume were reviewed and the opinion of the Reviewers, concerning the originality and scientific value, decides about including an abstract into the volume. However, neither the Reviewers, nor the Editors and the Publisher assume the responsibility for errors, linguistic or numerical, which is fully responsibility of Authors. The Authors were responsible for referring to appropriate and complete references and for obtaining the necessary permission to reproduce copyright materials and date from other sources. Title Flowpath 2014, National Meeting on Hydrogeology Abstract Volume Editors Antonella Baiocchi Francesca Lotti Silvano Onofri Vincenzo Piscopo Technical editing Antonella Baiocchi Francesca Lotti Simone Maria Piacentini Printing Leograph.it – Vetralla (VT) Via Cassia 201, Vetralla (VT) www.leograph.it [email protected] Copyright © Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche, ISBN 978-88-907553-4-7 Università degli Studi della Tuscia, 2014 The Organizing Committee (IAH Italian Chapter) Vincenzo Piscopo (Chair), Giovanni Barrocu, Daniela Ducci, Fulvio CelicoPaolo Cerutti, Antonio Dematteis, Paolo Fabbri, Maria Dolores Fidelibus, Alessandro Gargini, Francesco La Vigna, Marco Masetti, Marco Petitta, Maurizio Polemio, Viviana Re, Andrea Sottani. The Scientifc Committee Giovanni Pietro Beretta,Tullia Bonomi, Alfonso Corniello, Marina De Maio, Marco Doveri, Walter Dragoni, Mauro Giudici, Stefano Lo Russo, Francesca Lotti, Grazia Martelli, Micòl Mastrocicco, Torquato Nanni, Elisabetta Preziosi, Sergio Rusi, Giuseppe Sappa, Marco Tallini. _________________________________________________________________________________ Viterbo, Italy – June 18 – 20, 2014 FOREWORD FLOWPATH 2014, the National Meeting on Hydrogeology, Viterbo 2014, follows up on previously organized and successful meeting FLOWPATH 2012 held in 2012 in Bologna. -

Dati Anagrafici E Personali
DATI ANAGRAFICI E PERSONALI Dott. TESTA GIOVANNI nato a Belfort ( Francia ) il 04 Aprile 1965 e residente a Castelforte in via Garibaldi n°135, Cap 04021 (LT) —cell. 349.4267366; e-mail [email protected]. STUDI 1983 -1984 Diploma di Maturità Sperimentale di Tecnico di Ragioneria e Perito Commerciale, conseguito presso l’Istituto “G. Filangieri” di Formia; 1990-1991 attestato di frequenza dell’8° Corso Ufficiali per Personale Militare in congedo svolto presso il IX Centro di Mobilitazione C.R.I. di Roma; 1992-1993 attestato di Qualifica Professionale in Operatore Terminale Video svolto presso il comune di Pontecorvo (Frosinone) ed a cura della Regione Lazio Assessorato all’Istruzione Professionale; 1996 attestato al Corso di Diritto Internazionale Umanitario svoltosi a Gaeta, organizzato dalla C.R.I. Comitato Provinciale di Latina; 2000-2001 corso teorico-pratico di “Emergenze Internistiche e Protocolli Terapeutici” della Scuola Medica Ospedaliera, svoltosi presso l’ospedale S. Giovanni Addolorata di Roma; 2002.2003 corso teorico-pratico di “Argomenti di Medicina Interna” della scuola Medica Ospedaliera, svoltosi presso l’Ospedale S. Giovanni Addolorata di Roma; Luglio 2003 laurea in Medicina e Chirurgia, conseguita presso l’Università “La Sapienza” di Roma con tesi sperimentale dal titolo: “Gli aspetti della malattia celiaca dell’adulto nella risonanza magnetica”. 19/11/2003 Partecipazione al meeting “Microalbuminuria Setting Training”. Novembre 2003 Abilitazione all’esercizio professionale presso l’Università “La Sapienza” di Roma; 20-21/01/2004 partecipazione al convegno studi “Mobbing-Impresa responsabile, etica nell’economia-legislazione europea ed italiana aspetti giuridici e clinici” organizzato da INAS, A.GI.FOR., Ass.ONLUS; 25/03/2004 partecipazione al convegno “Tumori neuroendocrini” organizzato da EnDiaMet Lazio; ed altri…………. -

La Montagne Province De Latina
AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA DELLA PROVINCIA DI LATINA AGENCE DE PROMOTION TOURISTIQUE DE LA PROVINCE DE LATINA Monti LEPINI AUSONI Turismo - Arte AURUNCI Storia - Tempo Libero Tourisme - Art Histoire - Loisirs Monti LEPINI - AUSONI - AURUNCI Per informazioni sull’area e sulle località contenute nella pubblicazione, rivolgersi ai seguenti uffici turistici: Pour d’éventuelles renseignements sur la région et les localités figurant dans cette publication, s’adresser aux offices de tourisme suivants: A.P.T. Azienda di promozione Turistica della Provincia di Latina A.P.T. AGENCE DE PROMOTION TOURISTIQUE DE LA PROVINCE DE LATINA REGIONE LAZIO Via Duca del Mare, 19 - (C.A.P. 04100) Tel. 0773695404 - Fax 0773661266 - Latina www.aptlatinaturismo.it - www.latinaturismo.it - e-mail: [email protected] Ufficio Informazioni/Bureau de renseignements: Piazza del Popolo, Tel. 0773480672 - Latina I.A.T. Uffici informazioni e assistenza al turista I.A.T. bureaux dE RENSEIGNEMENTS et d’assistance au touriste Coordinamento redazionale Coordination de la rédaction: Formia Minturno-Scauri Pier Giacomo Sottoriva, Bruno Maragoni, Anna Maria Mantione, Viale Unità d’Italia, 30-34 (c.a.p. 04023) Via Lungomare, 32 (c.a.p. 04028) Maria Caterina Santini, Roberto Gori. Testi/ Textes: Tel. 0771771490 - Fax 0771323275 Tel. 0771683788 - Fax 0771620829 Bruno Maragoni, Anna Maria Mantione, Maria Caterina Santini Gaeta Terracina Foto/ Photos: Archivio Apt Latina, Paolo Petrignani, Via E. Filiberto Via Leopardi (c.a.p. 04019) Luciano Romano, Sandro Vannini, Tel. 0771461165 - Fax 0771450779 Tel. 0773727759 - Fax 0773721173 Franco Alessi Stampa/ Impression: All’interno sono indicati altri numeri telefonici locali per ulteriori informazioni / Vous trouverez à l’intérieur d’autres numéros de téléphone pour de plus amples Tipografia Monti s.r.l. -
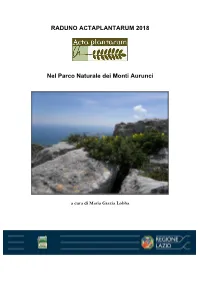
La Flora Dei Monti Aurunci Pteridophyta Aspleniaceae Asplenium Ceterach L.– MC in Quasi Tutta La Regione; Rupi, Muri, 0-1500 M Asplenium Obovatum Viv
RADUNO ACTAPLANTARUM 2018 Nel Parco Naturale dei Monti Aurunci a cura di Maria Grazia Lobba Il Parco Naturale dei Monti Aurunci Il Parco naturale dei Monti Aurunci, istituito con Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 della Regione Lazio (Art. 44, c. 1 lett. b), situato al Sud del Lazio, vanta un territorio eterogeneo, compreso in una fascia altimetrica che va dalla pianura a circa 30 metri s.l.m. fino alla quota di 1533 metri s.l.m. del Monte Petrella che si erge a poca distanza dalla costa. La catena dei Monti Aurunci possiede un misterioso fascino, segnando la conclusione del più importante sistema montuoso del Preappennino Laziale, di cui fanno parte anche i Monti Lepini e i Monti Ausoni. Gli Aurunci hanno la particolarità di essere l’unica catena montuosa laziale ad affacciarsi direttamente sul Mare Tirreno con vette che superano i 1500 metri. Il paesaggio dei Monti Aurunci regala scorci di grande suggestione; dalle cime più elevate della catena montuosa si possono scorgere le isole ponziane, il promontorio del Circeo, la Valle del Liri, i Monti del Matese e i Monti dell’Appennino abruzzese. Il paesaggio dei Monti Aurunci ha subito una lenta e graduale trasformazione dovuta alle attività antropiche che hanno prodotto opere di modifica del territorio, come ad esempio i terrazzamenti e i muri a secco, detti macere, realizzati per la coltivazione di uliveti. La millenaria presenza umana sugli Aurunci è testimoniata ancora meglio dagli antichi monasteri e dai piccoli rifugi, dai resti di dimenticate città e dall’eco di passate leggende che segnano il territorio del Parco Naturale dei Monti Aurunci. -
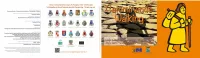
Indice | Index
Camminando Walking www.francigenapontina.it Lungo la Via Francigena nel Sud - Direttrice Appia Along South Francigena Way-the Appian way track INDICE | INDEX PRESENTAZIONE/PRESENTATION ...............................................................................................9 LE TAPPE DEL CAMMINO/THE STAGES OF THE JOURNEY Introduzione | Introduction ............................................................................................................15 Suio/Castelforte - Santi Cosma e Damiano - Minturno ............................................................ 17 Minturno - Formia (VARIANTE/VARIATION: Scauri-Parco Regionale Monte di Gianola-Maranola-Formia) ...............................................................25 Formia/Gaeta - Itri - Fondi .............................................................................................................35 Fondi - S.Magno - Monte S.Biagio - Terracina ........................................................................... 45 Terracina - La Fiora - Fossanova (VARIANTE/VARIATION: Terracina - Madonna della Delibera - Campo Soriano - Fossanova).....................................................51 Fossanova - Priverno - Sezze (VARIANTE/VARIATION: Maenza - Carpineto - Montelanico - Segni - Cori) .................................................................................. 59 Sezze - Bassiano ...............................................................................................................................67 Bassiano - Santuario Crocifisso - Sermoneta ........................................................................... -

Nolite Nocere Terrae Et Mari Nec Arboribus Touristicc, Arotistinc Antdehisntoritc Istineraries
Nolite nocere terrae et mari nec arboribus TouristiCc, arotistinc antdehisntoritc istineraries. Aprilia Cisterna di Latina 8 Ninfa Rocca Massima Sermoneta Cori Valvisciolo Norma Bassiano Sezze Touristic, artistic and historic itineraries. 14 22 Latina Sabaudia Roccagorga Editorial project and coordination Pontinia Maenza Pier Giacomo Sottoriva and Bruno Maragoni 30 Prossedi Pisterzo Texts 44 Pier Giacomo Sottoriva (based on “Piccolo Grand Tour” Fossanova by Pier Giacomo Sottoriva, revised and adapted Priverno by Pier Giacomo Sottoriva and Bruno Maragoni). Roccasecca dei Volsci San Felice Circeo Terracina Translation Sonnino Quadrivio Traduzioni Roma 50 58 Photography Monte S.Biagio Apt Latina Archives, Fabrizio Ardito, Diego Caruso, Fondi Gaeta Martino Cusano, Attilio Francescani, Paola Ghirotti, I-BUGA, Lenola Formia Campodimele Minturno Noé Marullo, Bruno Maragoni, Paolo Petrignani, Carlo Picone, 66 Itri Luciano Romano, Pier Giacomo Sottoriva, Sandro Vannini. Sperlonga 80 Layout and graphic design Spigno Saturnia Guercio Design di Latina Castelforte The Pontine Printing Suio Terme Islands Primaprint - Viterbo (2010) SS.Cosma e Damiano 96 Published by Azienda di Promozione Turistica della Provincia di Latina 92 04100 Latina, Via Duca del Mare, 19. Tel. 0773.695404 Fax 0773.661266 www.latinaturismo.it [email protected] Established in 1934, the province of Latina (33 municipalities) extends over Touristic, artistic and historic itineraries. 2,250 square kilometres, covering al - most equal proportions of hilly, moun - THE PROVINCE OF LATINA tainous areas (the Volsci mountains, divided into the Lepini, Ausoni and Au - runci mountain ranges) and coastal plains (the Pontine, Fondi-Monte San Biagio and Garigliano plains). The geo - graphic features and ancient human settlements make it an extremely inte - resting area to visit. -

Templari a Suio, Ma L’Ipotesi Non È Da Scartare Del Tutto
UNA PRESENZA TEMPLARE A SUIO, NEL LAZIO MERIDIONALE. Suio è un piccolo paese di collina, in provincia di Latina, a 150 Km a sud di Roma, ai confini con la Campania e a 10 Km dal mare. Antica contea, dagli inizi del secolo scorso è stato aggregato, insieme con il suo territorio, al comune di Castelforte, di cui ancora oggi è una frazione. A testimoniare la sua antica nobiltà, i ruderi del castello turrito ancora dominano la sottostante piana del Garigliano. La zona ha origini più remote della stessa Roma: gli Aurunci, popolazione italica pre-romana, vi avevano edificato la loro città più importante, Vescia, ricordata da Tito Livio nelle sue storie, distrutta dai romani dopo la vittoria riportata sulla Lega Latina, di cui gli Aurunci, insieme con gli altri popoli del Lazio, facevano parte. Per assicurare la vittoria al suo esercito, il console romano Publio Decio Mure si immolò volontariamente agli dei in sacrificio umano: è quanto avvenne nelle campagne di Suio il giorno precedente la cruenta battaglia fratricida che vide contrapposti due eserciti, quello romano e quello latino, fino a poco tempo prima alleati e formati alla stessa scuola militare. La battaglia, denominata del Veseris dall’antico nome dell’attuale piana del Garigliano, assicurò ai Romani il dominio definitivo sul “Latium Novum”, le attuali provincie di Latina e Frosinone a sud di Roma. Dell’antica Vescia non si conosce neanche il sito esatto. Ma tre iscrizioni di epoca imperiale ne ricordano l’esistenza. La prima menziona un “Pagus Vescinus”, che con un impegno finanziario volle dotarsi di un teatro; la seconda celebra Settimio Severo che “sua pecunia” lastricò la strada che da Minturnae, città sulla costa e sulla via Appia, conduceva ad “Aquas Vescinas”; la terza è un ex voto posto da due “servi dispensatores” al “Genio Aquarum Vescinarum” perchè fosse garantita la salute, la vittoria ed il ritorno di Antonino (=Caracalla) e Geta, suo fratello, figli di Settimio Severo, impegnati, nel 211-212 d.C., in una impresa bellica in Britannia. -

1A Parte Inglese Da 4-08
PROVINCE OF LATINA TOURISM OFFICE AMT FÜR DIE FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS IN DER PROVINZ LATINA Monti LEPINI AUSONI Tourism - Art AURUNCI History - Leisure Tourismus - Kunst Geschichte - Freizeit Monti LEPINI - AUSONI - AURUNCI Contact the following tourist offices for information concerning the area and places mentioned herein. Für Auskünfte über das Gebiet und die Orte dieser Ausgabe sich an die nachstehenden Geschätsstellen wenden: A.P.T. Province of Latina Tourist Office A.P.T. Amt für die Förderung des Fremdenverkehrs in der Provinz Latina REGIONE LAZIO Via Duca del Mare, 19 - 5. Stock - 04100 LATINA Tel. 0773695404/07 - Fax 0773661266 Information bureau: Piazza del popolo - Latina - Tel. 0773480672 www.aptlatinaturismo.it - www.latinaturismo.it - e-mail: [email protected] I.A.T. – Tourist Information and assistance Offices I.A.T. Auskunftsstelle und Hilfeleistung für Touristen Formia Minturno-Scauri Editing co-ordinated by Viale Unità d’Italia, 30-34 (04023) Via Lungomare, 32 (04028) Redaktionelle Koordinierung: Tel. 0771771490 - Fax 0771323275 Tel. 0771683788 - Fax 0771620829 Pier Giacomo Sottoriva, Bruno Maragoni, Anna Maria Mantione, Gaeta Terracina Maria Caterina Santini, Roberto Gori. Texts / Texte: Via E. Filiberto, 5 Via Leopardi (04019) Bruno Maragoni, Anna Maria Mantione, Maria Caterina Santini Tel. 0771461165 - Fax 0771450779 Tel. 0773727759 - Fax 0773721173 Photographs/ Fotos: Archivio Apt Latina, Paolo Petrignani Luciano Romano, Sandro Vannini, Additional telephone numbers are given in the text/Im Text sind weitere örtliche Rufnummern für zusätzliche Auskünfte aufgeführt. Franco Alessi Printing/ Druck: Tipografia Monti s.r.l. Cisterna di Latina - 2008 THE AREA DAS GEBIET The Apennines run through the province of Latina branching out pa- Die Apenninen durchqueren das Gebiet der Provinz Latina der Länge nach, rallel to the Tyrrhenian Sea and constitute an alternative to the more tra- fast parallel zum Tyrrhenischen Meer. -

Atlas of Italian Irrigation Systems
Atlas of Italian Irrigation systems Edited by Raffaella Zucaro Atlas of Italian Irrigation systems Edited by Raffaella Zucaro April 2014 “Not everything that counts can be counted and not everything than can be counted, counts” (Albert Einstein) ATLAS OF ITALiaN IRRIGATION SYSTEMS 2014. A traslated version of the “Atlante Nazionale dell’irrigazione” Roma, INEA 2011 Editor: Raffaella Zucaro Editorial staff: Antonella Pontrandolfi (Coordinator), Gian Marco Dodaro, Cristina Gallinoni, Ciro Luca Pacicco and Michele Vollaro. Technical team supporting editorial staff: Antonio Gerardo Pepe (Coordinator), Simona Capone and Fabrizio Mirra. Graphic Design and Layout: Fabio Lapiana Publishing Coordination: Benedetto Venuto Publishing Secretary: Roberta Capretti English Translation: Laura Maurano Introduction of the President of INEA The agricultural development of different areas in to support decision making. In fact, since the nineties Italy has been closely associated with access to water. INEA, on the base of precise guidelines received from Crop Irrigation systems have always been an asset in the European Commission and the Italian Ministry of terms of revenue and employment. These are the main Agriculture, has resumed its research on these issues reasons why in 1961, on the occasion of the 100th an- through specific surveys. The surveys, starting from niversary of the Italian Unification, the Italian Ministry portraying the need for general knowledge updating re- of Agriculture started up a specific survey entrusted lated to water use in agriculture (irrigated crops, ir- to INEA on Italian irrigation and the possible develop- rigation schemes, economic and managerial aspects ments of the sector in the different Italian regions, which etc.), delve into new research issues, such as public sec- led to the publication of the ‘Map of Irrigation in Italy’. -

The Geology and Hydrogeology of the Cassino Plain (Central Apennines, Italy): Redefining the Regional Groundwater Balance
Hydrogeology Journal https://doi.org/10.1007/s10040-019-01953-w REPORT The geology and hydrogeology of the Cassino plain (central Apennines, Italy): redefining the regional groundwater balance Michele Saroli1 & Michele Lancia2,3 & Marco Petitta4 Received: 12 September 2018 /Accepted: 18 February 2019 # The Author(s) 2019 Abstract Cassino plain is a Quaternary intermontane basin of the central-southern Apennines, Italy. The plain has outstanding groundwater resources (total discharge of 23,000 L/s), thanks to the huge karst basins that surround the area. The area has been involved in many hydrogeological interests since the 1970s due to the economic importance and construction of the Western Campania Aqueduct for the water supply of Naples city and its hinterland. Despite its importance, the area lacks a common accepted hydrogeological conceptual model due to the complex geological setting. Two contrasting conceptual models already exist in the literature, with the first model based on a quantitative hydrogeological approach and the second on fieldwork. Through a literature analysis and further detailed field surveys, a new conceptual model is presented, acknowledging the thrust tectonics of the Apennine chain. The model unveils the most important hydrogeological issues of the area, serving as a useful tool for groundwater management, as well as for considering the changing anthropic and climate scenarios. In particular, the study redefines the hydrostructure extents and the groundwater flowpaths, characterizing the main water resources as Gari and Peccia springs. Keywords Conceptual model . Groundwater management . Italy . Karst . Tectonics Introduction areas. Because of its geological and hydrogeological setting, the Cassino plain represents one of the most important con- The karst basins of central Italy host huge groundwater re- fluence points of groundwater flow, with discharges that vary sources, representing a strategic water resource (Ford and from 18,000 to 23,000 L/s (Boni et al.