De Minimis... Schede Leopardiane
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Necrologio A. Ranieri
ANTONIO RANIERI [NOTIZIA DELLA MORTE DEL] CONTE GIACOMO LEOPARDI. apparsa sul giornale “Il Progresso” vol. XVII, anno VI, Napoli, 1837 a cura di Angelo “quixote” Fregnani AQF Salve o fedel, che di tua nave a prua Sol virtù candidissima volesti, La qual ti scorse ove non son confini. (M. G. Guacci-Nobile, 1838) © 2009 AQF, Cesena ovvero Angelo “quixote” Fregnani via Garampa, 9862 47522 Cesena. — Le parti dovute al curatore, per essere riprodotte, richiedono preventivo assenso. Chi necessitasse la password di sblocco, può ottenerla inviando una mail – anche in bianco - con oggetto Password Necro837 all’indirizzo: afregnani <at/chiocciola> infinito <dot/punto>it Si pubblica questo brevissimo scritto, in quanto poco citato anche dai maggiori biografi leopardiani, e quasi mai ripresentato nel suo dettato originale1. Il 17 giugno 1837, a tre giorni dalla morte di Giacomo Leopardi, il Ranieri scriveva al conte Monaldo per annunciargli il triste evento. Pochi giorni dopo, il 26 giugno, riprendeva la penna per descrivergli in dettaglio gli ultimi giorni del poeta. Con più misura, il 18 luglio, gli accennava e accludeva: «la prima notizia che ho mandata del mio adorato amico a questo nostro giornale letterario intitolato il Progresso» (sc. “Il Progresso delle Scienze, delle Lettere e delle Arti”, vol. XVII, Anno VI, n. 33, quaderno di maggio, Napoli, dalla Tipografia Plautina, 1837, p. 166 s.). Si tratta di un breve necrologio, che da qualcuno, non del tutto a torto, è stato definito la miglior cosa scritta dal Ranieri su Leopardi. E certo non ha né la pesantezza né la prolissità della Notizia2 premessa all’edizione fiorentina del ‘45, e nella sua essenzialità, merita di essere conosciuto. -

Università Degli Studi Di Napoli “Federico II” Facoltà Di Lettere E Filosofia Dipartimento Di Scienze Relazionali “G
Università degli Studi di Napoli “Federico II” Facoltà di Lettere e Filosofia Dipartimento di Scienze Relazionali “G. Iacono” DOTTORATO IN STUDI DI GENERE XXI CICLO a. a. 2005-2006; 2006-2007; 2007-2008 Tra pubblico e privato: reti familiari e relazioni di genere nel lungo Ottocento Tutor Dottoranda Prof.ssa Laura Guidi Dott.ssa Marcella Varriale Coordinatrice Prof.ssa Adele Nunziante Cesàro Indice Indice pag. 2 Introduzione pag. 4 Capitolo I Sentimenti e relazioni familiari 1.1. Cambiamenti generazionali pag. 12 1.1.a. “E se a voler fu destino o fortuna non so...” pag. 17 1.1.b. “Solo chi è veramente libero può amare...” pag. 28 1.1.c. “Io mi sono data tutta all’educazione delle ragazze” pag. 37 1.2. “Grazie mille per la vostra sublime lettera” pag. 52 Capitolo II Famiglia e nazione 2.1. “La casa nella quale entrai sposa era ricca di memorie patriottiche” pag. 69 2.2. “Io sono stata, sono e sarò sempre sinistra “ pag. 83 2.3. “Veniva da Mentana dove aveva combattuto sotto gli occhi di Garibaldi” pag. 100 2.4. La discesa della politica nelle piazze e la partecipazione dei Capecelatro pag. 107 2.4.a. “... e mia madre volle che anch’io mi facessi un abito nero” pag. 109 2.4.b. “Fu gentile con tutti e si degnò parlare anche con me” pag. 114 Capitolo III Donne che scrivono storia 3.1. “Io purtroppo! non mi sentivo l’anima eroica” pag. 126 3.2. “Meminisse juvabit” pag. 136 3.3. “Com’è caro ricordare, e amar sempre, e mantener viva la memoria di chi merita di essere onorato dai posteri!” pag. -

Giambattista Vico and the Risorgimento
Giambattista Vico and the Risorgimento The Harvard community has made this article openly available. Please share how this access benefits you. Your story matters Citation Noether, Emiliana P. 1969. Giambattista Vico and the Risorgimento. Harvard Library Bulletin XVII (3), July 1969: 309-319. Citable link https://nrs.harvard.edu/URN-3:HUL.INSTREPOS:37363767 Terms of Use This article was downloaded from Harvard University’s DASH repository, and is made available under the terms and conditions applicable to Other Posted Material, as set forth at http:// nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:dash.current.terms-of- use#LAA Giambattista Vico and the Risorgimento * E111ilia11aP. N oether URI NG the first half of the ninetc enth century Giambattista Vico finall)T enjoyed the recognition that he had sought all his life. The n1an ,vho had ruefully commented that "'he Jived in his country not only as a foreigner, but also unkno\vn./' 1 though convjnccd that he had hcen "born for the glory of ... Italy," 2 ,vas given a prominent p1ace in the Pantheon of Italian geniuses erected by the n1cn of the Risorgimento. To his country1nen his na111ebecame -asource of national pride and his ideas provided the basis for many of the Risorgimento's earl)Tdreams of 2n I taI )T ,v h ich through indep endenc e \v ould be fulfilling its dcstinJ" 11s a nation. In attempting to nnd the reasons for his appeal at this mo- n1ent in Italian histOr)7 1 one n1ust first consider the general European int elice rual outlook. ll on1an tici sn1, ,vi th its sensitive a, va re n -

Greenskills-Forum 2012
Welcome Registration Agenda Information Speakers Presentations Papers Gallery You are here: Home Background The forum aims to draw on lessons from current work conducted by the OECD, Cedefop, and other research and international organisations on the implications of the green economy for skills development and training policies. These insights will contribute to the OECD’s Green Growth Studies such as the LEED projects on Measuring the Potential of Green Growth, Improving the effectiveness of green local development initiatives and to Cedefop’s Green Skills activities, which contribute to the European Commission’s initiative on New Skills for New Jobs. The Forum also provides insights for the Rio+20 process and the G20 pillar on the "Framework for Strong, Sustainable and Balanced Growth" and the G20 work on "Development". A transition to a low carbon economy is only possible by developing the skills, knowledge and competences required by resource-efficient, sustainable processes and technologies, and integrating these into our businesses and communities. While effective development strategies and activities for these skills are necessary to achieve green growth, their success relies on an integrated approach with other areas of workforce development and public policy. The Green Skills forum is an opportunity to gather the latest insights on (1) what firms, trade unions and other organisations are already doing to foster the potential of green growth through skills development activities; (2) how strategies for green skills are integrated with other areas of workforce development and (3) tools and directions for further research. Purpose The aim of this international forum of researchers, government advisers, employment and policy analysts and social partners actively involved in skills development and training needs for a low carbon economy is to review and discuss new research and policy approaches to foster a greener, more sustainable future. -

Entre France Et Italie : Échanges Et Réseaux Intellectuels Au Xixe Siècle
Transalpina Études italiennes 21 | 2018 Entre France et Italie : échanges et réseaux e intellectuels au XIX siècle Mariella Colin, Laura Fournier-Finocchiaro et Silvia Tatti (dir.) Édition électronique URL : http://journals.openedition.org/transalpina/285 DOI : 10.4000/transalpina.285 ISSN : 2534-5184 Éditeur Presses universitaires de Caen Édition imprimée Date de publication : 1 octobre 2018 ISBN : 978-2-84133-900-6 ISSN : 1278-334X Référence électronique Mariella Colin, Laura Fournier-Finocchiaro et Silvia Tatti (dir.), Transalpina, 21 | 2018, « Entre France et Italie : échanges et réseaux intellectuels au XIXe siècle » [En ligne], mis en ligne le 19 décembre 2019, consulté le 18 novembre 2020. URL : http://journals.openedition.org/transalpina/285 ; DOI : https:// doi.org/10.4000/transalpina.285 Transalpina. Études italiennes Entre France et Italie : échanges et réseaux intellectuels au XIXe siècle Couverture : Maquette de Cédric Lacherez Tous droits de traduction, d’adaptation et de reproduction, sous quelque forme que ce soit, réservés pour tous pays. ISSN : 1278-334x ISBN : 978-2-84133-900-6 © 2018. Presses universitaires de Caen 14032 Caen Cedex - France TRANSALPINA ÉTUDES ITALIENNES – 21 – Entre France et Italie : échanges et réseaux intellectuels au XIXe siècle Textes recueillis par Mariella Colin, Laura Fournier-Finocchiaro et Silvia Tatti 2018 Équipe de recherche sur les littératures, les imaginaires et les sociétés (erlis) Université de Caen Normandie Direction de la revue Mariella Colin (Université de Caen) Laura Fournier-Finocchiaro -

Lettera Di Antonio Ranieri a Leopardi
BL 1406 [12-08/2012, da un’idea del 8-06/2010] Per i caratteri della silloge e per un’eventuale nuova edizione: http://www.fregnani.it/leopardi/epistolario/ DUE DISLESSIE DI MORONCINI NELLA LETTERA DI ANTONIO RANIERI A GIACOMO LEO PARDI Come è ben noto, Antonio Ranieri, l’ombroso e non sempre decifrabile sodale dell’ultimo Leopardi, ha lasciato alla Biblioteca Nazionale di Napoli una vera e propria montagna di carte, cui non è bastata la vita di generazioni di studiosi a mettere ordine; pure, quella presentata infra è l’unica sua lettera superstite della corrispondenza col poeta, a fronte delle quarantatrè missive a lui indirizzate. Che altre ne esistessero, basterebbe un’intelligenza mediocre, quale potrebbe essere la mia, ad immaginarlo; d’altronde è e- spressamente e ripetutamente attestato da Giacomo medesimo, per esempio nella lettera all’amico del 25 dicembre 1832: «Ranieri mio caro. Crederai tu che le tue de’ 15, 18 e 20 mi giungono tutte insieme oggi?»1. Che egli le abbia distrutte, è uno di quei misteri di cui Ranieri non è mai stato parco. Erano infine le sue, e aveva bene il diritto di non curarsi ed eludere la curiosità dei posteri (forse che il Giordani si comportava diversamente?)2; mentre noi dovremmo comunque ringraziarlo per aver lasciato sopravvivere gli affettuosi bigliettini inviatigli da Giacomo, non fosse che ogni tanto solleticano le fantasie di odier- ni epigoni del Prof. Patrizi. Ma ecco la lettera in questione, secondo la lezione dell’Epistolario BRIOSCHI-LANDI, vol. II, n° 1406, p. 1594 s., equivalente a MORONCINI, V, n° 1370.3 Firenze li 18 Dicembre 1828 1 Cfr. -

©2009 William Eugene Roney ALL RIGHTS RESERVED
©2009 William Eugene Roney ALL RIGHTS RESERVED GIACOMO LEOPARDI: SHADES OF BLACK: MISANTHROPY IN LO ZIBALDONE By WILLIAM EUGENE RONEY A Dissertation submitted to the Graduate School-New Brunswick Rutgers, The State University of New Jersey in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Graduate Program in Italian written under the direction of Professor Elizabeth Leake and approved by ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ New Brunswick, New Jersey January 2009 ABSTRACT OF THE DISSERTATION GIACOMO LEOPARDI: SHADES OF BLACK: MISANTHROPY IN LO ZIBALDONE by WILLIAM EUGENE RONEY Dissertation Director: Professor Elizabeth Leake The work of Giacomo Leopardi has typically been analyzed by contrasting the noble values of the classical past against his perception of the inferior cultural condition found in the contemporary world. Leopardi believed that modern society at large was in decay as evidenced by the constant use of the word odio, hate, in relation to it and its members. Odio, and other misanthropic terms, are found so frequently and in such varied contexts in Lo Zibaldone, that one quickly understands that his feelings are more raw and less theoretical than past literary criticism would indicate. Leopardi’s hatred is misanthropic, a strong dislike and rejection of humankind itself. It is not that Leopardi dislikes everything, but rather, everyone. His negativity is directed toward people and their selfishness and lack of vision. Previous interpretations of his work focus on Leopardi’s pessimism but do not acknowledge that it is not expressed toward life itself, but rather the disappointing and inadequate actions of individuals and groups. -

Sicilian Intellectual and Cultural Resistance to Piedmont's Appropriation (1860-1920) Giordana Poggioli-Kaftan University of Wisconsin-Milwaukee
University of Wisconsin Milwaukee UWM Digital Commons Theses and Dissertations December 2016 Sicilian Intellectual and Cultural Resistance to Piedmont's Appropriation (1860-1920) Giordana Poggioli-Kaftan University of Wisconsin-Milwaukee Follow this and additional works at: https://dc.uwm.edu/etd Part of the Comparative Literature Commons, and the History Commons Recommended Citation Poggioli-Kaftan, Giordana, "Sicilian Intellectual and Cultural Resistance to Piedmont's Appropriation (1860-1920)" (2016). Theses and Dissertations. 1401. https://dc.uwm.edu/etd/1401 This Dissertation is brought to you for free and open access by UWM Digital Commons. It has been accepted for inclusion in Theses and Dissertations by an authorized administrator of UWM Digital Commons. For more information, please contact [email protected]. SICILIAN INTELLECTUAL AND CULTURAL RESISTANCE TO PIEDMONT’S APPROPRIATION (1860-1920) by Giordana Poggioli-Kaftan A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy in Modern Studies at The University of Wisconsin-Milwaukee December 2016 ABSTRACT SICILIAN INTELLECTUAL AND CULTURAL RESISTANCE TO PIEDMONT’S APPROPRIATION (1860-1920) by Giordana Poggioli-Kaftan The University of Wisconsin-Milwaukee, 2016 Under the Supervision of Professor Gregory Jay Through my analysis of literary works, I endeavor to bring to the fore a cultural and intellectual counter-hegemonic discourse that came to be articulated by three Sicilian writers in the years following Italy’s unification. Their intent was that of debunking a national discourse that constructed Italian Southerners as “Otherness.” My study focuses on six primary texts, five short stories, and one novel, written at the turn of the twentieth century. -

Rivista Di Studi Italiani 65 Contributi Giovan Battista
RIVISTA DI STUDI ITALIANI CONTRIBUTI GIOVAN BATTISTA NICCOLINI’S LITERARY AND POLITICAL ROLE IN THE RISORGIMENTO PIERO GAROFALO University of New Hampshire Durham, New Hampshire iovan Battista Niccolini was one of the most renowned Italian dramatists of the nineteenth century, but since the early 1900s critical Gand popular interest in his literary production has steadily diminished. His tragedies appealed to the ideals associated with national unification and with the Risorgimento culture because they reiterated the necessity of resisting tyranny in the cause of freedom. Extravagantly praised during his lifetime, Niccolini was buried alongside some of Florence’s most famous citizens in the church of Santa Croce. A funeral monument sculpted by Pio Fedi was added in 1883, to commemorate his literary achievements. The son of Ippolito and Settimia da Filicaja, Giovan Battista was born in Bagni di San Giuliano (today, San Giuliano Terme) near Pisa on 29 October 1782. His father, a nobleman of the Counts of Camugliano, was somewhat of an anglophile so English comprised part of Niccolini’s cultural formation. Ippolito served in the Palazzo Pretorio as a government representative of the Grand Duchy of Tuscany. His mother was also a descendant of a patrician Florentine family. As a child and throughout his life, Giovan Battista was timid and frail, more interested in intellectual activities than physical ones. In 1786, the family moved to Florence where Niccolini frequented the Scolopi School in Florence. He studied under the guidance of Angelo D’Elci (1754-1824) and Giovanni Battista Zannoni (1774-1832). He began to learn Greek in 1796, and quickly developed a passion for classical studies. -

Nietzsche's Zukunftsphilologie: Leopardi, Philology, History
Nietzsche’s Zukunftsphilologie: Leopardi, Philology, History* Angela Matilde Capodivacca When the past speaks it always speaks as an oracle: Only if you are an architect of the future and know the present will you understand it. --Nietzsche, Beyond Good and Evil: Prelude to a Philosophy of the Future Why do we have to learn so much history? What’s wrong with the future? --Marcy in the movie Legally Blonde 2 0:34:46-50 In November 1492, Politian gave his inaugural lecture, Lamia, for a course on Aristotelian philosophy in which he advocated a new understanding of philology.1 In this address, Politian redefined the relationship between philology, literature, and philosophy by affirming the preeminence of what he calls the grammaticus (grammarian, philologist)2 over the philosopher as the best interpreter of all texts, philosophical works included. Politian writes: Indeed, the functions of philologists are such that they examine and explain in detail every category of writers – poets, historians, orators, philosophers, medical doctors, and jurisconsults. Our age, knowing little about antiquity, has fenced the philologist in, within an exceedingly small circle. But among the ancients, once, this class of men had so much authority that philologists alone were the censors and critics of all writers. (2010, 245) For Politian, philology is the art of reading through the past: philosophical analysis, history, anthropology, sociology, and so on are but ancillary to it. Almost four hundred years later, in 1869, Friedrich Nietzsche made a similar move *I would like to thank Andrew Cutrofello, David Lummus, Giuseppe Mazzotta, Arielle Saiber, Francesca Trivellato, and Patrick Waldron for reading earlier versions of this essay. -
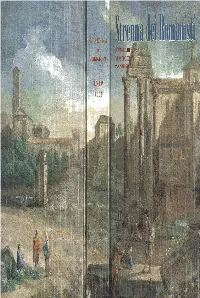
2003 Parte 1 Pp. 1-347
STRENNA DEI ROMANISTI NATALE DI ROMA 2003 ab U. c. MMDCCLVI ARRIGHI BORGHESE - BARBERITO - BARTOLONI - BATTELLI - BENOCCI - BIANC!Nl E COSTABILE - BONADONNA Russo - CARLONI - CAZZOLA - CECCARELLI - CECCOPIERI MARUFFI - CERESA - C!AMPAGLIA - COCCIA - CRIELESI - D' AMBROSIO - DELLA SETA - DE ROSA - Dr CASTRO - Dr GIOIA - DOMACAVALLI - EscH - ESCOBAR - FAGIOLO - FAITROP-PORTA - FLORIDI - FRAPISELLI - GUIDONI - HARTMANN - IMBRIGHI - IMPIGLIA - LOTTI - MALIZIA - MAMMUCCARI - MARIOTTI BIANCHI - MASETTI ZANN!Nl - MAZIO - MORELLI - F. ONORATI - U. ONORATI - ORSINI - PAGLIALUNGA - PANELLA - PASERO - PINTO - POCINO - PORF!Rl - QUINTAVALLE - RAVAGLIOLI - Russo DE CARO - SANTINI - TAMBLÉ - TOURNON - TRASTULLI - VERDONE - YIAN MATIJRIS NISl8U5 (o'EllfTRICE ROMA AMOJI. 1980 In copertina: EDITRICE ROMA AMOR 1980 G. B. BUSIRI, Campo Vaccino (sec. XVIII) Roma, coll. privata I Comitato dei curatori: MANLIO BARBERITO ANTONIO D' AMBROSIO LAURA GIGLI UMBERTO MARIOTTO BIANCHI ANTONIO MARTIN! FRANCO ONORATI MARIA TERESA Russo BONADONNA DONATO TAMBLÈ FRANCESCO PICCOLO Coordinamento e impaginazione: GEMMA HARTMANN AMEDEO INNOCENTI BRUNO MARIO NOBILE GIOVANNA RONDONI Consulenza editoriale: ANDREA MARINI GRUPPO DEI ROMANISTI MMDCCLVI www.gruppodeiromanisti.it [email protected] AB VRBE CONDITA © EDITRICE ROMA AMOR 1980 TEL. 06 32 34 375 S. Pietro successore di Romolo MANLIO BARBERITO In un mio scritto di qualche anno fa, ho parlato delle cerimo nie e delle tradizioni religiose e popolari che nella Roma papale contrassegnavano la festa dei santi Pietro e Paolo, annunciata e preparata già vari giorni prima da tridui e novene che si teneva no non solo in tutte le chiese dedicate ai due Apostoli e cioè le due basiliche, la vaticana e l'ostiense, S. Pietro in Vincoli, S. Pietro in Montorio e S. Paolo alla Regola, ma anche in quelle co munque legate alla loro memoria e alle loro vicende. -

Persistence of Iterative Personal Names in Italian: Medieval to Early Modern Vs
Persistence of iterative personal names in Italian: Medieval to early modern vs. the nineteenth and twentieth centuries Ephraim Nissan Goldsmiths College, London & University of Manchester, United Kingdom Persistence of iterative personal names in Italian: Medieval to early modern vs. the nineteenth and twentieth centuries Abstract: In Italian (and not as frequently, in some other languages as well) there exists a pattern ofiterative names. These, which in Italian are called nomi iterati, are such personal names, that the first name is a singular form of the family name. In the Middle Ages up to the early modern period, and much more rarely later on, in iterative names the first name is formed as the singular of the family name, even though the family name is not itself readily identifiable as being formed out of a first name in the contemporary onomasticon. In contrast, in the 19th and 20th century, one not infrequently comes across such Italian iterative names that the family name is clearly related to a first name, and the given person’s first name is that first name in the singular. I have currently a book in preparation about this topic. Sections in this article include: Iterative names as translated character names in Italy; Medieval Italian iterative names; Italian iterative names from the Quattrocento to the Seicento; Eighteenth-century Italian iterative names; Some nineteenth-century Italian iterative names; The case of Sismondo Sismondi; Considerations concerning iterative names borne by people in twentieth-century Italy; Some twentieth-century Italian iterative names: Some examples from just the first few letters of the alphabet; Female Italian iterative names; Italian iterative names borne by Jews; An Italian iterative name given to a child converted from Judaism; Concluding remarks: The historical trend privileging a less picturesque subpattern of iterative names in the last two centuries, and notable exceptions.