Chronicon Spilimbergense
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Archivio Capitolare E Nel Rubeis Monumenta Ecclesiae Aquilejensis a C.Ta 410
Cividale del Friuli Museo Archeologico Nazionale Polo Museale del Friuli Venezia Giulia Pergamene ex capitolari R in fondo alla segnatura: regesto della Torre nel relativo tomo (non esiste documento) T in fondo alla segnatura: solo copia nel relativo tomo Colto 24 in pessime condizioni di conservazione, privo di dati dove illeggibili 1 N. della Torre 01.001 data data topica trasmissione regesto Mizuzà notaio note Note della Torre: Spiegazione della pergamena scritta in ebraico fatta dal rabbino sig.r Isacco Reggio in Gorizia li 12. Marzo 1819 per instanza del canonico archivista Michele co. Della Torre: La pergamena è detta in nostra lingua Mezuzà e serve per attaccarla allo stipite della porta d'una casa abbitata da un israelita, giusto il precetto divino. Deut. Vi.V.9: scribesque ea in limine et ostiis domus tuae. Essa contiene in carattere ebraico sei versetti del Deut. Si assomiglia questo carattere ebraico alla maniera da scrivere degli spagnoli ed italiani. N. della Torre 01.002 data data topica trasmissione regesto In caratteri glagolitici notaio note Note della Torre: G.B. Hattinger antiquario di Trieste diede questo specimen Characteris glagoritici! li 14. Novembre 1818 in Cividale al canonico Michele della Torre e Valsassina N. della Torre 01.003T data 0762.05.03 ind. 15 data topica trasmissione regesto Fondazione del monastero di Santa Maria in Valle, anticamente detto di Santa Maria di Salt, ad opera della principessa Piltrude longobarda insieme ai suoi figli, i quali fondarono il monastero di Santa Maria di Sesto, diocesi di Concordia notaio note Note della Torre: Copia autentica fatta da me d. -

Manoscritti Della Biblioteca “Bartoliniana” Dell’Arcidiocesi Di Udine
Manoscritti della Biblioteca Bartoliniana MANOSCRITTI DELLA BIBLIOTECA “BARTOLINIANA” DELL’ARCIDIOCESI DI UDINE INVENTARIO Inventariazione realizzata da Luca Olivo nel 2011 per conto dell’Archivio Storico Diocesano di Udine a cura dell’Istituto “Pio Paschini” per la Storia della Chiesa in Friuli 1 Manoscritti della Biblioteca Bartoliniana Il conte Antonio Bartolini1 appartenne ad una delle più insigni famiglie nobiliari friulane, di antica schiatta fiorentina. A Firenze infatti gli avi del conte Antonio ricoprirono varie cariche pubbliche ma pare la loro origine fosse quella di mugnai. I Bartolini si trasferirono in Friuli nella prima metà del Trecento e già nel 1518 erano annoverati nel Libro d’oro della nobiltà come conti. Nel corso del Settecento la famiglia riuscì ad acquisire notevoli fortune grazie ad una redditizia attività di possidenti agrari con varie tenute, soprattutto a Buttrio. Agronomo fu il padre di Antonio Bartolini, Ettore. Questi nel 1737 sposò Francesca Manin, appartenente alla prestigiosissima casata. Il matrimonio era avvenuto nel quadro di una specifica strategia di alleanze tra famiglie nobili e nell’intento di dare ulteriore lustro ai Bartolini, le cui fortune nel campo dell’imprenditoria agraria potevano gettare ombre sul loro grado di nobiltà. Antonio Bartolini nacque a Udine il 12 settembre 1741 e già all’età di 6 anni rimase orfano di madre, essendo in quell’anno deceduta Francesca Bartolini Manin all’età di soli 38 anni. Difficile stabilire con certezza la formazione di Antonio ma dato che il fratello maggiore Gregorio (1738 – 1828) e il fratellastro minore Giovanni Battista (1754 – 1823) studiarono al Collegio dei Barnabiti di Udine pare possibile che anche il giovane conte fosse stato colà indirizzato dal padre. -

Pro Honore, Utilitate Et Commodo: the Margraviate of Istria and the Market Privileges of the Aquileian Patriarch Bertrand De Saint-Geniès (1334-1350)
Zavičajni muzej Poreštine – Museo del territorio parentino Sveučilište Jurja Dobrile u Puli – Filozofski fakultet Državni arhiv u Pazinu 8. ISTARSKI POVIJESNI BIENNALE Artisani et mercatores: o obrtnicima i trgovcima na jadranskom prostoru Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog u Poreču od 11. do 13. svibnja 2017. Nakladnik Zavičajni muzej Poreštine – Museo del territorio parentino Decumanus 9 52440 Poreč Sunakladnici Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Filozofski fakultet Zagrebačka 30 52100 Pula Državni arhiv u Pazinu Vladimira Nazora 3 52000 Pazin Za nakladnika Elena Uljančić Za sunakladnike Alfio Barbieri Mirela Mrak Glavne urednice Marija Mogorović Crljenko Elena Uljančić Uredništvo zbornika Gaetano Benčić, Danijela Doblanović Šuran, Marija Mogorović Crljenko, Davor Munda, Elena Poropat Pustijanac, Elena Uljančić Znanstveni odbor skupa Miroslav Bertoša, Neven Budak, Danijela Doblanović Šuran, Jakov Jelinčić, Ivan Matejčić, Robert Matijašić, Marija Mogorović Crljenko, Elvis Orbanić, Elena Poropat Pustijanac, Tajana Ujčić, Elena Uljančić Recenzenti doc. dr. sc. Tonija Andrić, dr. sc. Maja Katušić Tajnica uredništva Jasna Grgić Lektori Vanessa Vitković Marčeta, hrvatski jezik, Nelida Milani Kruljac, talijanski jezik Aleksandra Gačić, slovenski jezik, Danijela Bilić Rojnić, engleski jezik Prijevod sažetaka na engleski jezik Danijela Bilić Rojnić Korektura Eda Vlahov Grafičko oblikovanje i priprema Alfio Klarić Naklada 500 primjeraka Realizacija Sv. German, Pula Tisak Grafomark, Zagreb Objavljivanje Zbornika omogućili su: -
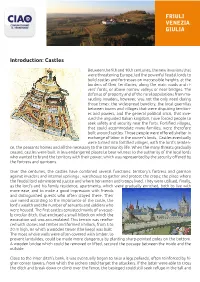
Introduction: Castles
Introduction: Castles Between the 9th and 10th centuries, the new invasions that were threatening Europe, led the powerful feudal lords to build castles and fortresses on inaccessible heights, at the borders of their territories, along the main roads and ri- vers’ fords, or above narrow valleys or near bridges. The defense of property and of the rural populations from ma- rauding invaders, however, was not the only need during those times: the widespread banditry, the local guerrillas between towns and villages that were disputing territori- es and powers, and the general political crisis, that inve- sted the unguided Italian kingdom, have forced people to seek safety and security near the forts. Fortified villages, that could accommodate many families, were therefore built around castles. Those people were offered shelter in exchange of labor in the owner’s lands. Castles eventually were turned into fortified villages, with the lord’s residen- ce, the peasants homes and all the necessary to the community life. When the many threats gradually ceased, castles were built in less endangered places to bear witness to the authority of the local lords who wanted to brand the territory with their power, which was represented by the security offered by the fortress and garrisons. Over the centuries, the castles have combined several functions: territory’s fortress and garrison against invaders and internal uprisings ; warehouse to gather and protect the crops; the place where the feudal lord administered justice and where horsemen and troops lived. They were utilised, finally, as the lord’s and his family residence, apartments, which were gradually enriched, both to live with more ease, and to make a good impression with friends and distinguished guests who often stayed there. -

Fondo SAF-Miscellanee
Fondo librario Società alpina friulana (SAF) - Sezione miscellanee Autore Titolo Data di pubblicazione Pagine Note bibliografiche Collocazione [Miscellanea di pubblicazioni] 52 Contiene diverse pubblicazioni. La prima pubblicazione: A 2 .1 12 "Bollettino del Club Alpino Italiano, per l'anno 1882. Estratto". Balliano Adolfo …e non potrai tornare 1945 46 B 79 18 Basagliutta 1324-1727 1934 16 "Nozze Scrosoppi - Broili" C 26 2 Benefattori della congregazione di carità di Udine 1831-1904 1907 22 C 91 18 Cattedra ambulante di agricoltura 186 milioni di danni causati dalla siccità in Friuli nel 1928 1928 12 Estratto da "L'Agricoltura Friulana" C 21 12 Lazzarini Alfredo 22 giugno 1905 - Davanti ad Adalberga 4 C 5 15 Larice Rina 29 maggio 1848. Conferenza tenuta all'Istituto Nazionale Villa 1897 38 C 71 18 della Regina Boegan Eugenio 3200 grotte nella Venezia Giulia 1936 4 C 76 22 Marinelli Olinto 50 anni di alpinismo in Friuli 1874-1924 1925 22 Discorso detto dal Presidente al XXXVI Convegno della SAF a B 100 14 Tolmezzo Marinelli Olinto 50 anni di alpinismo in Friuli 1874-1924 1925 22 Discorso detto dal presidente al XXXVI Convegno della S.A.F. a C 92 25 Tolmezzo Renati Giuseppe Filippo 6 Gennaio. Giuseppe Filippo Renati 1899 12 A 41 5 Vogric G. A Andrea Casasola Arcivescovo di Udine 1873 52 A 34 7 Brown Edward A brief account of some travels in Hungaria, Servia, Bulgaria, 1926 16 C 12 26 Macedonia, Thessly, Austria, Styria, Carinthia, Carniola and Friuli Modoni Antonio A Burgianella. Gita negli Appennini 1880 20 A 54 18 Liruti Gian Giuseppe A Carlo Fabrizi 1873 8 B 30 4 Percoto Caterina A Caterina Cernazai - Per vivere nella sua memoria 1888 16 "Nozze" C 84 16 Luzzatto Oscar A cinquant'anni dalla fondaione della Società udinese per case 1954 24 B 53 14 popolari Fiammazzo Antonio A i pregi onde t'arrisero 1898 80 In copertina: "Nozze Grosser - D'Orlandi" C 88 17 A la conquista dell'aria. -

Le Sacre Reliquie Della Chiesa D' Aqui Leia 197
LE SA CRE RE LI QUIE DELLA CHIESA PATRIARCALE D'AQUILEIA. Me1norie e àornmenti. In seguito alla pubblicazione degli inventari del Tesoro patriar cale d'Aquileia fatta in questo Archivio (I, 95-rn6; Il, 54-71, 149- 17 l; III, 57-7 l) mi parve non inutil cosa di occuparmi di du e tra le pi ù venerate reliquie che resero insig ne quella Chiesa . Con la scorta di nuovi documenti spero di poter rettifi care qu anto ne ha n no scritto i passati agiografi e .cronis ti , e di poter anche aggiungere qualcosa alla loro ill ustrazione. Di rò in prima delle vicende de' corpi de' SS. Ermacora e For tunato, patroni dell'arcidiocesi aquileiese, e poi dell'evangeliario che per lu nghi anni fu riputato scrittura della mano stessa dello evangelista Marco. Nè si vorrà attribuire a mia soverchia credu lità, se, specie a proposito de lle spoglie di S. Ermacora, dovr6 ri portare le antiche leggende e le tradizioni colle quali si andarono tessendo le Vite de' Santi che leggonsi nei più vetusti pass iona ri '), poichè l'avveduto lettore saprà spogliare dal meraviglioso ed in verosimile que' pii racconti, che privi di co testi elementi non avrebbero colpito le semplici menti dei devoti di quell'età rimota. Nella città d' Aq uilej a, metropoli della Venezia, emporio del com mercio tra l'oriente e l'occidente, si raccoglie dalle tradizioni che intorno all'anno 46 dell'èra volgare, venisse l'evangeli_sta Marco a predicare la religione di Cristo, e che affidasse al proprio discepolo Ennacora la nuova chiesa, dandogli il titolo di pastore o vesco vo. -

Quellen Und Forschungen Aus Italienischen Archiven Und Bibliotheken
Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken Herausgegeben vom Deutschen Historischen Institut in Rom Bd. 89 2009 Copyright Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online- Publikationsplattform der Stiftung Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland (DGIA), zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Herunterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu privaten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hinausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weitergabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch strafrechtlich verfolgt werden. QUELLEN UND FORSCHUNGEN AUS ITALIENISCHEN ARCHIVEN UND BIBLIOTHEKEN BAND 8789 QUELLEN UND FORSCHUNGEN AUS ITALIENISCHEN ARCHIVEN UND BIBLIOTHEKEN HERAUSGEGEBEN VOM DEUTSCHEN HISTORISCHEN INSTITUT IN ROM BAND89 87 DE GRUYTER Redaktion: Alexander Koller Deutsches Historisches Institut in Rom Via Aurelia Antica 391 00165 Roma Italien http://www.dhi-roma.it ISBN 978-3-484-83087-583089-9 ISSN 0079-9068 ” Max Niemeyer Verlag, Tübingen 2007 Ein Imprint© Walter der de WalterGruyter de GmbH Gruyter & Co GmbH. KG, &2009 Co. KG httphttp://www.niemeyer.de://www.degruyter.com Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Printed in Germany. Gedruckt auf alterungsbeständigem Papier. Gesamtherstellung: AZ Druck und Datentechnik GmbH, Kempten/Allgäu INHALTSVERZEICHNIS Jahresbericht 2008 ................. IX–LX Florian Hartmann, Das Enchiridion de Prosis et Rithmis Alberichs von Montecassino und die Flores Rhetorici . -

Notizie Storico-Araldiche Di Docastelli, Sue Ville E Territorio
NOTIZIE STORICO-ARALDICHE DI DOCASTELLI, SUE VILLE E TERRITORIO GIOVANNI RADOSSI Centro di ricerche storiche CDV 929.6(497.5Docastelli) Rovigno Saggio scientifico originale Febbraio 1996 Riassunto- L'autore in questo contributo offre un compendio delle vicende storiche di Do castelli, con una dettagliata rivisitazione delle fonti e dei contributi storiografico-araldici, e pubblica la sua raccolta di stemmi che si compone di 25 pezzi. Questo corpo è in mag gior parte costituito da blasoni di nobiltà locale, capodistriana. Ciò va addebitato al fatto che la nomina del podestà di Docastelli spettava prima al podestà e capitanio e, successi vamente, al Consiglio di Capodistria. «Alla marina sotto Orser ritrovansi assai vestigi d'antichi edifizj per buon tratto. Passato due miglia appar la foce del canal Lemo il quale è piuttosto canale che fiume, ancorché 'l sia molto rapace si come un fiume tra gli alti monti et è sal so insino all'Hostaria. Da lì in su pare che anticamente scorresse insino ai due Ca stelli (Castello talmente addomandato) per la tortuosa via dei monti. Et avvenga che ora l'acqua non entri in detta Hostaria, sino ai due Castelli, per spazio di cin que miglia nondimeno però vi entra la pestilenziata aria di Lemo per quello insi no ai Due Castelli».' Dalla valle si arriva faticosamente sotto le mura del borgo diroccato, visto che il pendio del colle è da ogni parte molto erto ed ingombro di vegetazione. Scendendo da Canfanaro si ammira ancora l'antico viottolo che con duceva dall'altopiano al fondo valle e proseguiva arrampicandosi a settentrione. -

Bollettino Di Numismatica on Line Materiali N. 41-2016
SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL COLOSSEO, IL MUSEO NAZIONALE ROMANO E L’AREA ARCHEOLOGICA DI ROMA Medagliere LA COLLEZIONE DI VITTORIO EMANUELE III collana on line a cura di Silvana BalBi de Caro GaBriella anGeli Bufalini Ministero............................................................................................................................... dei beni e delle attività culturali..................................................... e del turismo BOLLETTINO DI NUMISMATICA ON-LINE MATERIALI Numero 41 – Maggio 2016 ROMA, MUSEO NAZIONALE ROMANO LA COLLEZIONE DI VITTORIO EMANUELE III La zecca di aquiLeia Da Pietro Gera (1299-1301) a Ludovico II di Teck (1412-1420) di Lorenzo Passera e Artur Zub Sommario la zecca di aquileia. Da Pietro Gera (1299-1301) a Ludovico II di Teck (1412-1420) introduzione di Lorenzo Passera Pietro Gera (1299-1301) . p . 5 Ottobono de’ Razzi (1302-1315) . » 5 Pagano della Torre (1319-1332) . » 6 Bertrando di san Genesio (1334-1350) . » 6 Nicolò di Boemia (1350-1358) . » 7 Ludovico I della Torre (1359-1365) . » 8 Marquardo di Randeck (1365-1381) . » 9 Filippo d’Alençon (1381-1387) . » 9 Giovanni di Moravia (1387-1394) . » 9 Antonio I Gaetani (1395-1402) . » 10 Antonio II Panciera (1402-1411) . » 10 Ludovico II di Teck (1412-1420) . » 11 Note . » 11 CataloGo di Artur Zub . » 13 Abbreviazioni bibliografiche . » 203 Indici . » 205 MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO BOLLETTINO DI NUMISMATICA c/o Museo Nazionale Romano - Medagliere Palazzo Massimo alle Terme Piazza dei Cinquecento, 67 – 00185 Roma www .numismaticadellostato .it Direttore Silvana BalBi de Caro silvana .balbi@virgilio .it Capo redattore e coordinatore di redazione GaBriella anGeli Bufalini gabriella .angelibufalini@beniculturali .it Redazione Simone BoCCardi, faBiana lanna Responsabile settore grafico Stefano ferrante stefano .ferrante@beniculturali .it Comitato tecnico-scientifico Ermanno A . -

15° Concorso Della Mailing List Histria Edizione 2017
CONCORSO MAILING 1 LIST HISTRIA 15° CONCORSO DELLA MAILING LIST HISTRIA EDIZIONE 2017 www.mlhistria.it www.adriaticounisce.it con la collaborazione di (in ordine alfabetico) ASSOCIAZIONE DALMATI ITALIANI NEL MONDO ASSOCIAZIONE LIBERO COMUNE DI FIUME IN ESILIO ASSOCIAZIONE LIBERO COMUNE DI POLA IN ESILIO ASSOCIAZIONE PER LA CULTURA FIUMANA, ISTRIANA E DALMATA LAZIO COMITATO PROV. DI GORIZIA – ANVGD COMUNITA’ DEGLI ITALIANI DI UMAGO FAMIA RUVIGNISA FAMIGLIA UMAGHESE IMPRINTING DELL'ISTRIA (temi in dialetto) ISTRIA EUROPA DI LINO VIVODA REGIONE ISTRIANA – ISTARSKA SOCIETA' DANTE ALIGHIERI COMITATO DI GORIZIA UNIONE ITALIANA UNIVERSITA' POPOLARE TRIESTE Premiazione Umago, maggio 2017 Zara, novembre 2017 Cattaro, marzo 2018 Si ringrazia CDM – CENTRO DOCUMENTAZIONE MULTIMEDIALE DELLA CULTURA GIULIANA ISTRIANA FIUMANA E DALMATA DI TRIESTE che ha realizzato questa pubblicazione www.arcipelagoadriatico.it volume stampato con il contributo del Ministero per gli Affari Esteri - Ex Legge 72/2001 I curatori Maria Rita Cosliani e Walter Cnapich 2 15° CONCORSO DELLA MAILING LIST HISTRIA ANNO 2017 TEMI DEL CONCORSO PER LE SCUOLE ELEMENTARI INDIVIDUALI O DI GRUPPO • “I nostri noni ne conta - i nostri nonni ci raccontano" - storie e memorie del vostro passato familiare. • "La mia classe plurilingue. Vi racconto perché mi piace frequentare la scuola italiana o frequentare corsi di italiano e avere amici che parlano lingue diverse." • Quant'è bella la mia città... • In riva al mare • La storia maestra di vita • Una pagina bianca da riempire con quello che vuoi, con i tuoi interessi, con i tuoi passatempi, con le tue amicizie. • Girando per l'Istria o la Dalmazia puoi incontrare tante antiche costruzioni come castelli, chiese ma anche semplici vere di pozzo, pietre confinarie, simboli che parlano di un tempo lontano. -

Piani E Memorie Dell'antica Basilica Di Aquileja Con I Capolavori D'arte Che
Informazioni su questo libro Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell’ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo. Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l’anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire. Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall’editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te. Linee guide per l’utilizzo Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l’utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l’imposizione di restrizioni sull’invio di query automatizzate. Inoltre ti chiediamo di: + Non fare un uso commerciale di questi file Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l’uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali. -

I Conti Di Gorizia E L'istria Nel Medioevo
UDK: 323.31(091)(450.367+497.4/.5-3Istria)”653/654” ISSN 0353-3301 ISBN 978-953-7891-05-3 CENTRO DI RICERCHE STORICHE - ROVIGNO Collana degli Atti N. 36 PETER ŠTIH I CONTI DI GORIZIA E L’ISTRIA NEL MEDIOEVO I CONTI DI GORIZIA E L’ISTRIA NEL MEDIOEVO NEL E L’ISTRIA I CONTI DI GORIZIA - TIH Š ETER P UNIONE ITALIANA – FIUME UNIVERSITÀ POPOLARE – TRIESTE ROVIGNO 2013 COLLANA DEGLI ATTI, Centro Ricerche Storiche, Rovigno, n. 36, p. 1 - 285, Rovigno, 2013 Collana degli Atti N. 36 2013 L'immagine di copertina è tratta da: Caspar MERIAN, Görz in Friaul, incisione in rame risalente intorno all'anno 1650, Topographia Austriacarum Provinciarum (Narodni muzej Slovenije/Museo nazionale della Slovenia, N.ro inv. G-5876; foto Tomaž Lauko). COLLANA DEGLI ATTI - N. 36 La ricerca e la pubblicazione del presente volume sono state realizzate con il contributo del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana, Direzione generale per l’Unione europea, ai sensi della Legge n. 194 del 2009 UDK: 323.31(091)(450.367+497.4/.5-3Istria)”653/654” ISSN 0353-3301 ISBN 978-953-7891-05-3 CENTRO DI RICERCHE STORICHE - ROVIGNO Collana degli Atti N. 36 PETER ŠTIH I CONTI DI GORIZIA E L’ISTRIA NEL MEDIOEVO UNIONE ITALIANA – FIUME UNIVERSITÀ POPOLARE – TRIESTE ROVIGNO 2013 COLLANA DEGLI ATTI, Centro Ricerche Storiche, Rovigno, n. 36, p. 1 - 285, Rovigno, 2013 CENTRO DI RICERCHE STORICHE – ROVIGNO UNIONE ITALIANA – FIUME UNIVERSITÀ POPOLARE – TRIESTE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE Piazza Matteotti 13 – Rovigno (Croazia), tel. +385 (052) 811-133 – fax (052) 815-786 internet: