Atti Della Accademia Dei Georgofili
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Product Categories Page 1 of 4 B 4.0
2022_PROWEIN_B_EN.qxp_2022_PROWEIN_B_EN 19.07.21 14:49 Seite 1 GB Product categories Page 1 of 4 B 4.0 Düsseldorf Wines (according to cultivable areas) 27/03–29/03/22 Europe Italy 01.01.16.01.03 Leithaberg 01.01.09.01 Abruzzo 01.01.16.01.04 Eisenberg 01.01.01 Albania 01.01.09.02 Valle d'Aosta Niederösterreich 01.01.09.03 Basilicata 01.01.16.02.01 Carnuntum 01.01.02 Bosnia-Herzegowina 01.01.09.04 Calabria 01.01.16.02.02 Wagram 01.01.09.05 Campania 01.01.16.02.03 Kamptal Bulgaria 01.01.09.06 Emilia-Romagna 01.01.16.02.04 Kremstal 01.01.03.01 Cherno more 01.01.09.07 Friuli Venezia-Giulia 01.01.16.02.05 Thermenregion 01.01.03.02 Dolinata na Strouma 01.01.09.08 Lazio 01.01.16.02.06 Traisental 01.01.03.03 Dunavska ravnina 01.01.09.09 Liguria 01.01.16.02.07 Wachau 01.01.03.04 Rozova Dolina 01.01.09.10 Lombardia 01.01.16.02.08 Weinviertel 01.01.03.05 Trakiiska nizina 01.01.09.11 Marche Steiermark 01.01.09.12 Molise 01.01.16.03.01 Südsteiermark Germany 01.01.09.13 Piemont 01.01.16.03.02 Vulkanland Steiermark 01.01.04.01 Ahr 01.01.09.14 Puglia 01.01.16.03.03 Schlicherland 01.01.04.02 Baden 01.01.09.15 Sardegna 01.01.16.04 Wien 01.01.04.03 Franken 01.01.09.16 Sicilia 01.01.16.05 Kärnten 01.01.04.04 Hess. -

INFODOC Per Il Settore IG Informazione D’Origine Controllata
FEDERDOC - Confederazione Nazionale dei Consorzi Volontari Via Piave, 24 tel. +390644250589 - [email protected] per la Tutela delle Denominazioni dei Vini Italiani 00187 Roma www.federdoc.com Maggio 2018 Bollettino Mensile INFODOC per il Settore IG INFORMAZIone d’ORIGINE CONTROLLATA NOTIZIE DALL’EUROPA E DAL MONDO LA COMMISSIONE PRESENTA proposto sulla politica agricola UE, l’Ita- di errori manifesti nelle domande, se- lia potrebbe perdere circa 2,7 miliardi a parando le norme sulla proprietà intel- LA PROPOSTA LEGISLATIVA prezzi correnti, il 6,9% in meno rispet- lettuale da altri requisiti stabiliti nei di- SULLA NUOVA PAC to all’attuale periodo di programmazio- sciplinari e abilitando gli Stati membri a ne. Nel pacchetto di iniziative legisla- decidere emendamenti che non hanno La Commissione europea ha presenta- tive presentate dalla CE, è ricompreso impatti a livello UE, snellendo le appro- to, nella mattinata del 1°giugno, la boz- anche il testo legale di proposta di re- vazioni, abbreviando i tempi e raziona- za di riforma per la PAC 2021-2027, che golamento emendativo, tra l’altro, dei lizzando le risorse, in linea con i prin- prevede un budget complessivo di 365 Reg. 1308/2013 (OCM), 1151/2012 (DOP- cipi di sussidiarietà e proporzionalità. miliardi di euro. Per redistribuire il so- IGP agroalimentari), 251/2014 (IG vini Allo stesso modo, è prevista la semplifi- stegno della politica agricola comune in aromatizzati). Nel memorandum espli- cazione di alcune procedure specifiche, favore delle piccole aziende, il Commis- cativo che introduce quest’ultima boz- ad esempio la procedura di opposizio- sario UE all’Agricoltura Phil Hogan pro- za di regolamento, viene testualmente ne, per rendere più efficiente il proces- pone di fissare un tetto agli aiuti a quota riportato “…la Comunicazione sul futu- so di approvazione. -

Assessment of Wine Packaging Effects on Customer Purchasing Decision in Tanzania: a Case of Hombolo and Miuji Wine Industries
The University of Dodoma University of Dodoma Institutional Repository http://repository.udom.ac.tz Business Master Dissertations 2014 Assessment of wine packaging effects on customer purchasing decision in Tanzania: a case of Hombolo and Miuji wine industries Waziri, Amina Mohamed The University of Dodoma Waziri, A. M. (2014). Assessment of wine packaging effects on customer purchasing decision in Tanzania: a case of Hombolo and Miuji wine industries. Dodoma: The University of Dodoma. http://hdl.handle.net/20.500.12661/1259 Downloaded from UDOM Institutional Repository at The University of Dodoma, an open access institutional repository. ASSESSMENT OF WINE PACKAGING EFFECTS ON CUSTOMER PURCHESING DECISSION IN TANZANIA: A CASE OF HOMBOLO AND MIUJI WINE INDUSTRIES By Amina Mohamed Waziri Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Award of the Degree of Masters of Business Administration of the University of Dodoma The University of Dodoma October, 2014 CERTIFICATION The undersigned certifies that has read and hereby recommends for acceptance by the University of Dodoma dissertation entitled: “Assessment of Wine Packaging Effects on Customer Purchasing Decision in Dodoma Municipality: A Case Study of Hombolo and Mihuji” in partial fulfillment of the requirements for the Degree of Masters of Business Administration of the University of Dodoma. ……………………………………. Dr Mark Paul Diyammi (SUPERVISOR) Date ……………………………… i DECLARATION AND COPYRIGHT I, Amina Mohamed Waziri do hereby declare to University of Dodoma that this dissertation is a result of my own original work and that it has not been submitted for any degree award in any university for the award of the Degree of Masters of Business Administration of the University of Dodoma. -

Welcome to High Street Wine
WELCOME TO HIGH STREET WINE CO! FOOD CHARCUTERIE BOARDS | 3 FOR $18 OR 6 FOR $28 Each Served with Baguette & Accoutrements CHEESES CHARCUTERIE CHÈVRE CHORIZO Goat | Soft Pork with Smoked Paprika MT TAM DODGE CITY Cow | Triple Cream | Soft Pork with Fennel and Pepper GRAND CRU 'GRUYERE' ROSETTE DE LYON Raw Cow | Semi-Firm Pork with Garlic MANCHEGO SMOKED DUCK HAM Sheep | 6 mo Firm Thinly Sliced Duck Breast MIMOLETTE Cow | 15 mo Firm SNACKS | 3 EACH MIXED NUTS POINT REYES BAY BLUE MARCONA ALMONDS Cow | Semi- Firm MIXED SPANISH OLIVES BAGUETTE WITH JAM OR OLIVE OIL SHAREABLE FLATBREADS All items served on a 9" Flatbread - This product contains wheat CHEESE WHEELS | 25 Please no substitutions Served with Baguette & Jam CLASSIC NEAPOLITAN | 12 MT TAM 11oz San Marzano tomatoes | fresh mozzarella Cow | Soft |Triple Cream | California basil pesto drizzle FONTINA D'AOSTA & PROSCIUTTO | 17 Dalmatia fig jam | Fontina D'Aosta | Prosciutto di Parma CONSERVA SEAFOOD | 10 balsamic glaze | arugula +Served in can with baguette BERBERECHOS IN BRINE SMOKED SALMON | 16 aka ‘Baby Clams’ Atlantic smoked salmon | herbed cheese spread | capers ORGANIC MUSSELS IN OIL AND VINEGAR arugula | lemon vinaigrette | red onion CHOCOLATE BE A LITTLE EXTRA! HIGH STREET SWAG Go ahead, treat yourself! Because you love us. ASKINOSIE | WHOLE BAR 3OZ | 16 Mababu Tanzania '72%' Dark Chocolate PROSCIUTTO | 6 T-SHIRTS | 25 KAKA'WA | COCOA BEANS 1OZ| 8 ATLANTIC SMOKED SALMON | 6 GO-VINO CUPS | 4 Dusted Cocoa Beans ANCHOVIES | 4 TRAVEL ICE BAGS | 10 w/ White, Milk, and Dark Chocolate -
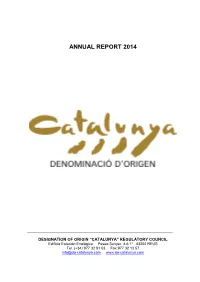
Com Cada Any, El Consell Regulador Confecciona La
ANNUAL REPORT 2014 DESIGNATION OF ORIGIN “CATALUNYA” REGULATORY COUNCIL Edificio Estación Enológica Paseo Sunyer, 4-6 1º 43202 REUS Tel. (+34) 977 32 81 03 Fax 977 32 13 57 [email protected] www.do-catalunya.com REPORT 2014 DENOMINACIÓ D’ORIGEN INDEX Pg. 1. INTRODUCTION...................................................................................................... 2 2. SITUATION OF RECORD OF ACTIVITIES............................................................ 3 3. QUALIFICATION OF WINES.................................................................................. 4 4. COMERCIALIZATION OF BOTTLED WINE…………............................................ 6 5. SUITABLE GRAPES DO CATALUNYA. HARVEST 2014 .................................... 12 6. RESGISTERED CELLARS IN DO CATALUNYA .................................................. 13 1 DESIGNATION OF ORIGIN “CATALUNYA” REGULATORY COUNCIL Edificio Estación Enológica Pg Sunyer, 4-6 1º 43202 REUS Tel 977 328103 Fax 977 321357 [email protected] REPORT 2014 DENOMINACIÓ D’ORIGEN 1. INTRODUCCIÓN As every year, the Regulatory Council prepares the annual report of the Designation of Origin Catalunya. This year corresponds to 2014 financial period. The total volume of qualified wine has been 567.004 hl, 15,7% higher than in 2013. Stock has also increased, both at the end of the wine year and at the end of the calendar year, by 41% and 29% respectively. Concerning wine color, all of them have increased: white wine by 12,8%, rosé by 32,4% and red wine by 15,2%. Proportionally, the latter remains the majority of the qualified wine (49%), followed by white (41%) and rosé (10%). Out of the total qualified wines, 375.860 hl (66,3%) are 2013 harvest wines and the rest correspond to other seasons. This raises the percentage in relation to last period by 6,9%. Regarding bottled wine, in 2014 65,6 million bottles (0,75 L) have been commercialized, from which 31,4 M (48%) has been distributed to the internal market and the remaining 34,2 M (52%) was destined to the external market. -
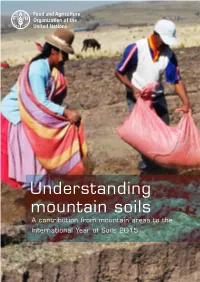
Understanding Mountain Soils
2015 In every mountain region, soils constitute the foundation for agriculture, supporting essential ecosystem functions and food security. Mountain soils benefit not only the 900 million people living in the world’s mountainous areas but also billions more living downstream. Soil is a fragile resource that needs time to regenerate. Mountain soils are particularly susceptible to climate change, deforestation, unsustainable farming practices and resource extraction methods that affect their fertility and trigger land degradation, desertification and disasters such as floods and landslides. Mountain peoples often have a deep-rooted connection to the soils they live on; it is a part of their heritage. Over the centuries, they have developed solutions and techniques, indigenous practices, knowledge and sustain- able soil management approaches which have proved to be a key to resilience. This publication, produced by the Mountain Partnership as a contribution to the International Year of Soils 2015, presents the main features of mountain soil systems, their environmental, economic and social values, the threats they are facing and the cultural traditions concerning them. Case studies provided by Mountain Partnership members and partners around the world showcase challenges and opportunities as well as lessons learned in soil management. This publication presents a series of lessons learned and recommendations to inform moun- Understanding Mountain soils tain communities, policy-makers, development experts and academics who support sustainable -

South African Wine: Trends and Opportunities for Trade in Africa 18
South African Wine: Trends and Opportunities for Trade in Africa 18 May 2021 Table of Contents 1 Background to the South African Wine industry ...................................................................... 3 2 Production ..................................................................................................................................... 3 3 Domestic consumption ................................................................................................................ 5 4 South Africa Wine Trade ............................................................................................................. 6 5 Western Cape’s Trade of Wine .................................................................................................. 9 6 Opportunities for South African Wine in Africa ...................................................................... 12 6.1 Nigerian Wine Market ........................................................................................................ 12 6.2 Angolan Wine Market ........................................................................................................ 16 6.3 Mozambique Wine Market ................................................................................................ 21 6.4 Ghana Wine Market ........................................................................................................... 23 2 1 Background to the South African Wine industry The Cape winegrowing areas, situated in the narrow viticultural zone of the southern hemisphere, -

L 127 Official Journal
ISSN 1725-2555 Official Journal L 127 of the European Union Volume 51 English edition Legislation 15 May 2008 Contents I Acts adopted under the EC Treaty/Euratom Treaty whose publication is obligatory REGULATIONS ★ Council Regulation (EC, Euratom) No 420/2008 of 14 May 2008 adjusting with effect from 1 July 2007 the remuneration and pensions of officials and other servants of the European Communities ..................................................................................... 1 Commission Regulation (EC) No 421/2008 of 14 May 2008 establishing the standard import values for determining the entry price of certain fruit and vegetables ...................................... 7 Commission Regulation (EC) No 422/2008 of 14 May 2008 setting the allocation coefficient for issuing of licences applied for from 5 May to 9 May 2008 to import sugar products under tariff quotas and preferential agreements ................................................................. 9 ★ Commission Regulation (EC) No 423/2008 of 8 May 2008 on laying down certain detailed rules for implementing Council Regulation (EC) No 1493/1999 and establishing a Community code of oenological practices and processes (Codified version) ........................................ 13 (Continued overleaf) Price: EUR 18 Acts whose titles are printed in light type are those relating to day-to-day management of agricultural matters, and are generally valid for a limited period. EN The titles of all other acts are printed in bold type and preceded by an asterisk. Contents (continued) II Acts adopted under the EC Treaty/Euratom Treaty whose publication is not obligatory ACTS ADOPTED BY BODIES CREATED BY INTERNATIONAL AGREEMENTS Commission 2008/367/EC: ★ Decision No 2/2007 of the Joint Community/Switzerland Air Transport Committee set up under the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation on Air Transport of 15 December 2007 replacing the Annex to the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation on Air Transport ........................ -

Spain Country Handbook 1
Spain Country Handbook 1. This handbook provides basic reference information on Spain, including its geography, history, government, military forces, and communications and transportation networks. This information is intended to familiarize military personnel with local customs and area knowledge to assist them during their assignment to Spain. 2. This product is published under the auspices of the U.S. Department of Defense Intelligence Production Program (DoDIPP) with the Marine Corps Intelligence Activity designated as the community coordinator for the Country Handbook Program. This product reflects the coordinated U.S. Defense Intelligence Community position on Spain. 3. Dissemination and use of this publication is restricted to official military and government personnel from the United States of America, United Kingdom, Canada, Australia, NATO member countries, and other countries as required and designated for support of coalition operations. 4. The photos and text reproduced herein have been extracted solely for research, comment, and information reporting, and are intended for fair use by designated personnel in their official duties, including local reproduction for training. Further dissemination of copyrighted material contained in this document, to include excerpts and graphics, is strictly prohibited under Title 17, U.S. Code. CONTENTS KEY FACTS. 1 U.S. MISSION . 2 U.S. Embassy. 2 U.S. Consulate . 2 Travel Advisories. 2 Entry Requirements . 3 Customs Restrictions . 3 GEOGRAPHY AND CLIMATE . 5 Geography . 5 Bodies of Water. 6 Drainage . 6 Topography . 6 Climate. 7 Vegetation . 10 TRANSPORTATION AND COMMUNICATION . 11 Transportation . 11 Roads . 11 Rail . 14 Maritime . 16 Communication . 17 Radio and Television. 17 Telephone and Telegraph . 18 Newspapers and Magazines . -

The Legal Protection of Geographical Indications in the EU's Bilateral Trade Agreements: Moving Beyond TRIPS
The legal protection of Geographical Indications in the EU’s Bilateral Trade Agreements: moving beyond TRIPS Bernard O’Connor - Laura Richardson 1.- Background A GI is an indication, most commonly the name of a place, which identifies goods as originating from that place and possessing qualities and a reputation essentially attributable to it. At the international level, GIs are legally provided for by the WTO Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), which defines them as “indications which identify a good as originating in the territory of a Member, or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to its geographical origin”1 and establishes a two-tier system for their protection. While Article 22 provides a basic level of protection for all GIs, whereby “evidence must be provided that the consumers are misled”, Article 23 provides an enhanced level of protection specifically for wines and spirits, whereby, regardless of deception, the use of a GI is not permitted when the true origin of the good is indicated or when the GI is used in translation or is accompanied by expressions such as “kind”, “style” or “type”. This two level system of protection has been under negotiation within the WTO’s Doha Development Round (DDR). A number of WTO members led by the European Union (EU) and including among others Thailand, Kenya, Sri Lanka, Switzerland and Turkey2, demand that Article 23 TRIPS protection be extended from wines and spirits to, at a minimum, agricultural and foodstuff products. -

Spain Gourmet Tour, 2011
OUR FOURTH FULL ALTERNATE ANNUAL SPAIN ACTIVITY PROGRAM GOURMET PROGRAM FOR PARTNERS LAST FEW PLACES ! Professional Advancement Escape CME, CULTURAL & GASTRONOMICAL TOUR OF SPAIN NOVEMBER 2 – 12, 2015 The Organizers… Dr. John Cocker, M.B., B.S - Stouffville, Ontario > Dr. John Cocker qualified from St. Barts., London, and came to Canada for military service, qualifying as a Flight Surgeon. He was involved in research into altitude sickness and built a laboratory on Mount Logan at 17,000 ft., the highest building in Canada. Following this, during general practice in Aurora, he became the Medical Director of two cruise lines, sourcing on-board physicians for them. Dr. Cocker founded Stitches Magazine, the Journal of Medical Humour, which became the most read medical Journal in Canada, for which he contributed a regular column. Through the magazine, John has organized over 90 CME conferences in 30 different countries. This will be John's third venture hosting a Doctors-on-Tour program coming after his leadership of the over- subscribed CME tours to South East Asia (October 2014) and Chile & Argentina (March 2015). His a accomplishments also include building several full sized aircraft, the fastest of which he flew around North America. John's passion though is sailing and he skippered a 74 ft. Yawl around the world in 2000- 2002, with 12 passengers to 180 ports in 62 countries. He is the author of several books, the latest, Sailing in Stitches, recounts the adventures during his circumnavigation. Dr. Cocker may be contacted at - Tel: 647-558-1746, e: [email protected] 1 Doctors-on-Tour > Doctors-on-Tour was created in 2000 and specializes in offering ecological, cultural, gastronomical and adventure travel to exotic destinations for physicians who want to combine learning and travelling. -

Vernacular Architecture; Definitions; Associations; France; Europe; Africa; Asia
Prepared and edited by Igor Sollogoub, intern at UNESCO-ICOMOS Documentation Centre. Préparé et édité par Igor Sollogoub, stagiaire au Centre de Documentation UNESCO-ICOMOS. © UNESCO-ICOMOS Documentation Centre, Mar. 2011 ISBN: 978-2-918086-09-3 ICOMOS - International Council on Monuments and sites / Conseil International des Monuments et des Sites 49-51 rue de la Fédération 75015 Paris FRANCE http://www.international.icomos.org UNESCO-ICOMOS Documentation Centre / Centre de Documentation UNESCO-ICOMOS : http://www.international.icomos.org/centre_documentation/index.html Cover photographs: Photos de couverture : Mali, Pays Dogon © IRD ; habitat troglodytique en Turquie © IRD ; Dordogne, France © Marie-Ange Mat ; Maison construite dans un banian au Vanuatu ©IRD 1 Index 1. Reference texts / Textes de référence 6 2. Generalities / Généralités 6 3. Africa / Afrique 9 Angola Benin Botswana Burkina Faso Cameroon / Cameroun Ethiopia / Ethiopie Ghana Kenya Madagascar Mali Mauritania / Mauritanie Niger Nigeria Senegal / Sénégal Seychelles South Africa / Afrique du Sud United Republic of Tanzania / Tanzanie Zambia / Zambie Zimbabwe 2 4. Latin America and the Carribean 21 Amérique latine et Caraïbes Argentina / Argentine Barbados / Barbade Belize Bolivia / Bolivie Bolivarian Republic of Venezuela / République bolivarienne du Vénézuela Brazil / Brésil Chile / Chili Colombia / Colombie Costa Rica Cuba Dominican Republic / République dominicaine Ecuador / Equateur El Salvador Guatemala Guyana / Guyane Haiti Jamaica