Comp-Cham.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Elementary and Grammar Education in Late Medieval France
KNOWLEDGE COMMUNITIES Lynch Education in Late Medieval France Elementary and Grammar Sarah B. Lynch Elementary and Grammar Education in Late Medieval France Lyon, 1285-1530 Elementary and Grammar Education in Late Medieval France Knowledge Communities This series focuses on innovative scholarship in the areas of intellectual history and the history of ideas, particularly as they relate to the communication of knowledge within and among diverse scholarly, literary, religious, and social communities across Western Europe. Interdisciplinary in nature, the series especially encourages new methodological outlooks that draw on the disciplines of philosophy, theology, musicology, anthropology, paleography, and codicology. Knowledge Communities addresses the myriad ways in which knowledge was expressed and inculcated, not only focusing upon scholarly texts from the period but also emphasizing the importance of emotions, ritual, performance, images, and gestures as modalities that communicate and acculturate ideas. The series publishes cutting-edge work that explores the nexus between ideas, communities and individuals in medieval and early modern Europe. Series Editor Clare Monagle, Macquarie University Editorial Board Mette Bruun, University of Copenhagen Babette Hellemans, University of Groningen Severin Kitanov, Salem State University Alex Novikoff, Fordham University Willemien Otten, University of Chicago Divinity School Elementary and Grammar Education in Late Medieval France Lyon, 1285-1530 Sarah B. Lynch Amsterdam University Press Cover illustration: Aristotle Teaching in Aristotle’s Politiques, Poitiers, 1480-90. Paris, BnF, ms fr 22500, f. 248 r. Cover design: Coördesign, Leiden Lay-out: Crius Group, Hulshout Amsterdam University Press English-language titles are distributed in the US and Canada by the University of Chicago Press. isbn 978 90 8964 986 7 e-isbn 978 90 4852 902 5 (pdf) doi 10.5117/9789089649867 nur 684 © Sarah B. -

In Love with Lyon, France and Everything French
jadorelyon In Love with Lyon, France and Everything French Lyon, September 2017 By Aga Marchewka yOUR gUIDE TO LYON WWW.JADORELYON.COM jadorelyon By Aga Marchewka I am a Polish Girl who felt in love with Lyon from the first sight! So I moved here to discover ABOUT AGA AT France…starting from Lyon I want to learn more about France and everything what’s French. I love all JADORELYON those culture’s differences and I love to explore more. I like to share my observations through my IN LOVE WITH LYON, FRANCE AND EVERYTHING blog and photos which I love to take. So that’s why FRENCH jadorelyon was born. Because I truly love Lyon & France & Everything what is French. jadorelyon is my WWW.JADORELYON.COM way of exploring France, the French way of life, food, places to visit, things to do & adding Polish influence to it! jadorelyon By Aga Marchewka fIND ME : JOin Me here & Discover More About Lyon, France & Everything French FB JadoreLyon By Aga JadoreLyon Instagram Google Plus J'adorelyon Tumblr ShopaholicAga Pinterest JadoreLyon Twitter Aga at LinkedIn jadorelyon By Aga Marchewka Summary: 1. LOCATION- Lyon is 2. BASIC NUMBERS ABOUT LYON 3. MAIN FACTS ABOUT LYON AND LYONNAIS 4. PUBLIC TRANSPORT IN LYON 5. LEISURE ACTIVITIES - Top 10 Things To Do In Lyon 6. TOP 5 TRIPS AROUND LYON 7. TOP 5 MUSEUMS AROUND LYON 8. TOP 5 EVENTS IN LYON 9. MY FAVORITE EXPATS WEBSITES AND COMMUNITIES 10. TOP 5 BLOGS ABOUT LYON 11. TOP 5 ONLINE MAGAZINES ABOUT LYON AND FRANCE IN ENGLISH 12. -

Gadagne, Renaissance ! • the GADAGNE MUSEUMS • P
2009 // 2010 Magazine de l’association des artisans et commerçants du Vieux Lyon (ACVL) // LE MAGAZINE DU VIEUX LYON PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO LE PLUS JEUNE DES VIEUX QUARTIERS ! Vieille ville // Old town Achats & loisirs // Shopping & leisures Restaurants // Restaurants Gadagne, Renaissance ! • THE GADAGNE MUSEUMS • p. 6 & 7 ÉDITO *EDITORIAL 3 Édito. • edItoRIal • OH LYON, MON BEAU LYON ! Moi qui te regarde depuis plus de 200 ans, your OLD LyoN, the very same that saw my je ne me lasse pas de ton évolution. birth. So continue to make yourself beautiful and Aujourd’hui tu es devenue une grande parmi I will still continue to look at you for years and les grandes et tu es prête à recevoir le monde years, I, Guignol, your most faithful servant. You entier. Il t’en aura fallu du temps pour éclore, who read these few lines, carry away with you maintenant c’est chose faite et chaque visiteur this picture of hiDDEN, SECRET, WELCOMING pourra prendre de toi, «Lyon», ce qu’il voudra : AND DAZZliNG Lyon, become our greatest Histoire, culture, gastronomie, ambassadors. And you, inhabitants of Lyon, be nouvelles tecHnologies, DÉtente et aware of how lucky you are to live in Lyon, but bien sûr ton Vieux-Lyon celui-là même qui be careful: the old Lyon proverb says, “Not m’a vu naître. Alors continue à te faire belle everybody can be from Lyon, we need a et je te regarderai encore des années et des few from other places too”. Let us hope that années moi, Guignol, ton plus fidèle serviteur. -

The Urbanization of the Periphery: a Spatio- Temporal History of Lyon Since the Eighteenth Century Rau, Susanne
www.ssoar.info The urbanization of the periphery: a spatio- temporal history of Lyon since the eighteenth century Rau, Susanne Veröffentlichungsversion / Published Version Zeitschriftenartikel / journal article Zur Verfügung gestellt in Kooperation mit / provided in cooperation with: GESIS - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften Empfohlene Zitierung / Suggested Citation: Rau, S. (2013). The urbanization of the periphery: a spatio-temporal history of Lyon since the eighteenth century. Historical Social Research, 38(3), 150-175. https://doi.org/10.12759/hsr.38.2013.3.150-175 Nutzungsbedingungen: Terms of use: Dieser Text wird unter einer CC BY Lizenz (Namensnennung) zur This document is made available under a CC BY Licence Verfügung gestellt. Nähere Auskünfte zu den CC-Lizenzen finden (Attribution). For more Information see: Sie hier: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de Diese Version ist zitierbar unter / This version is citable under: https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-379753 The Urbanization of the Periphery: A Spatio-Temporal History of Lyon since the Eighteenth Century ∗ Susanne Rau Abstract: »Die Urbanisierung der Peripherie: Eine raumzeitliche Betrachtungs- weise der Stadt Lyon seit dem 18. Jahrhundert«. Suburbs have mostly received attention in recent years as social hot spots. An examination of the history of urban planning and expansion reveals a fundamental paradox, for it became apparent very early on that living space does not lend itself so readily to plan- ning. Although the rise of suburbs is usually associated with the nineteenth century, a few "early bloomers" can be identified in urban history. Architects such as Antoine-Michel Perrache and Jean-Antoine Morand, who designed ex- pansion projects in the south and in the east of the city of Lyon, became veri- table city planners, if not choreographers, of the suburbs. -

2000 Vol.22 No2
JFJLAJNINfJIN G HTI§ TO JR ~y BULLETIN OF THE INTERNATIONAL PLANNING HISTORY SOCIETY VOL. 22 NO. 2 * 2000 ISSN 0959-5805 JFI~AJNNJI)NjG IHITI§1r0~Y BULLETIN OF THE INTERNATIONAL PLANNING HISTORY SOCIETY BULLETIN OF THE INT ERNATIONAL PLANNING HISTORY SOCIETY EDITOR Dr Kiki Kafkoula Department of Urban and Regional Planning Dr Mark Clapson School of Architecture Dept. of History Aristotle University ofThessalonika University of Luton Thessalonika 54006 75 Castle Street Greece Luton Tel: 303 1 995495 I Fax: 3031 995576 LU I 3AJ UK Dr. Peter Larkham Birmingham School of Planning page 2 Tel: 01582 489034 I Fax: 01582 489014 University of Central England EDITORIAL E-mail: [email protected] Perry Barr Birmingham NOTICES 4 B42 2SU EDITORIAL BOARD UK Tcl: 0121 331 5145 ARTICLES Or Arturo Almandoz Email: [email protected] Departamento de Planificacion Urbana Political symbolism in the Canberra Landscape Universidad Simon Bolivar Professor John Muller 8 Aptdo. 89000 Department ofTown and Regional Planning Peter R. Proudfoot Caracas I086 University of Witwatersrand Venezuela Johannesburg Transatlantic dialogue: Raymond Unwin and the American planning scene Tel: (58 2) 906 4037 I 38 PO Wits2050 Mervyn Miller 17 E-mail: [email protected] South Africa Tel:Oll 7162654 / Fax: 011 403 2519 Or Halina Dunin-Woyseth E-mail: 041 [email protected] .ac.za P RACTICE Oslo School of Architecture Department of Urban Planning Professor Georgio Piccinato The Tony Garnier Urban Museum, Lyon PO Box 271 300 I Drammen Facolta di Architettura 29 Norway Universita -

The Croix Rousse • a Bohemian Chic Neighbourhood • Ancient Working-Class District : the Canuts
SPVL department (Proximity Services and Local Life) Lycée des métiers Jean Lurçat Department : Rhône Number of inhabitants : approximately 530,000 9 arrondissements Maire : Gérard Collomb Location : between 2 rivers (River Rhône and River Saône) Basilica of Fourvière - Dedicated to the Virgin Marie. Louis XIV’s statue - Unique architecture with byzantine, gothique et Place Bellecour roman inspiration. - Built between 1872 and 1884 It is said that the King had come to Lyon once only but he would have helped the town to acquire this Square, as a consequence his statue was built. Gallo-Roman theatre Saint-Jean Cathedral The « Grand Théâtre », the largest in The cathedral was built from 1180 to 1480. It is 79m France, built by Augustus in 15 BC. long, 26m large, 32m high. The big rose on the front The theatre was made for comedies only. has a diameter of 8m. Built in the 18th century, the traboules are pedestrian ways through the buildings that allow to go from one street to another. Formerly used to protect the bundles of silk and of fabrics that the Canuts (silk workers) would transport. Where ? • In the Vieux Lyon • In the Croix-Rousse The Vieux Lyon • One of the largest district from the The « Parc de la tête d’or » Renaissance of Europe • The zoological park • Restaurants and bars • The botanical garden • Numerous museums • The rose gardens • The Cathedral The Croix Rousse • A bohemian chic neighbourhood • Ancient working-class district : The Canuts. Lyon = capital city of the silk • High buildings with high windows • The market, the -

Greek Coins.” Grierson 59
THE 2018 NEW YORK BOOK AUCTION Featuring Selections from the Library of William A. Burd & Other Properties Public Auction and Online Sale 148 Saturday, January 13, 2018 at 12:30 P.M. Auctioneer Marissa Russell, New York Auctioneer License No. 1341093 Sale Location The New York International Numismatic Convention Grand Hyatt New York • Empire State Ballroom 1 • 109 E. 42nd Street • New York, NY 10017 Lots may be viewed by appointment at the offices of Kolbe & Fanning in Gahanna, Ohio from Dec. 1 until Dec. 16, 2017. Selected lots may be viewed at the Grand Hyatt New York Plymouth Room on Thursday, January 11, 2018 from 9:00 A.M. until 5:00 P.M., Friday, January 12 from 9:00 a.m. until 6:00 p.m., and Saturday, January 13 from 9:00 A.M. to 12:00 NOON. Bidding Instructions Internet Bidding: Advance registration required at bid.numislit.com. Mail and fax bids must arrive in Gahanna by Monday, January 8, 2018. No mail or fax bids arriving after that day will be processed and no telephone message bids left after January 9 on the Gahanna business line will be accepted. Email bids will be accepted until Friday, January 12. No email bids arriving on January 13 can be processed. From January 10 to January 12, telephone bids may be placed by calling (614) 256-8915. Absentee and Live Internet Bidding bid.numislit.com 141 W. Johnstown Road • Gahanna, Ohio 43230 (614) 414-0855 • Fax (614) 414-0860 • numislit.com • [email protected] Terms of Sale Please note that the Terms of Sale for this public auction differ from those of our mail-bid sales and that bidders should be aware of the following. -
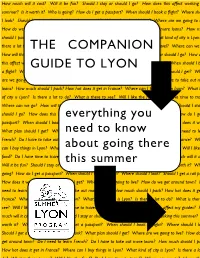
The Companion Guide to Lyon
How much will it cost? Will it be fun? Should I stay or should I go? How does this affect working this summer? Is it worth it? Who is going? How do I get a passport? When should I book a flight? Where should I look? Should I get a rail pass? How does it work? What plan should I get? Where are we going to live? How do we get around town? Do I need to learn French? Do I have to take out more loans? How much should I pack? How hot does it get in France? Where can I buy things in Lyon? What kind of city is Lyon? Is there a lot to do?THE What is there toCOMPANION see? Will I like the food? Do I have time to travel? Where can we go? How will this affect my grades? How much will it cost? Will it be fun? Should I stay or should I go? How does this affect working this summer? Is it worth it? Who is going? How do I get a passport? When should I book GUIDE TO LYON a flight? Where should I look? Should I get a rail pass? How does it work? What plan should I get? Where are we going to live? How do we get around town? Do I need to learn French? Do I have to take out more loans? How much should I pack? How hot does it get in France? Where can I buy things in Lyon? What kind of city is Lyon? Is there a lot to do? What is there to see? Will I like the food? Do I have time to travel? Where can we go? How will this affect my grades? How much will it cost? Will it be fun? Should I stay or should I go? How does this affecteverything working this summer? Is it worth you it? Who is going? How do I get a passport? When should I book a flight? Where should I look? -

Lyon, a Tattooed City an Interactive Qualifying Project Report
Lyon, A Tattooed City An Interactive Qualifying Project Report By Hélèna Cohen Danielle Felten With faculty advisors Fabienne Miller and Peter Hansen 6/28/2019 Submitted to the Faculty of WORCESTER POLYTECHNIC INSTITUTE In partial fulfillment of the requirements for the Degree of Bachelor of Science This report represents the work of WPI undergraduate students submitted to the faculty as evidence of completion of a degree requirement. WPI routinely publishes these reports on its website without editorial or peer review. For more information about the projects program at WPI, please see https://www.wpi.edu/project-based-learning/global-project-program Abstract This project observed wall murals, or murs peints, in Lyon, France, with a focus on murals that have a significance to Lyon’s history. A mural could be historically significant for a variety of reasons, whether due to size, location, composition, or subject. In surveys, residents of Lyon identify murals with the city’s patrimoine, or heritage. Research, tours, and interviews examined the legal and financial context for wall murals. The importance of murals throughout Lyon give its people a sense of pride, and they view wall murals as more than just street art. ii Executive Summary Culture, defined by Google as “the arts and other manifestations of human intellectual achievement regarded collectively, a refined understanding or appreciation of culture, customs, arts, social institutions, and achievements of a particular nation, people, or other social group, and the attitudes and behavior characteristic of a particular social group” can be interpreted in many ways (Dictionary, n. d). This definition Ph t Th Cit f L C dit could be seen as very vague, so understanding a new culture can be hard to determine what exactly should be categorized. -

Visites Guidées Guided Tours
VISITES GUIDÉES GUIDED TOURS * ACCRO À LYON ACCRO * Laurence, Eléonore, Jérôme, Véronique, Delphine, Anne-Marie, Claire, Anne, Anneliese, Laureen, Catherine, Françoise, Claude, Anne, Magali, Bénédicte 1 Guides conférenciers - ONLYLYON Tourisme et Congrès Excursion 1h30 Visite insolite en tram-train Découvrez tout Lyon sur l’Impériale Tél. 04 78 56 32 39 - [email protected] - www.lyoncitytour.fr Au cœur de la presqu’île, à 10 minutes à pied de la Place Bellecour et du Vieux Lyon, l’hôtel IBIS vous accueille dans un bâtiment historique de 1916, voisin de la célèbre Brasserie Georges. 123 chambres climatisées à 50 m de la gare de Perrache Parking pour cars devant l’hôtel 28 cours de Verdun Perrache - 69002 LYON Tél. 04 78 37 56 55 - Fax 04 78 37 02 58 E-mail : [email protected] - www.ibishotel.com ÉDITO EDITORIAL � � Cette brochure rassemble tous les thèmes This brochure brings together all visit themes de visites pour satisfaire vos demandes : de to meet your needs: from the unmissable to the traboules en murs peints, vous découvrirez que most unusual, without forgetting the made-to- Lyon offre une palette très riche de découvertes. measure, you will find that Lyon has a very wide Les visites incontournables vous emmènent à la range on offer. rencontre de 2000 ans d’histoire, dans les rues Unmissable visits will lead you to an encounter étroites du Vieux-Lyon ou à la découverte de with 2,000 years of history in the narrow streets l’histoire des tisseurs de soie à la Croix-Rousse. of Old Lyon or to finding out about the history of Les visites insolites vous ouvrent les portes silk weavers in Croix-Rousse. -

White Working Class Communities in Lyon
EUROPE’S WHITE WORKING CLASS COMMUNITIES 1 LYON AT HOME IN EUROPE EUROPE’S WHITE WORKING CLASS COMMUNITIES LYON OOSF_LYON_cimnegyed-150407.inddSF_LYON_cimnegyed-150407.indd CC11 22015.04.07.015.04.07. 114:37:194:37:19 ©2015 Open Society Foundations This publication is available as a pdf on the Open Society Foundations website under a Creative Commons license that allows copying and distributing the publication, only in its entirety, as long as it is attributed to the Open Society Foundations and used for noncommercial educational or public policy purposes. Photographs may not be used separately from the publication. ISBN: 9781940983196 Published by OPEN SOCIETY FOUNDATIONS 224 West 57th Street New York NY 10019 United States For more information contact: AT HOME IN EUROPE OPEN SOCIETY INITIATIVE FOR EUROPE Millbank Tower, 21-24 Millbank, London, SW1P 4QP, UK Design by Ahlgrim Design Group Layout by Q.E.D. Publishing Printed in Hungary. Printed on CyclusOffset paper produced from 100% recycled fi bres OOSF_LYON_cimnegyed-150407.inddSF_LYON_cimnegyed-150407.indd CC22 22015.04.07.015.04.07. 114:37:204:37:20 EUROPE’S WHITE WORKING CLASS COMMUNITIES 1 LYON THE OPEN SOCIETY FOUNDATIONS WORK TO BUILD VIBRANT AND TOLERANT SOCIETIES WHOSE GOVERNMENTS ARE ACCOUNTABLE TO THEIR CITIZENS. WORKING WITH LOCAL COMMUNITIES IN MORE THAN 100 COUNTRIES, THE OPEN SOCIETY FOUNDATIONS SUPPORT JUSTICE AND HUMAN RIGHTS, FREEDOM OF EXPRESSION, AND ACCESS TO PUBLIC HEALTH AND EDUCATION. OOSF_LYON_cimnegyed-150407.inddSF_LYON_cimnegyed-150407.indd 1 22015.04.07.015.04.07. 114:37:204:37:20 AT HOME IN EUROPE 2 ACKNOWLEDGEMENTS Acknowledgements This city report was prepared as a part of series of reports titled Europe´s White Working Class Communities. -

Historic Site of Lyon
· the town has adapted itself in particular to the silk WORLD HERITAGE LIST trade, with the houses of the canuts (silk weavers) of the Croix-Rousse serving as precedents for an original form of social life; there has been continu- Lyon (France) ous spiritual enthusiasm, demonstrated by the many religious buildings constructed over the centuries, and a religious fervour, the apogee and the No 872 persistence of which are symbolized by the Basilica of Fourvière. Criterion iii The historic site of Lyon may be regarded as “an outstanding example of a traditional human settlement,” which combines an exceptional site with an urban continuity that is remarkable for its harmony. Whilst in most European cities the centre has been developed by rebuilding on the same site, in Lyon it has Identification moved eastwards, deserting the former centres. For this reason the city has preserved its centres in preceding Nomination The historic site of Lyon periods intact and legible. The unusual homogeneity of the urban fabric that strikes the eye results from Location Région Rhône-Alpes harmony in the architecture that goes beyond stylistic evolution and from the symbiosis between the natural State Party France site of the city and its urbanization. Criterion v Date 10 July 1997 With the first western Christians having been martyred there in AD 177, Lyon was the centre of the expansion of Christianity in the west. Religious and secular organizations devoted to the assistance of the poor and social works throughout the Justification by State Party world have always been based in Lyon. Two figures from recent history admirably illustrate the The special quality of the historic site of Lyon derives international role of Lyon in this field: from its exceptional setting, on two hills at the confluence of two rivers, combined with the material · Frédéric Ozanam was born in Milan in 1813 and manifestation of its way of life through its town plan brought up in Lyon, where in 1833 he founded the and its architecture.