PVTEOLI Da Tiberio a Traiano
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
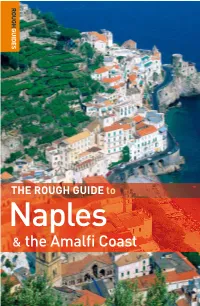
The Rough Guide to Naples & the Amalfi Coast
HEK=> =K?:;I J>;HEK=>=K?:;je CVeaZh i]Z6bVaÒ8dVhi D7FB;IJ>;7C7B<?9E7IJ 7ZcZkZcid BdcYgV\dcZ 8{ejV HVc<^dg\^d 8VhZgiV HVciÉ6\ViV YZaHVcc^d YZ^<di^ HVciVBVg^V 8{ejVKiZgZ 8VhiZaKdaijgcd 8VhVaY^ Eg^cX^eZ 6g^Zcod / AV\dY^EVig^V BVg^\a^Vcd 6kZaa^cd 9WfeZ_Y^_de CdaV 8jbV CVeaZh AV\dY^;jhVgd Edoojda^ BiKZhjk^jh BZgXVidHVcHZkZg^cd EgX^YV :gXdaVcd Fecf[__ >hX]^V EdbeZ^ >hX]^V IdggZ6ccjco^ViV 8VhiZaaVbbVgZY^HiVW^V 7Vnd[CVeaZh GVkZaad HdggZcid Edh^iVcd HVaZgcd 6bVa[^ 8{eg^ <ja[d[HVaZgcd 6cVX{eg^ 8{eg^ CVeaZh I]Z8Vbe^;aZ\gZ^ Hdji]d[CVeaZh I]Z6bVa[^8dVhi I]Z^haVcYh LN Cdgi]d[CVeaZh FW[ijkc About this book Rough Guides are designed to be good to read and easy to use. The book is divided into the following sections, and you should be able to find whatever you need in one of them. The introductory colour section is designed to give you a feel for Naples and the Amalfi Coast, suggesting when to go and what not to miss, and includes a full list of contents. Then comes basics, for pre-departure information and other practicalities. The guide chapters cover the region in depth, each starting with a highlights panel, introduction and a map to help you plan your route. Contexts fills you in on history, books and film while individual colour sections introduce Neapolitan cuisine and performance. Language gives you an extensive menu reader and enough Italian to get by. 9 781843 537144 ISBN 978-1-84353-714-4 The book concludes with all the small print, including details of how to send in updates and corrections, and a comprehensive index. -

La Via Appia
LA VIA APPIA Storia Alla fine del IV secolo a.C. Roma era padrona di gran parte della Penisola e una delle grandi potenze del Mediterraneo, solo pochi gruppi etnici, a sud delle Alpi, restavano da soggiogare. L'Urbe stessa stava cambiando il suo volto tradizionale assumendo quello di una capitale, ricca di opere pubbliche erette dai suoi generali vittoriosi. Il Foro, il Campidoglio, erano luoghi dove si ostentava la potenza crescente della città. Solo la nazione Sannita sfidava ancora l'egemonia di Roma da sud; da Paestum all'Apulia la Lega Sannitica minacciava di prendere Capua, non lontana dai confini del Lazio. La Via Appia nacque in questo contesto, come una via militare che consentiva di accelerare le comunicazioni coi confini meridionali del territorio conquistato. La strada fu poi estesa man mano che altri territori cadevano sotto il dominio di Roma. Appio Claudio Cieco, il console, fu colui che rese celebre la funzione di censore per le grandi imprese di interesse pubblico da lui realizzate, ma il suo nome fu reso famoso dalla Via Appia che gli sopravvisse. Nel 1993 la Via Appia compie 2305 anni, Appio fece tracciare la strada all'epoca delle guerre contro i Sanniti, nel 312 a.C., da Roma a Capua, per una distanza di 124 miglia romane. Appio impiegò anche i suoi capitali personali laddove le tesorerie dello stato erano insufficienti. Al primo posto fra tutte le strade di Roma c'era la Via Appia, a suo tempo la più lunga, la più bella, la più imponente via che fosse mai stata tracciata in alcuna parte del mondo, al punto che i romani la chiamarono "Regina di tutte le vie". -

Incidenti Mortali 2000-2013
cProv PROVINCIACODICE NOME STRADA ESTESA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Incidenti Mortali 092 Cagliari SS39101 SS 391 - di Elmas 0,757 0 0 0 0 0 0 003 Novara SS59601 SS 596 - dei Cairoli 0,694 0 0 0 0 0 0 070 CampobassoSS71101 SS 711 - Tangenziale Ovest di Campobasso 1,8 0 0 0 0 0 0 028 Padova SS51501 SS 515 - Noalese 4,115 0 1 0 0 0 2 016 Bergamo SS63901 SS 639 - dei Laghi di Pusiano e di Garlate 2,277 1 0 0 0 0 0 015 Milano AA05101 A 51 - Tangenziale Est Milano 17,7 6 4 5 10 4 5 058 Roma SS00405 SS 004 dir - via Salaria 2,9 0 0 0 1 0 0 098 Lodi SS41201 SS 412 - della Val Tidone 3,415 0 0 0 0 0 0 034 Parma SS00936 SS 009 var/a - Tangenziale Sud di Parma 7,375 0 0 0 0 0 0 011 La Spezia RA01901 Raccordo La Spezia-Lerici 3,7 0 0 0 0 0 0 001 Torino SS02034 SS 020 var1 - Variante di La Loggia 3,8 0 0 0 0 0 0 046 Lucca SS01237 SS 012 var/b - Variante di Ponte a Moriano 4 0 0 0 0 0 1 001 Torino SS02434 SS 024 var - Variante Alpignano-Pianezza 8,1 0 0 0 0 0 0 057 Rieti NC26501 NSA 265 - ex SS 004 Variante Galleria Colle Giardino 4,26 0 0 0 0 0 0 015 Milano SS41201 SS 412 - della Val Tidone 8,525 2 0 0 2 1 0 108 Monza e dellaSS03501 Brianza SS 035 - dei Giovi 8,6 1 1 3 1 0 1 098 Lodi SS00905 SS 009 dir - Tangenziale Est di Lodi 4,366 0 0 0 0 0 0 072 Bari AA01421 A 14 - Raccordo per Tangenziale di Bari 4,6 0 0 0 0 0 0 034 Parma SS00934 SS 009 var - Tangenziale Nord Ovest di Parma 18,644 0 1 1 1 4 2 093 PordenoneNC03001 NSA 030 - di Montereale Valcellina 4,935 0 0 0 0 0 0 103 Verbano-Cusio-OssolaSS22901 SS 229 - del Lago d'Orta 9,889 0 2 1 1 0 1 -
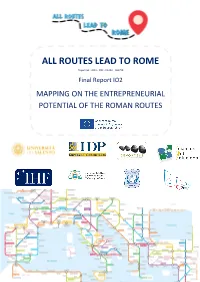
Download IO2 Final Report
ALL ROUTES LEAD TO ROME Project ref.: 2019 - IT02 - KA203 – 062798 Final Report IO2 MAPPING ON THE ENTREPRENEURIAL POTENTIAL OF THE ROMAN ROUTES a a a With the support of the Erasmus+ programme of the European Union. This document and its contents reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Content Content..................................................................................................................................... 2 1. Introduction ...................................................................................................................... 6 1.1. Grounding: Secondary Research ................................................................................ 6 1.2. Involvement: Primary Research ................................................................................. 7 2. The Sample ....................................................................................................................... 8 2.1. Descriptives ............................................................................................................... 8 2.2. The Roman Routes Questionnaire ............................................................................ 11 2.3. Results ..................................................................................................................... 12 2.4. Conclusions ............................................................................................................ -

Caserta and Matese
Generale_INGL 25-03-2008 13:28 Pagina 122 Caserta and Matese 122 123 This is the area referred to as “Campania Felix ” by ancient populations due to its privileged position i and the fertility of its soil. Irrigated by the Volturno and favoured by a mild climate, the province extends from the sea to the Apennines, alternating between lush vegetation and places of great historic and cultural interest. The vast plains of the Caserta area Ente Provinciale per il open onto the sea and host one of the most famous Turismo di Caserta and widely visited monuments of the Region: the Palazzo Reale Royal Palace (Reggia) of Caserta. tel. 0823 321137 www.eptcaserta.it Santa Maria Capua Vetere, Capua and Sessa Aurunca, are also of historic and archaeological Ente Parco del Matese interest, all concentrated in the area of Caserta via Sannitica known as Terra di Lavoro. The Domitian shore is Piedimonte Matese the province’s coastline, an area rich with pine tel. 0823 917232 stands, wide sandy beaches and famous bathing Comunità Montana establishments. Monte Santa Croce Inland, the massif of Matese offers marvellous via Roma 30 uncontaminated nature and villages where art and Roccamonfina popular traditions are still strongly felt; one of the tel. 0823 921276 least contaminated areas of Italy. Calvi Vecchia Scavi archeologici di Cales strada statale Casilina tel. 0823 652533 Capua Museo Provinciale Campano via Roma 68 tel. 0823 961402 Santa Maria Capua Vetere Museo Archeologico dell’antica Capua via Roberto d’Angiò 48 tel. 0823 844206 Caserta Reggia e Parco via Douhet 22 tel. -

Paul's Missionary Journeys
TRAVEL GUIDE PAUL’S MISSIONARY JOURNEYS CYPRUS • TURKEY • GREECE MALTA • ITALY 1 PAUL’S MISSIONARY JOURNEYS MILAN VENICE ZAGREB ROMANIA BOSNA & BELGRADE BUCHAREST HERZEGOVINA CROATIA SAARAJEVO PISA SERBIA ANCONA ITALY A MONTENEGRO PRISTINA Black Sea dr PODGORICA BULGARIA PESCARA ia KOSOVA SOFIA ti ROME c S SINOP e SKOPJE Sinope a EDIRNE Amastris Three Taverns FOGGIA MACEDONIA PONTUS SAMSUN Forum of Appius TIRANA Philippi ISTANBUL Amisos Neapolis TEKIRDAG AMASYA NAPLES Amphipolis Byzantium Hattusa T Thessalonica Amaseia ORDU Puteoli TARANTO Nicomedia y SORRENTO Pella Apollonia Marmara Sea rr ALBANIA Nicaea Tavium h BRINDISI Beroea Kyzikos en SAPRI CANAKKALE BITHYNIA ANKARA Troy BURSA ia Troas MYSIA Dorylaion Gordion n S Larissa A Hadrianuthera Assos Pessinous T U R K E Y e Adramytteum Cotiaeum e ge GALATIA a GREECE Mytilene Pergamon Aizanoi CATANZARO a Thyatira n S CAPPADOCIA IZMIR ASIA PHRYGIA Prymnessus Delphi Chios Smyrna Philadelphia Mazaka Sardis PALERMO Ionian Sea Athens Antioch Pisidia MESSINA e Nysa Hierapolis Rhegium Corinth a Ephesus Apamea KONYA COMMOGENE Laodicea TRAPANI Olympia Mycenae Samos Tralles Iconium Aphrodisias Arsameia Epidaurus Sounion Colossae CATANIA Miletus Lystra Patmos CARIA SICILY Derbe ADANA GAZIANTEP Siracuse Sparta Halicarnassus ANTALYA Perge Tarsus Cnidus Cos LYCIA Attalia Side CILICIA Soli Korakesion Korykos Antioch Patara Mira Seleucia Rhodes Seleucia Malta Anemurion Pieria CRETE MALTA Knosos CYPRUS Salamis TUNISIA Fair Haven Paphos Kition Amathous SYRIA Kourion BEIRUT LEBANON DAMASCUS PAUL’S MISSIONARY -

Quaderni Della Scuola Di Specializzazione in Archeologia
ALMA MATER STUDIORUM - U NIVERSITÀ DI BOLOGNA OCNUS Quaderni della Scuola di Specializzazione in Archeologia 14 2006 ESTRATTO Direttore Responsabile Giuseppe Sassatelli Comitato Scientifico Pier Luigi Dall’Aglio Sandro De Maria Fiorenzo Facchini Maria Cristina Genito Gualandi Sergio Pernigotti Giuseppe Sassatelli Coordinamento Maria Teresa Guaitoli Editore e abbonamenti Ante Quem soc. coop. Via C. Ranzani 13/3, 40127 Bologna tel. e fax + 39 051 4211109 www.antequem.it Redazione Valentina Gabusi, Flavia Ippolito, Viviana Sanzone Traduzione degli abstracts Marco Podini Abbonamento 40,00 Richiesta di cambi Dipartimento di Archeologia Piazza San Giovanni in Monte 2, 40124 Bologna tel. +39 051 2097700; fax +39 051 2097701 Le sigle utilizzate per i titoli dei periodici sono quelle indicate nella «Archäologische Bibliografie» edita a cura del Deutsches Archäologisches Institut. Autorizzazione tribunale di Bologna n. 6803 del 17.4.1988 Senza adeguata autorizzazione scritta, è vietata la riproduzione della presente opera e di ogni sua parte, anche parziale, con qualsiasi mezzo effettuata, compresa la fotocopia, anche ad uso interno o didattico. ISSN 1122-6315 ISBN 88-7849-019-9 © 2006 Ante Quem soc. coop. IndIce Prefazione di Giuseppe Sassatelli 9 ARTICOLI Viviana Ardesia Sulle dinamiche insediamentali della Valle del Pescara nell’Età del Bronzo (II millennio a.C.) 11 Giovanni Azzena Appunti per una rilettura dell’urbanistica di Atri romana 27 Julian Bogdani Le fortificazioni di età ellenistica di Çuka e Aitoit (Epiro) 43 Fausto Bosi Sul mito dell’Atlantide 61 Domenico Camardo Gli scavi ed i restauri di Amedeo Maiuri. Ercolano e l’esperimento di una città museo 69 Antonella Coralini, Daniela Scagliarini Corlàita, Riccardo Helg, Enrico Giorgi, Massimo Zanfini, Silvia Minghelli, Carolina Ascari Raccagni, Gilda Assenti Domus Herculanensis Rationes (DHER). -

Spazio Enel Anagrafica
A ogni angolo, c'è uno Spazio Enel che ti aspetta. Scopri quello più vicino a te. REGIONE PROVINCIA COMUNE CAP INDIRIZZO RAGIONE SOCIALE N. TELEFONO ABRUZZO AQ L'AQUILA 67100 VIA XX SETTEMBRE 14 SPAZIO ENEL PARTNER 0862294572 ABRUZZO AQ AVEZZANO 67051 Via B. Cassinelli Snc SPAZIO ENEL PARTNER 0863472721 ABRUZZO AQ MAGLIANO DE' MARSI 67062 Piazza San Luigi Orione, 11 SPAZIO ENEL PARTNER 086351160 ABRUZZO AQ AVEZZANO 67051 Via Antonio Gramsci, 48 SPAZIO ENEL PARTNER 08631872311 ABRUZZO AQ CASTEL DI SANGRO 67031 Piazza T. Patini, 28 SPAZIO ENEL PARTNER 0864840864 ABRUZZO AQ SULMONA 67039 Viale Papa Giovanni XXIII SPAZIO ENEL PARTNER 0864547032 ABRUZZO AQ L'AQUILA 67100 Via Guglielmo Marconi, 7/E SPAZIO ENEL PARTNER 0862318694 ABRUZZO AQ ROCCA DI MEZZO 67048 Piazza Principe di Piemonte, 22 SPAZIO ENEL PARTNER 0862916176 ABRUZZO CH ORTONA 66026 Corso Matteotti, 32 SPAZIO ENEL PARTNER 0858963997 ABRUZZO CH CHIETI 66100 Piazza San Giustino, 3 SPAZIO ENEL PARTNER 0871346734 ABRUZZO CH CHIETI 66100 Via Colonnetta, 157 SPAZIO ENEL PARTNER 0871782169 ABRUZZO CH FRANCAVILLA AL MARE 66023 Via Nazionale Adriatica, 58 SPAZIO ENEL PARTNER 0854912125 ABRUZZO CH SAN SALVO 66050 Corso Umberto I, 86 SPAZIO ENEL PARTNER 0873549551 ABRUZZO CH VASTO 66054 Via Mazzini, 192 SPAZIO ENEL PARTNER 0873366406 ABRUZZO CH VASTO 66054 Via Torino, 88 SPAZIO ENEL PARTNER 0873367685 ABRUZZO CH LANCIANO 66034 Viale Cappuccini, 35 SPAZIO ENEL PARTNER 0872459936 ABRUZZO CH LANCIANO 66034 Via Vittorio Veneto, 1 SPAZIO ENEL PARTNER 0872469557 ABRUZZO CH ATESSA 66041 Via Cesare Battisti, 40 SPAZIO ENEL PARTNER 0872866388 ABRUZZO PE MONTESILVANO 65015 Corso Umberto I, 489 SPAZIO ENEL PARTNER 0854451621 ABRUZZO PE MONTESILVANO 65015 Via G. -

Un'eredità Culturale Nel Territorio Campano: Antichi Ponti in Muratura
Publisher: FeDOA Press - Centro di Ateneo per le Biblioteche dell’Università di Napoli Federico II Registered in Italy Publication details, including instructions for authors and subscription information: http://www.eikonocity.it Un’eredità culturale nel territorio campano: antichi ponti in muratura tra fonti storico-iconografiche e conservazione Claudia Aveta Università degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Architettura To cite this article: Aveta, C. (2017).Un’eredità culturale nel territorio campano: antichi ponti in muratura tra fonti storico-iconografiche e conserva- zione: Eikonocity, 2017, anno II, n. 2, 71-88, DOI: 10.6092/2499-1422/5225 To link to this article: http://dx.doi.org/10.6092/2499-1422/5225 FeDOA Press makes every effort to ensure the accuracy of all the information (the “Content”) contai- ned in the publications on our platform. FeDOA Press, our agents, and our licensors make no repre- sentations or warranties whatsoever as to the accuracy, completeness, or suitability for any purpose of the Content. Versions of published FeDOA Press and Routledge Open articles and FeDOA Press and Routledge Open Select articles posted to institutional or subject repositories or any other third- party website are without warranty from FeDOA Press of any kind, either expressed or implied, inclu- ding, but not limited to, warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infrin- gement. Any opinions and views expressed in this article are the opinions and views of the authors, and are not the views of or endorsed by FeDOA Press . The accuracy of the Content should not be relied upon and should be independently verified with primary sources of information. -

Scambi E Commerci in Area Vesuviana: I Dati Delle Anfore Dai Saggi Stratigrafici I.E
Scambi e commerci in area vesuviana: i dati delle anfore dai saggi stratigrafici I.E. (Impianto Elettrico) 1980-81 nel Foro di Pompei rappresenta la prima monografia pompeiana dedicata esclusivamente all’analisi delle testimonianze anforiche portate alla luce da attività RLAMP di scavo archeologico nella città sepolta dall’eruzione del Vesuvio, ed analizza in prospettiva diacronica tutte le produzioni in circolazione 14 tra il VI/V secolo a.C. e l’anno 79 d.C. I quattordici capitoli del volume offrono al lettore i dati relativi alle anfore arcaiche, non abbondanti ma molto significative per le fasi più antiche dell’insediamento, e alle anfore greche, specialmente rodie di epoca ellenistica, che si distinguono per l’abbondanza di esemplari bollati. Sono poi presentate le anfore vinarie italiche di epoca repubblicana, che disegnano un panorama commerciale di grande vitalità, nel quale la Campania gioca un ruolo preminente, intrecciando le sue produzioni con quelle di vesuviana in area e commerci (eds) Scambi Bernal-Casasola e Daniela Cottica Scambi e commerci altre aree della penisola. Si passano quindi in rassegna le anfore africane, o di tradizione punica, caratterizzate da una complessa seriazione tipologica che ben illustra gli intensi rapporti commerciali con il nordafrica e l’isola di Ibiza; seguono poi le anfore punico-gaditane da garum, identificate per la prima volta in area vesuviana proprio in questo studio, e le Dressel 21-22, contenitori per il commercio italico in area vesuviana di salagione di recente caratterizzazione e, infine, le produzioni del periodo tardo-repubblicano e giulio-claudio. Completano il volume una serie di analisi complementari effettuate su alcune delle anfore prese in esame: si indaga il paleocontenuto di alcune serie (con le analisi dei residui organici), si analizza la composizione di alcuni impasti, si studiano i sistemi di chiusura e sigillatura delle anfore e del loro contenuto (opercula) e si illustrano alcuni casi di reimpiego di anfore, o parti di esse, come affilatoi, come lisciatoi e a fini statici.