Terza Serie (1999)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Benedetto Xvi Per La Canonizzazione Dei Beati
CAPPELLA PAPALE PRESIEDUTA DAL SANTO PADRE BENEDETTO XVI PER LA CANONIZZAZIONE DEI BEATI ARCANGELO TADINI PRESBITERO FONDATORE DELLA CONGREGAZIONE DELLE SUORE OPERAIE DELLA SANTA CASA DI NAZARETH BERNARDO TOLOMEI ABATE FONDATORE DELLA CONGREGAZIONE DI SANTA MARIA DI MONTE OLIVETO DELL’ORDINE DI SAN BENEDETTO NUNO DE SANTA MARIA ÁLVARES PEREIRA RELIGIOSO DELL’ORDINE DEI CARMELITANI GELTRUDE COMENSOLI VERGINE FONDATRICE DELL’ISTITUTO DELLE SUORE SACRAMENTINE CATERINA VOLPICELLI VERGINE FONDATRICE DELLA CONGREGAZIONE DELLE ANCELLE DEL SACRO CUORE PIAZZA SAN PIETRO, 26 APRILE 2009 IIIDOMENICADIPASQUA 1 2 I PROFILO BIOGRAFICO DEI BEATI 3 4 ARCANGELO TADINI (1846-1912) 6 ARCANGELO TADINI, sacerdote bresciano vissuto tra il 1846 e il 1912, è una figura limpida e affascinante. Uomo intraprendente, prete autentico, ha intrecciato sapientemente rischio e fede, amore per gli uomini e amore per Dio, austerità e tenerezza. Nasce a Verolanuova (Brescia) il 12 ottobre 1846. Conclusi gli studi elementari nel paese natale, frequenta il ginnasio a Lovere (Bergamo). Nel 1864 entra nel seminario di Brescia e nel 1870 è ordinato sacerdote. Dal 1871 al 1873 è nominato vicario-cooperatore a Lo- drino (Brescia), piccolo paese di montagna, e dal 1873 cappellano al santuario di Santa Maria della Noce, frazione di Brescia. Nel 1885 inizia il suo servizio a Botticino Sera (Brescia) come vicario-cooperatore; due anni dopo, è nominato Parroco e vi rimane fino al 1912, anno della sua morte. All’inizio del suo mandato, dal pulpito afferma con forza: «Starò con voi, vivrò con voi, morirò con voi». Gli anni vissuti a Botticino sono certamente i più fecondi della vita di don Tadini. -

Mensile Di Vita Parrocchiale Anno XXXIV - N
L’Angelo di Verola 4 Mensile di vita Parrocchiale anno XXXIV - n. 4 aprile 2009 sommario La parola del Prevosto (don Luigi) 3 Calendario liturgico (T. Cervati) 4 Due minuti con don Primo Mazzolari 10 o Sant’Arcangelo Tadini Il Prevosto 12 La lettera del Vescovo (L. Monari) 13 Il Santo che è Uno di noi 14 Intuizione d’amore (M. Emma Arrighini) 16 Tadini e il miracolo della vita (M. R. Biscella) 17 Scenari diversi, valori uguali (F. Fiorese) 19 Omelia di don Arturo Balduzzi 20 Le Suore Operaie 23 Le opere di don Tadini nel mondo 24 In copertina Preghiere a Sant’Arcangelo 26 Beato Angelico: Il programma dei festeggiamenti 27 Noli me tangere Don Tadini in Internet 28 Firenze, Convento di San Marco Vita parrocchiale L’Anno Paolino (Don Carlo) 29 L’Angelo di Verola Il nuovo Consiglio Presbiterale 31 Mensile di Vita Un esame di coscienza (Don Giuseppe) 33 Lectio Divina (Don Graziano) 34 Parrocchiale Verolese Briciole Francescane (A. Rossi) 36 A cura di don Luigi Bracchi Movimento dei Focolari (R. Fontana) 37 Suor Ester Sangalli 38 Don Stefano Varnavà 39 Redattori: Sac. Giuseppe Lama Dall’oratorio Don Bosco e l’Oratorio 7ª (D. Giuseppe) 42 Sac. Giovanni Consolati Insieme per Marco 43 Sac. Carlo Civera Arte & Cultura Sac. Graziano Tregambe Le Poesie di Rosetta (R. Mor) 44 Tiziano Cervati L’angolo di Massimo (M. Calvi) 45 Il mondo tra le mani 46 Telefoni utili Le nostre rubriche 030 931210 (Casa Canonica) Verola Missionaria (P. Sala) 47 Voi che ne pensate? (L. A. Pinelli) 48 030 932975 (abit. -

Thriving in Broken Futures: the Paradox of Church in Historic Watersheds Christopher Lars Arney George Fox University
Digital Commons @ George Fox University Doctor of Ministry Seminary 1-1-2013 Thriving in broken futures: the paradox of church in historic watersheds Christopher Lars Arney George Fox University This research is a product of the Doctor of Ministry (DMin) program at George Fox University. Find out more about the program. Recommended Citation Arney, Christopher Lars, "Thriving in broken futures: the paradox of church in historic watersheds" (2013). Doctor of Ministry. Paper 40. http://digitalcommons.georgefox.edu/dmin/40 This Dissertation is brought to you for free and open access by the Seminary at Digital Commons @ George Fox University. It has been accepted for inclusion in Doctor of Ministry by an authorized administrator of Digital Commons @ George Fox University. GEORGE FOX UNIVERSITY THRIVING IN BROKEN FUTURES: THE PARADOX OF CHURCH IN HISTORIC WATERSHEDS A DISSERTATION SUBMITTED TO THE FACULTY OF GEORGE FOX EVANGELICAL SEMINARY IN CANDIDACY FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF MINISTRY BY CHRISTOPHER LARS ARNEY PORTLAND, OREGON MARCH 2013 George Fox Evangelical Seminary George Fox University Portland, Oregon CERTIFICATE OF APPROVAL ________________________________ DMin Dissertation ________________________________ This is to certify that the DMin Dissertation of Christopher Lars Arney has been approved by the Dissertation Committee on March 22, 2013 for the degree of Doctor of Ministry in Leadership in the Emerging Culture. Dissertation Committee: Primary Advisor: Kent Yinger, PhD Secondary Advisor: Leonard Hjalmarson, DMin Lead Mentor: Leonard I. Sweet, PhD Copyright 2013 by Christopher Lars Arney All Rights Reserved Unless otherwise indicated, all scripture references are taken from, The Holy Bible: Today's ew International Version . Colorado Springs, Colorado: International Bible Society, copyright 2005. -

Ottobre 1999 - Spedizione in A
Notiziario della Comunità Parrocchiale di Chiari - Ottobre 1999 - Spedizione in a. p. Art. 2 Comma 20/c - Legge 662/96 - F. Bs. L’Angelo Sommario Notiziario della Comunità parrocchiale La parola del parroco di Chiari (Bs) Lo scandalo e la macina 3 N. 8 - Ottobre 1999 Conosci il Centro giovanile2000? 3 Anno IX Siamo in discoteca 5 Registrazione N. 45/91 del 6 settembre 1991 Scuola della Parola di Dio 5 Tribunale di Brescia Scelta pastorale diocesana Edito dalla Parrocchia Gesù Cristo, ieri, oggi e sempre 6 dei Santi Faustino e Giovita Missioni 2000 in Chiari Una parrocchia in missione 8 Cose sbalorditive via Morcelli 7 - Chiari (Brescia) Don Davide, che razza di ignoranti 8 Caro don Davide 9 Direttore Responsabile Pellegrinaggio in Terra Santa 10 Claudio Baroni Primo piano Educarsi alla legalità 12 Redazione AA - Alanon 12 Luciano Cinquini, don Andrea Ferrari, Dottrina sociale della Chiesa Enrica Gobbi Come lievito nella pasta 13 Caritas zonale Hanno collaborato a questo numero In Kosovo 14 Mons. Angelo Zanetti, Bruno Mazzotti, Sil- Oratorio via Fioretti, Luisa Libretti, Roberto Zini, Ma- I colori dell'estate 16 ria Marini, Vittorio Iezzi, Roberto Bedogna, Appunti di un'estate giovani 17 Emanuele Baroni, Caterina Chioda, Fulvio Brasile non è solo Ronaldo 18 Cocciolo, Ida Ambrosiani, Giuseppe Delfrate Ricordi in un'esperienza brasiliana 19 Taizé 19 Montaggio di retro copertina Campo Val Adamé - We can fly 20 Giuseppe Sisinni Il principe Ian e gli scudi di Haria 21 Fotografie di copertina e retro copertina Via alla pole position (Pallavolo) 21 Roberto Mora, Santino Goffi, Paolo Betella Fuori orario riparte 21 Tipografia Giornata missionaria mondiale 22 Tipolitografia Clarense, La Madre dei poveri 24 Nuovi santi di Lussignoli e Ferrari s.n.c. -

The Holy See
The Holy See PASTORAL VISIT TO BRESCIA AND CONCESIO EUCHARISTIC CONCELEBRATION HOMILY OF HIS HOLINESS BENEDICT XVI Paul VI Square - Brescia, Italy Sunday, 8 November 2009 Dear Brothers and Sisters, I have great joy in being able to break the Bread of the Word of God and of the Eucharist with you here, in the heart of the Diocese of Brescia, where the Servant of God Giovanni Battista Montini, Pope Paul VI was born and educated in his youth. I greet you all with affection and thank you for your warm welcome! In particular I thank Bishop Luciano Monari, for his words to me at the beginning of the celebration and with him I greet the Cardinals, Bishops, priests and deacons, the men and women religious and all the pastoral workers. I thank the Mayor for his words and his gift, and the other civil and military Authorities. I address a special thought to the sick who have gathered in the Cathedral. At the heart of the Liturgy of the Word this Sunday the 32nd in Ordinary Time we find the figure of the poor widow or, more precisely, we find her gesture when she dropped her last coins into the collection box of the Temple treasury. Thanks to Jesus' attentive look it has become the proverbial "widow's mite" and indeed is synonymous with the generosity of those who give unsparingly the little they possess. However, I would like first of all to emphasize the importance of the atmosphere in which this Gospel episode takes place, that is, the Temple of Jerusalem, the religious centre of the People of Israel and the heart of its whole life. -

May 1, 2009 Vol
LivingInside the good life Spirit of Service winners know ‘how to live the good life,’ Criterion page 3. Serving the Church in Central and Southern Indiana Since 1960 CriterionOnline.com May 1, 2009 Vol. XLIX, No. 29 75¢ Glendon declines to accept Notre Dame’s prestigious Laetare Medal WASHINGTON (CNS)—Citing concerns about plans to honor President Barack Obama despite his views on “fundamental principles of justice” that are contrary to Catholic teaching, former U.S. Ambassador to the Vatican Mary Ann Glendon has turned down the prestigious Laetare Medal from Mary Ann Glendon the University of Notre Dame. In an April 27 letter to Holy Cross Father John I. Jenkins, Notre Dame’s president, Glendon said she will not participate in May 17 commencement exercises during which the award was to have been presented. The letter, posted on the blog of the magazine First Things, does not mention specific justice principles, but Glendon was Submitted photo critical of Notre Dame’s decision to give Dominican Father Robert Keller, pastor of the St. Paul Catholic Center in Bloomington, baptizes Hillary Brooks, a senior at Indiana University in Obama an honorary degree. Bloomington, during the parish’s Easter Vigil on April 11. Obama supports legal abortion and his administration recently proposed new regulations that would allow the use of federal Relationships bring youths, young adults into the Church funds for embryonic stem-cell research. Both are in direct conflict with fundamental Church By Sean Gallagher of faith with God or is that not really important? Indiana University in Bloomington and is teaching. -
![Lightning Strikes St Peter's Basilica As Pope Resigns 2013 HQ [Video]](https://docslib.b-cdn.net/cover/8902/lightning-strikes-st-peters-basilica-as-pope-resigns-2013-hq-video-3588902.webp)
Lightning Strikes St Peter's Basilica As Pope Resigns 2013 HQ [Video]
Lightning Strikes St Peter's Basilica As Pope Resigns 2013 HQ [Video] http://www.disclose.tv/action/viewvideo/125241/Lightning_Strikes_St_P... Liked this page? Let Google know: ›‹ Like 22k Join 70929 members... | Create Account | Contact | Shop | Login 1 of 10 2/16/2013 9:12 PM Lightning Strikes St Peter's Basilica As Pope Resigns 2013 HQ [Video] http://www.disclose.tv/action/viewvideo/125241/Lightning_Strikes_St_P... You might like: Prophecy In The Amazing UFO Making: The Coming Footage Of A Object Black Pope Transforming Recommended by Disclose.tv Like 22,905 people like Disclose.tv . Facebook social plugin Lightning Strikes St Peter's Basilica as Pope Resigns 2013 HQ 2 of 10 2/16/2013 9:12 PM Lightning Strikes St Peter's Basilica As Pope Resigns 2013 HQ [Video] http://www.disclose.tv/action/viewvideo/125241/Lightning_Strikes_St_P... Like 459 Tweet 7 2 32 [4] 1 2 3 4 5 3 of 10 2/16/2013 9:12 PM Lightning Strikes St Peter's Basilica As Pope Resigns 2013 HQ [Video] http://www.disclose.tv/action/viewvideo/125241/Lightning_Strikes_St_P... PC Cleaner- Free Download Free-PC-Cleaner.sparktrust.com Clean PC, Boost Speed, Fix Errors. Free Download (Highly Recommended!) DestinationUnknown uploaded: Feb 12, 2013 Hits: 5557 Description: Pope Benedict has shocked a billion Roman Catholics around the world, and his closest advisers, by announcing that he will resign at the end of this month. Within hours of Pope Benedict announcing his resignation, lightning struck St Peter's Basilica. The Pope, who is 85 years old, has been the head of the Church since 2005ADG Facebook: http://www.facebook.com/pages/Alien-Disclosure- Group/189249627773146Follow ADG on Twitter: http://twitter.com/ADG_UK Tags: Pope Lightning Benedict Peters Basilica Categories: Other Mysteries 4 of 10 2/16/2013 9:12 PM Lightning Strikes St Peter's Basilica As Pope Resigns 2013 HQ [Video] http://www.disclose.tv/action/viewvideo/125241/Lightning_Strikes_St_P.. -

The Holy See
The Holy See ADDRESS OF HIS HOLINESS JOHN PAUL II TO THE PILGRIMS WHO HAD COME TO ROME FOR THE BEATIFICATION OF NEW BLESSEDS Monday, 4 October 1999 Dear Brothers and Sisters, 1. Yesterday's solemn celebration is in a certain sense continued in our meeting today, at which we would like to renew our song of praise and thanksgiving to the Lord for the new blesseds, whom the Church holds up to us as examples to imitate. With great affection I greet each of you who have come in such numbers to pay homage to these faithful witnesses of the Gospel. In contemplating Fr Ferdinand Mary Baccilieri, a humble and zealous priest, I extend a cordial greeting to the Sisters Servants of Mary of Galeazza, who venerate him as their founder and feel committed to keep his spirit alive and active in their Institute's work. May the spiritual daughters of this new Blessed and all who invoke him as their protector welcome his invitation to reflect constantly on the Christian message and to foster a tender devotion to Our Lady of Sorrows. It is important to understand that following Christ necessarily involves that serious revision of one's life to which he exhorted everyone, especially on the occasion of the parish missions. May the desire to offer each one the clear teaching of the Gospel grow in those who, in following his example, continue his apostolic action to reach families and individual faithful. 2. I cordially greet the brothers and sisters who have come for the beatification of Fr Edward Poppe, especially those from Belgium. -

The Martyrology of the Monastery of the Ascension
The Martyrology of the Monastery of the Ascension Introduction History of Martyrologies The Martyrology is an official liturgical book of the Catholic Church. The official Latin version of the Martyrology contains a short liturgical service the daily reading of the Martyrology’s list of saints for each day. The oldest surviving martyologies are the lists of martyrs and bishops from the fourth-century Roman Church. The martyrology wrongly attributed to St. Jerome was written in Ital in the second half of the fifth century, but all the surviving versions of it come from Gaul. It is a simple martyrology, which lists the name of the saint and the date and place of death of the saint. Historical martyrologies give a brief history of the saints. In the eighth and ninth centuries, St. Bede, Rhabanus Maurus, and Usuard all wrote historical martyrologies. The Roman Martyrology, based primarily on Usuard’s, was first published in 1583, and the edition of 1584 was made normative in the Roman rite by Gregory XIII. The post-Vatican II revision appeared first in 2001. A revision that corrected typographical errors and added 117 people canonized by Pope John Paul II between 2001 and 2004, appeared in 2005.1 The Purpose and Principles of This Martyology The primary purpose of this martyrology is to provide an historically accurate text for liturgical use at the monastery, where each day after noon prayer it is customary to read the martyrology for the following day. Some things in this martyrology are specific to the Monastery of the Ascension: namesdays of the members of the community, anniversaries of members of the community who have died, a few references to specific events or saints of local interest. -
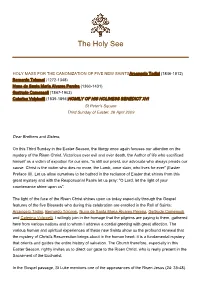
The Holy See
The Holy See HOLY MASS FOR THE CANONIZATION OF FIVE NEW SAINTSArcangelo Tadini (1846-1912) Bernardo Tolomei (1272-1348) Nuno de Santa Maria Alvares Pereira (1360-1431) Gertrude Comensoli (1847-1903) Caterina Volpicelli (1839-1894)HOMILY OF HIS HOLINESS BENEDICT XVI St Peter's Square Third Sunday of Easter, 26 April 2009 Dear Brothers and Sisters, On this Third Sunday in the Easter Season, the liturgy once again focuses our attention on the mystery of the Risen Christ. Victorious over evil and over death, the Author of life who sacrificed himself as a victim of expiation for our sins, "is still our priest, our advocate who always pleads our cause. Christ is the victim who dies no more, the Lamb, once slain, who lives for ever" (Easter Preface III). Let us allow ourselves to be bathed in the radiance of Easter that shines from this great mystery and with the Responsorial Psalm let us pray: "O Lord, let the light of your countenance shine upon us". The light of the face of the Risen Christ shines upon us today especially through the Gospel features of the five Blesseds who during this celebration are enrolled in the Roll of Saints: Arcangelo Tadini, Bernardo Tolomei, Nuno de Santa Maria Álvares Pereira, Geltrude Comensoli and Caterina Volpicelli. I willingly join in the homage that the pilgrims are paying to them, gathered here from various nations and to whom I address a cordial greeting with great affection. The various human and spiritual experiences of these new Saints show us the profound renewal that the mystery of Christ's Resurrection brings about in the human heart; it is a fundamental mystery that orients and guides the entire history of salvation. -

News from Bishop Michael
Page Two July 2010 OUR DIOCESAN FAMILY NEWS FROM BISHOP MICHAEL Second Collections Woodbridge, which has been without a resident priest since A Summer of Celebrations Sunday 11th July (Sea Sunday) The summer in East Anglia is always full of different their parish priest Fr Ivan Rudkin died. celebrations, but there are more than usual this year. Besides APOSTLESHIP OF THE SEA the various Confirmations, Diocesan Pilgrimages, Marriage Two Polish La Salette priests - Fr Edward Tredota and Fr The Apostleship of the Sea is an agency of the Catholic & Family Life Celebration, Clergy Jubilees Mass, etc, we Marek Pabis (both currently in Goodmayes, Ilford, Essex) – Bishops’ Conference of England and Wales. It is both a have also had the opening of the Cathedral Narthex, the will move to St Ives, with Fr Edward as parish priest and Fr mission and welfare outreach of the Church, providing Cathedral Centenary Celebration and Diaconal Ordinations, Marek as his assistant. We are planning ahead for just a few help to all seafarers regardless of colour, creed or and we are looking forward to the Priestly Ordinations on years time when St Ives parish will include a new town – nationality. It works closely with its ecumenical partners. 10th July. All of these should lift our hearts and spirits, and Northstowe – which will eventually be much the same size This mission is a very important but often forgotten give us an even greater sense of being a single diocesan as Huntingdon and Godmanchester combined. Fr Marek is work. family. staying at the Cathedral for a few weeks to begin to get used to our strange ways in East Anglia. -

Father Michael Magiera Blends Experience on Opera Stage with Priestly Ministry
Inside Food for the soul Lenten meals give parents a chance to teach the faith, page 9. Serving the ChurchCriterion in Central and Souther n Indiana Since 1960 CriterionOnline.com Febraury 27, 2009 Vol. XLIX, No. 20 75¢ New leader meets archdiocese he calls ‘snapshot’ of universal Church Photo by Sean Gallagher NEW YORK (CNS)—Calling the diverse New York Archdiocese “a real icon, a snapshot of the Church universal, of the Church in the United States,” Arch - bishop Timothy M. Dolan pledged his life, his heart and his soul to the people of the archdiocese on Feb. 23. Archbishop Pope Benedict XVI Timothy M. Dolan named Archbishop Dolan, head of the Milwaukee Archdiocese since 2002, to succeed the retiring Cardinal Edward M. Egan. He is to be installed as New York archbishop on April 15. At a press Cardinal conference in the Edward M. Egan New York Catholic Priestly Fraternity of St. Peter Father Michael Magiera, associate pastor of Our Lady of the Most Holy Rosary Parish in Indianapolis, celebrates the Center, traditional Latin Mass on Feb. 18 at the parish’s church. Altar server Simon Sheridan, a student at Lumen Christi Sc hool, kneels at left. Archbishop Dolan said, “I can tell you already that I love you. I need so much your prayers and support. I am so honored, humbled and Father Michael Magiera blends experience happy at the prospect of serving as your pastor.” As pastor, he said he has “a sacred mandate on opera stage with priestly ministr y to preach the Gospel of Jesus Christ and ho w the Church transmits his mystery, his ministry By Sean Gallagher he was an international opera singer.