L'umanità Di Don Bosco
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

BRUNO MUNARI, FUTURISMO E OLTRE …. AVVENIMENTI E SCRITTI 1926-1940
BRUNO MUNARI, FUTURISMO E OLTRE …. AVVENIMENTI e SCRITTI 1926-1940 Mostra futurista alla Galleria Pesaro, ogni anno era un grande avvenimento. Le ricorderete tutti, immagino. Dal 1930 al 1935 mi pare, Prampolini a sorpresa, ogni anno ci stupiva con le sue idee. E la famosa cena futurista con un tavolo che si snodava per tutte le sale della galleria. In quel periodo io esposi le mie prime macchine inutili. C'era molto entusiasmo e molta attività: Marinetti al Corso Hotel, riunioni discussioni presentazioni organizzazione di mostre di spettacoli di serate futuriste. Lavoravamo tutti sodo e con accanimento. Marinetti ogni volta ci entusiasmava, ogni volta era una polemica, ogni volta una battaglia. Eravamo allora il gruppo futurista lombardo, aeropittura aeroscultura radiopittura plastici polimaterici, macchine inutili, mandavamo a tutte le esposizioni in Italia in Francia in tutto il mondo. Ma in tutto questo fervore, in mezzo a queste girandole multicolori, il nostro punto di riferimento era Paolo Buzzi. Era il burocrate futurista, era l'uomo apparentemente come tutti gli altri uomini ma animato da un segreto violentissimo fuoco futurista. Le nostre vere vittorie non erano le mostre non erano le discussioni accanite. La nostra vera vittoria era un nostro quadro a Palazzo Monforte. Paolo Buzzi era la nostra quinta colonna, era la testa di ponte che ci permetteva di entrare nella mentalità borghese e di aprire i cervelli al nostro nuovo mondo. Pallido serio e dignitoso, apparentemente immobile ma internamente animatissimo, con milioni di immagini di argomenti di colori di sensazioni, sempre pronto ad animare e ad aiutare i giovani artisti, tu, con la tua amicizia e con la tua poesia ci hai regalato uno dei più bei periodi della nostra vita.1 Una cena futurista. -
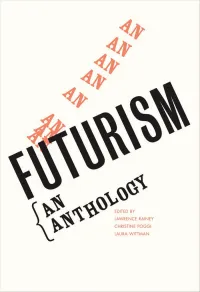
Futurism-Anthology.Pdf
FUTURISM FUTURISM AN ANTHOLOGY Edited by Lawrence Rainey Christine Poggi Laura Wittman Yale University Press New Haven & London Disclaimer: Some images in the printed version of this book are not available for inclusion in the eBook. Published with assistance from the Kingsley Trust Association Publication Fund established by the Scroll and Key Society of Yale College. Frontispiece on page ii is a detail of fig. 35. Copyright © 2009 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced, in whole or in part, including illustrations, in any form (beyond that copying permitted by Sections 107 and 108 of the U.S. Copyright Law and except by reviewers for the public press), without written permission from the publishers. Designed by Nancy Ovedovitz and set in Scala type by Tseng Information Systems, Inc. Printed in the United States of America by Sheridan Books. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Futurism : an anthology / edited by Lawrence Rainey, Christine Poggi, and Laura Wittman. p. cm. Includes bibliographical references and index. ISBN 978-0-300-08875-5 (cloth : alk. paper) 1. Futurism (Art) 2. Futurism (Literary movement) 3. Arts, Modern—20th century. I. Rainey, Lawrence S. II. Poggi, Christine, 1953– III. Wittman, Laura. NX456.5.F8F87 2009 700'.4114—dc22 2009007811 A catalogue record for this book is available from the British Library. This paper meets the requirements of ANSI/NISO Z39.48–1992 (Permanence of Paper). 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 CONTENTS Acknowledgments xiii Introduction: F. T. Marinetti and the Development of Futurism Lawrence Rainey 1 Part One Manifestos and Theoretical Writings Introduction to Part One Lawrence Rainey 43 The Founding and Manifesto of Futurism (1909) F. -

Futurismo: L'arte Degli Stati D'animo
CCoonnffiinnii Web-magazine di prospezione sul futuro Raccolta n. 47 Idee & oltre Settembre 2016 FUTURISMO: L’ARTE DEGLI STATI D’ANIMO www.confini.org Confini Webmagazine di prospezione sul futuro Organo dell’Associazione Culturale “Confini” Raccolta n. 47 - Settembre 2016 Anno XVIII + Direttore e fondatore: Angelo Romano + Condirettori: Massimo Sergenti - Cristofaro Sola + Hanno collaborato: Gianni Falcone I Futuristi + Segreteria: [email protected] [email protected] RISO AMARO 1 Referendum: il sogno americano Per gentile concessione di Gianni Falcone 2 EDITORIALE AI LETTORI Prosegue la carrellata sul Movimento Futurista. Dopo i principali manifesti, pubblicati lo scorso mese, è la volta di documenti meno noti ma non meno significativi. Essi vanno contestualizzati nel clima culturale in cui furono concepiti. Abbiamo voluto dedicare questo omaggio al Futurismo, nell’auspicio che possa nascere in Italia una destra “futurista”, proiettata verso il domani, concentrata sul futuro della nazione, capace di generare cultura, di recuperare il senso della prospettiva di lungo periodo, di rompere con gli schemi del “politicamente corretto” e con la ricerca a tutti i costi del “consenso moderato”, di coltivare un rapporto privilegiato con la scienza e le tecnologie, di non avere tabù o complessi, di essere “rivoluzionaria”, perché capace di concepire un Orizzonte e di tracciare una rotta per raggiungerlo. Dal prossimo mese ritorneremo a presidiare i confini tra il noto e l’ignoto. MONOGRAFIA/IL FUTURISMO 3 Filippo Tommaso Marinetti UCCIDIAMO IL CHIARO DI LUNA! 1. Olà! grandi poeti incendiarî, fratelli miei futuristi!.... Olà! Paolo Buzzi, Palazzeschi, Cavacchioli, Govoni, Altomare, Folgore, Boccioni, Carrà, Russolo, Balla, Severini, Pratella, D'Alba, Mazza! Usciamo da Paralisi, devastiamo Podagra e stendiamo il gran Binario militare sui fianchi del Gorisankar, vetta del mondo! Uscivamo tutti dalla città, con un passo agile e preciso, che sembrava volesse danzare cercando ovunque ostacoli da superare. -

Export / Import: the Promotion of Contemporary Italian Art in the United States, 1935–1969
City University of New York (CUNY) CUNY Academic Works All Dissertations, Theses, and Capstone Projects Dissertations, Theses, and Capstone Projects 2-2016 Export / Import: The Promotion of Contemporary Italian Art in the United States, 1935–1969 Raffaele Bedarida Graduate Center, City University of New York How does access to this work benefit ou?y Let us know! More information about this work at: https://academicworks.cuny.edu/gc_etds/736 Discover additional works at: https://academicworks.cuny.edu This work is made publicly available by the City University of New York (CUNY). Contact: [email protected] EXPORT / IMPORT: THE PROMOTION OF CONTEMPORARY ITALIAN ART IN THE UNITED STATES, 1935-1969 by RAFFAELE BEDARIDA A dissertation submitted to the Graduate Faculty in Art History in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy, The City University of New York 2016 © 2016 RAFFAELE BEDARIDA All Rights Reserved ii This manuscript has been read and accepted for the Graduate Faculty in Art History in satisfaction of the Dissertation requirement for the degree of Doctor of Philosophy ___________________________________________________________ Date Professor Emily Braun Chair of Examining Committee ___________________________________________________________ Date Professor Rachel Kousser Executive Officer ________________________________ Professor Romy Golan ________________________________ Professor Antonella Pelizzari ________________________________ Professor Lucia Re THE CITY UNIVERSITY OF NEW YORK iii ABSTRACT EXPORT / IMPORT: THE PROMOTION OF CONTEMPORARY ITALIAN ART IN THE UNITED STATES, 1935-1969 by Raffaele Bedarida Advisor: Professor Emily Braun Export / Import examines the exportation of contemporary Italian art to the United States from 1935 to 1969 and how it refashioned Italian national identity in the process. -

Marisa Mori, Le Futuriste E Il Volo
Nonostante la componente misogina di un mo- vimento che già nel manifesto di esordio del 1909 dichiarava di voler glorificare il «disprezzo della donna» e di voler «combattere contro […] il femminismo», il drappello delle artiste che aderirono al Futurismo fu assai nutrito e si infittì man mano con il passare degli anni coprendo capillarmente, con la sua presenza, l’intero ter- ritorio nazionale. Al di là di queste asserzioni provocatorie, più che altro eredi di una cultura patriarcale che collocava la figura femmine in Chiara Toti una sfera sentimental-romantica, a cui si oppo- neva, di contro, l’esaltazione della violenza e della guerra, le donne del Futurismo rimasero Marisa Mori, le futuriste e il volo infatti attratte da altre prerogative del movimen- to: così il vitalismo e l’impulso al rinnovamento fotografie archivio privato, Firenze propugnati da Marinetti vennero letti come un’opportunità di riscatto della condizione fem- Chiara Toti ha incentrato i suoi studi sull’arte della prima metà del Novecento, con minile, uno slancio verso l’emancipazione e la li- particolare attenzione al collezionismo e alle tematiche al femminile. Ha curato numerose bertà. Da parte sua Marinetti intravide presto mostre, il catalogo generale di Primo Conti e l’inventario dell’archivio cartaceo del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Si è occupata di didattica dell’arte, prima presso il Polo l’enorme potenziale rappresentato dalle futuri- Museale fiorentino, poi presso la Fondazione Ragghianti con la quale collabora dal 2008. ste nella crescita e nella diffusione del movi- mento, mostrandosi dunque sempre più dispo- nibile ad accoglierle e a lodarne il lavoro. -

Futurismo : 1909-1944 / Claudia Salaris
1895 Lucini, Gian Pietro Gian Pietro da Core / G.P. Lucini. - Milano : Galli, 1895. - XII, 261 p., [1] c. di tav. ; 19 cm. Prima del tit.: Storia della evoluzione della idea. 1900 Buzzi, Paolo Il miracolo della parete : commedia in due sintesi in versi / Paolo Buzzi. - Milano : Associazione di propaganda per il risparmio e la previdenza, [1900?] [19--?]. - 47 p. ; 18 cm. Cappa, Innocenzo Pagine staccate / Innocenzo Cappa ; raccolte da Terenzio Grandi ; con una lettera dell'autore e una nota biografica. - Bari : Humanitas, [1900?] [19--?]. - 329 p., [ritr.] ; 21 cm. Lucini, Gian Pietro Filosofi ultimi : rassegna a volo d'aquila del Melibeo controllata da G.P. Lucini : contributo ad una storia della filosofia contemporanea / Gian Pietro Lucini. - Roma : Libreria politica moderna, [1900?] [19--?]. - VIII, 243 p. ; 21 cm. - (Arte, scienza, filosofia / [Libreria politica moderna] ; 1). Lucini, Gian Pietro Poesie scelte / G.P. Lucini. - Milano : ISEDI, [1900?] [19--?]. - 207 p. ; 10 cm. - (Raccolta di breviari intellettuali ; 72). Mallarmé, Stéphane Versi e prose / Mallarmé ; prima traduzione italiana di F.T. Marinetti. - Milano : Istituto Editoriale Italiano, [1900?] [19--?]. - 173 p. ; 10 cm. - (Raccolta di breviari intellettuali ; 24). Poe, Edgar Allan Racconti straordinari / Edgardo Poe ; traduzione di Decio Cinti ; illustrazioni di Arnaldo Ginna. - Milano : Facchi, [1900?] [19--?]. - 268 p. : ill. ; 24 cm. Pratella, Francesco Balilla Un prologo all'opera in due atti per il teatro dei fanciulli La ninna nanna della bambola / F. Balilla Pratella. - Ravenna : STEM, [1900?] [19--?]. - 14 p. ; 19 cm. Dati della cop. 1903 Govoni, Corrado Le fiale / Corrado Govoni. - Firenze : Lumachi, 1903. - 223 p. ; 25 cm. Marinetti, Filippo Tommaso Gabriele D'Annunzio intime / F. -

Marinetti La Cucina Futurista
Raccolta di testi per la storia della gastronomia digitalizzati e restaurati da Edoardo Mori 2018 ** F. T. Marinetti La Cucina Futurista Contrariamente alle critiche lanciate e a quelle prevedibili, la rivoluzione cu cinaria futurista, illustrata in questo volume, si propone lo scopo alto, no bile ed utile a tutti di modificare radi calmente l’ alimentazione della nostra razza, fortificandola, dinamizzandola e spiritualizzandola con nuovissime vi vande in cui l’esperienza, l’ intelli genza e la fantasia sostituiscano eco nomicamente la quantità, la banalità, la ripetizione e il costo. Questa nostra cucina futurista, regolata come il motore di un idrovolante per alte velocità, sembrerà ad alcuni tre mebondi passatisti pazzesca e perico losa: essa invece vuole finalm ente creare un’ armonia tra il palato degli uomini e la loro vita di oggi e di domani. x Salvo le eccezioni decantate e leggen darie, gli uomini si sono nutriti finora come le formiche, i topi, i gatti e i buoi. [5] Nasce con noi futuristi la prima cucina umana, cioè l’arte di alimentarsi. Come tutte le arti, essa esclude il plagio ed esige l’ originalità creativa. Non a caso questa opera viene pub blicata nella crisi economica mondiale di cui appare imprecisabile lo sviluppo, ma precisabile il pericoloso pànico de primente. A questo pànico noi oppo niamo una cucina futurista, cioè : l’otti mismo a tavola. ' [6] un pranzo che evitò un suicidio L ’ 11 Maggio 1930 il poeta Marinetti partiva per il Lago Trasimeno in automobile, obbe dendo a questo preoccupante, strambo e miste rioso telegramma: <( Carissimo poiché Essa partì definitivamente sono preso da angoscia torturante Stop tristezza immensa vietami sopravivere Stop supplicoti ve nire subito prima che arrivi quella che le ras somiglia troppo ma non abbastanza GIULIO ». -

Catalogo 66 – Seconda Parte
Libreria Le Colonne Catalogo 66 – Seconda parte n. 118bis – RUBINO Antonio - INCANTESIMO 1. (Agricoltura - Allevamento) GAMBA Aiace, Veterinario Comunale. RELAZIONE della MOSTRA ZOOTECNICA del 24 Marzo 1908 in CHIUSDINO (Siena). Consorzio Agrario Cooperativo di Chiusdino. Siena, Tipografia Cooperativa, 1908. In-8°, pp. 6. Bross. edit. Cifre a lapis e timbro illeggibile in cop. Strappetto senza perdite al piatto posteriore. € 10 2. (Alpi - Cartografia) Anonimo. LA MOTTE - AUZET / SISTERON - DIGNES / SEYNE - ALLOS / LA JAVIE - COLMAR / ST. ETIENNE. S. ANNA di VINADIO - GUILLAUME – St. SAUVEUR. Grandissima carta topografica di tipo militare di cm. 196,4 x 167,2 perfettamente TELATA e in ottime condizioni, divisa in rettangoli di cm. 20,8x16,4 editorialmente applicata alla tela grigia, e ripiegata a formare un oggetto di cm. 21x 16,5 x 2 di spessore. Impressa in bianco e nero, con bella evidenza dei rilievi, corsi d'acqua e laghi in azzurro, confine nazionale in rosso-viola, reticolo grande in nero con indicaz. dei gradi a margine reticolo più piccolo in rosso. Parrebbe in scala 1:50.000 (cioè un cm. sulla carta equivale a 500 metri nella realtà). € 60 3. (Alpinismo - Avventura - Illustrati) VERNE Giulio. Il capitano della "Giovane ardita". Un'ASCENSIONE al MONTE BIANCO. Inoltre: 2) RACCONTI FANTASTICI (Un capriccio del Dottor Oss, Mastro Zaccaria, Un dramma in aria). 3) MARTINO PAZ + Un episodio del TERRORE. 4) VIAGGIO AL CENTRO DELLA TERRA. Unica traduzione autorizzata dall'autore. Milano, Soc. Ed. Sonzogno, 1911. 4 opere rilegate in un volume in-8° (cm. 25,3x18,6), mz. tela muta coeva, carta decorata ai piatti. 1) pp. -

Maqueta Def. Nueva
http://doi.org/10.7203/arslonga.29.17102 L MITO AÉREO EN EL FUTURISMO ITALIANO: DEL PERIODO HEROICO A LA ESPIRITUALIDAD E AÉREA (1909-1944) JUAN AGUSTÍN MANCEBO ROCA Universidad de Castilla-La Mancha [email protected] Resumen: La poética de lo aéreo atravesó transversalmente la historia del futurismo italiano. El undécimo punto de su manifiesto y fundación en 1909, hizo referencia al aeroplano como una máquina esencial para comprender que la vida y el arte se debían someter a un mundo en permanente transformación. Lo aéreo y sus implicaciones compusieron proclamas y manifiestos determinando la creación literaria y artística del pe- riodo heroico. En los años treinta, cuando el futurismo planteaba su supervivencia en el complejo contexto social y político italiano, la aeropintura se convirtió en su línea oficial. Un perfil que, desde ese mismo mo- mento, se bifurcó en dos tendencias complementarias: la dedicada a una praxis orgánica de las variables de la mirada aérea y la de una política representacional que superaba lo aéreo para penetrar en lo trascendente. Con la desaparición de las líneas de identificación entre estética y política, la temática aérea adquirió el rol de pro- paganda del régimen, celebración de la guerra-fiesta, que recuperaba el discurso intervencionista de la Primera Guerra Mundial y que, tras un periodo de manifestaciones de escaso valor plástico, concluyó abruptamente con el deceso del futurismo que coincidió con el nuevo ciclo histórico que se inició en Italia. Palabras clave: Futurismo / aeropintura / fascismo / espiritualidad / aérea / política. THE AERIAL MYTH OF ITALIAN FUTURISM: FROM THE HEROIC PERIOD TO THE AERIAL SPIRITUALITY (1909-1944) Abstract: The poetics of the aerial went through the history of Italian futurism. -

Unveiling This Year's Significant Exhibitions, Highlights and Themes
Press Release Unveiling This Year’s Significant Exhibitions, Highlights and Themes London Art Week Summer 2018 29 June to 6 July 2018, Opening Night 28 June London Art Week Summer 2018, which opens on the evening of Thursday 28 June and runs through Friday 6 July with a new Late Night Opening on Tuesday 3 July, marks one of the most important weeks in the UK’s art market calendar. Notable exhibitions by some 40 pre-eminent art dealers, major Old Master sales at the auction houses and a raft of events attract collectors, connoisseurs and museum curators to the capital, underlining the central role that London plays in the international art world. London Art Week Summer 2018 Participants will be unveiling important works and staging exhibitions which Preview & Opening Night: demonstrate the unrivalled connoisseurship and expertise to be found in St. Thursday 28 June, 3pm-8pm James’s and Mayfair, traditional home to the finest art and art dealerships for Friday 29 June, 10am-6pm more than 250 years. Some dealer exhibitions have been years in the Saturday 30 June, 10am-5pm making, others are the first of their kind for decades. Sunday 1 July, 10am-5pm Monday 2 July, 10am-6pm Late Night New discoveries, works appearing on the market for the first time in many Tuesday 3 July, 10am-9pm generations, and great rarities are to be found. Here we outline the variety Wednesday 4 July, 10am-6pm of academic and celebratory exhibitions, share significant works of art on Thursday 5 July, 10am-6pm display, and offer a number of feature ideas and themes. -

Da Editori a PADRONI
LIBRI DEL MESE Da editori a PADRONI La messinscena di Ground Zero LEARCO/NORI a stile libero In PATAGONIA Nuovi fiori del male senza Chatwin Troppo buoni gli Americani Animali che si fanno le corna Sylvia Plath: pane, latte, e suicidio Vinci, Evangelisti, Santojanni, Pound, Nothomb MENSILE D'INFORMAZIONE - SPED. IN ABB. POST. COMMA 20/b ART. 2, LEGGE 662/96 - ROMA - ISSN 0393-3903 N. 4 EditoriA gardére è un conglomerato industriale che ha interes- Utet: un vergognoso silenzio Monopolio alla francese si nell'aeronautica, nella missilistica, nell'industria spaziale e automobilistica. Ne consegue che "quando di Carlo Carlucci di Andrea Bosco il libro alimenta l'insieme delle attività di comunica- zione (televisione, cinema, internet...) i diritti deriva- 'aria condizionata fa bene? Non sempre. E l'edi- ti esercitano un loro peso sulla decisione di pubblica- ono stato relatore al congresso internazionale di L toria condizionata? Mai, almeno in Francia, se- re". Risultato della situazione: un'uniformazione pro- Slessicografia tenutosi a Torino il novembre scorso condo il parere di Jeanine e Greg Bremond, fondato- gettuale del libro. Molti libri pubblicati si assomiglia- in occasione della chiusura del grande Dizionario Utet ri delle Editions Liris. Il loro libro Editoria condizio- no o presentano un contenuto strutturato secondo la della lingua Italiana, universalmente conosciuto come nata affronta il tema della concorrenza nel mercato li- stessa articolazione, o si ispirano a un concetto già svi- il Battaglia, ma che sarebbe più giusto chiamare Bat- brario francese, dove la concentrazione è molto forte. luppato da libri preesistenti. I responsabili editoriali taglia-Barberi posto che il professor Barberi Squarot- Vi si racconta come tale fenomeno sia iniziato negli vedono così scemare la loro influenza rispetto ai re- ti, impegnato per quarantacinque anni, ha portato anni ottanta per arrivare a oggi, in cui due grandi sponsabili del marketing. -

Women Futurists and Parole in Libertà 1914-1924
Between Word and Image: Women Futurists and Parole in Libertà 1914-1924 By Janaya Sandra Lasker-Ferretti A dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Italian Studies in the Graduate Division of the University of California, Berkeley Committee in charge: Professor Barbara Spackman, Chair Professor Albert R. Ascoli Professor Harsha Ram Professor Alessia Ricciardi Spring 2012 Between Word and Image: Women Futurists and Parole in Libertà 1914-1924 © 2012 by Janaya Sandra Lasker-Ferretti Abstract Between Word and Image: Women Futurists and Parole in Libertà 1914-1924 by Janaya Sandra Lasker-Ferretti Doctor of Philosophy in Italian Studies University of California, Berkeley Professor Barbara Spackman, Chair After F.T. Marinetti, the leader of futurism, theorized parole in libertà (or “words-in- freedom”) in his manifestoes, numerous futurists participated in this verbo-visual practice. Although paroliberismo was a characteristic form of expression that dominated futurist poetics preceding, during, and after World War I, little scholarly work has been done on the “words-in- freedom” authored by women and how they might differ from those created by their male counterparts. Women, outcast as they were by futurism both in theory and often in practice, participated nevertheless in the avant-garde movement known for announcing its “disdain for women” in its “Founding Manifesto” of 1909. This dissertation takes an interdisciplinary approach to analyzing the position of the female futurist and her mixed-media contributions during the years in which paroliberismo was carried out in futurist circles. I examine rare and under-studied verbo-visual works done by women between 1914 and 1924.