Matteo Bandello
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Historical Context Elizabethantheatres
Historical Context The first Elizabethan playhouse was an open air theatre built in 1567 by James Burbage called “The Theatre”. After it’s success other playhouses were built : in 1577 “The Courtain”, in 1587 “The Rose”, and in 1595 “The Swan”. In 1599 the Lord Chamberlain’s Man rebuilt “The Globe” which became the most important centre of performances. Elizabethan Theatres Performances took place during the afternoon and were acted only by man and boys. The audiences were made by all sorts of people, reach and poor who had stand on the ground, theatres were designed as large wooden structures, circular or octagonal in shape, with three tiers of galleries surrounding a yard open to the sky. The stage was roofed and was very high, and there were railings between the yard and the lower gallery. There was no scenery and the audience had to image the scene by listening to the language of the actors. There was no courtain and no intervals, so they were very quick. The platform stage was pushed out into the audience who stood around in three sides. This create assends of close intimacy between actors and audiences. Context Romeo and Juliet is one of the most famous plays written by William Shakespeare (1564-1616). When it first appeared on the stage probably in 1595 it was a very popular tale in Elizabethan times, and many versions were available. The sources of the play are Arthur Brooke’s poem “The Tragical Historye of Romeus and Juliet” (1562) which was a translation from the French Matteo Bandello’s novella “Romeo e Giulietta” (1554). -
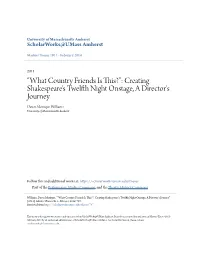
Creating Shakespeare's Twelfth Night Onstage, a Director's Journey
University of Massachusetts Amherst ScholarWorks@UMass Amherst Masters Theses 1911 - February 2014 2011 “What Country Friends Is This?”: Creating Shakespeare’s Twelfth iN ght Onstage, A Director's Journey Dawn Monique Williams University of Massachusetts Amherst Follow this and additional works at: https://scholarworks.umass.edu/theses Part of the Performance Studies Commons, and the Theatre History Commons Williams, Dawn Monique, "“What Country Friends Is This?”: Creating Shakespeare’s Twelfth iN ght Onstage, A Director's Journey" (2011). Masters Theses 1911 - February 2014. 737. Retrieved from https://scholarworks.umass.edu/theses/737 This thesis is brought to you for free and open access by ScholarWorks@UMass Amherst. It has been accepted for inclusion in Masters Theses 1911 - February 2014 by an authorized administrator of ScholarWorks@UMass Amherst. For more information, please contact [email protected]. “WHAT COUNTRY FRIENDS IS THIS?”: CREATING SHAKESPEARE’S TWELFTH NIGHT ONSTAGE A DIRECTOR’S JOURNEY A Thesis Presented by DAWN MONIQUE WILLIAMS Submitted to the Graduate School of the University of Massachusetts Amherst in partial fulfillment of the requirements for the degree of MASTER OF FINE ARTS September 2011 Department of Theater © Copyright by Dawn Monique Williams 2011 All Rights Reserved “WHAT COUNTRY FRIENDS IS THIS?”: CREATING SHAKESPEARE’S TWELFTH NIGHT ONSTAGE A DIRECTOR’S JOURNEY A Thesis Presented by DAWN MONIQUE WILLIAMS Approved as to style and content by: _______________________________________ Gilbert McCauley, Chair _______________________________________ Marcus Gardley, Member _______________________________________ Gina Kaufmann, Member ____________________________________ Penny Remsen, Department Head Department of Theater DEDICATION Just like the river, Jordyn, the girl of my dreams, Manifests my God. -

Proposed Core Literature Titles Twelfth Night, Or, What You Will
Proposed Core Literature Titles The following summary is provided by the California Department of Education’s “Recommended Literature List”, and the top three Google searches of the book title and author name that produced a description of the title. Twelfth Night, or, What You Will Proposed Grade Level: 8 Title: Twelfth Night, or, What You Will Author: William Shakespeare First Published: 2002 Lexile Level: 1140 Proposed Grade Level: 8 California Department of Education, Recommended Literature List: https://www.cde.ca.gov/ci/cr/rl/ This title is on the CDE Recommended Literature List. Annotation: On the island of Illyria, Duke Orsino pines away for the love of the beautiful, but unapproachable Olivia. A tempest occurs that brings Viola and Sebastian to the shores, and a renewed pursuing of affection begins among the island's inhabitants. (Circa 1600.) Copyright: 1992: Original Copyright: 1600 Grade Level Span: 9-12 Genre: Drama Classification: Classic Topic: English-Language Arts/General Discipline: English Language Arts/Vocabulary; Visual and Performing Arts Descriptions From Top 3 Google Searches: Search: "Twelfth Night or What You Will" by William Shakespeare https://en.wikipedia.org/wiki/Twelfth_Night Viola is shipwrecked on the coast of Illyria and she comes ashore with the help of a Captain. She has lost contact with her twin brother, Sebastian, whom she believes to be drowned, and with the aid of the Captain, she disguises herself as a young man under the name Cesario and enters the service of Duke Orsino. Duke Orsino has convinced himself that he is in love with Olivia, who is mourning the recent deaths of her father and brother. -

Matteo Bandello : Twelve Stories
ZZI DATE DUE /' ck^Jpon i DueBs (TOCCHI I Thtariì livereitv / 1 1 ! PRINTED IN USA Cornell University Library The original of this book is in the Cornell University Library. There are no known copyright restrictions in the United States on the use of the text. http://archive.org/details/cu31924102029083 In compliance with current Copyright law, Cornell University Library produced this replacement volume on paper that meets the ANSI Standard Z39.48-1992 to replace the irreparably deteriorated original. 2006 CORNELL UNIVERSITY LIBRARY BOUGHT WITH THE INCOME OF THE 'SAGE ENDOWMENT FUND GIVEN IN 1 89 1 BY HENRY WILLIAMS SAGE (NJDFSLLI8RI ITALIANI MATTEO BANDELLO Novellieri Italiani MATTEO BANDELLO TWELVE STORIES SELECTED AND DONE INTO ENGLISH WITH A MEMOIR OF THE AUTHOR BY PERCY PINKERTON LONDON JOHN C. NIMMO 14, KING WILLIAM STREET, STRAND MDCCCXCV L o CONTENTS How Don Diego, being scorned by his mistress, takes up his abode in a grotto, and how he comes out again I An avaricious priest is nicely cheated by certain good fellows, who rob him of afat sheep . -55 Gerardo secretly weds his mistress and sets out for Baruti. The girtsfather wouldgive her in mar- riage; she swoons with grief, and is buriedfor dead. That selfsame day her true husband returns, and, taking herforth from the tomb, discovers that she is not deadj whereupon he tends her, and formally celebrates his nuptials with her .... 67 How Signor Didaco Centiglia, having wedded a damsel, grows weary of her, and how at her hands he meets his death 117 Of the divers mischances and grievous perils which befell Cornelio for the love of his lady . -

Shakespeare Trivia Anthology Canadian Adaptations of Shakespeare Project (CASP) Shakespeare Learning Commons
1 Shakespeare Trivia Anthology Canadian Adaptations of Shakespeare Project (CASP) Shakespeare Learning Commons FACT 1. Shakespeare is thought to have been born on April 23, 1564 and to have died the same day 52 years later. 2. During his lifetime, John Shakespeare (William’s father) did all of these jobs: glove maker, wool-dealer, moneylender, constable, chamberlain, alderman, bailiff, and justice of the peace. 3. Many of Shakespeare’s early sonnets are likely to have been written to another man: Henry Wriothesley, the 3rd Earl of Southampton. 4. In his will, Shakespeare left his wife Anne Hathaway his “second best bed with the furniture.” Second-best bed was not as bad as it sounds because the best bed was reserved for guests. 5. The open-air theatres that Shakespeare’s plays were first performed in were designed in the same style as the bear-baiting gardens (circular buildings with an open roof and a pit in the centre for the bear or the theatre audience). 6. A Google search for “Shakespeare” returns over 119 million hits. That’s more than Michael Jackson (42 million), Avril Lavigne (29 million) and Tiger Woods (21 million) combined. 7. Shakespeare invented over 1700 commonly used words in English (like “madcap,” “obscene,” “puking,” “outbreak,” “watchdog,” “addiction,” “cold-blooded,” “secure,” and “torture”). 8. Shakespeare’s plays have a vocabulary of some 17,000 words, four times what a well-educated English speaker would have. Shakespeare used 29,066 different words out of 884,647 words in all. 9. Shakespeare was so skilled with words that he used 7000 words only once––more than occur in the whole of the King James Bible. -

Malcontented Agents : from the Novellas to Much Ado About Nothing and the Duchess of Malfi Nigri, L 10.80/0895769X.2018.1462689
Malcontented agents : from the novellas to Much Ado about Nothing and The Duchess of Malfi Nigri, L 10.80/0895769X.2018.1462689 Title Malcontented agents : from the novellas to Much Ado about Nothing and The Duchess of Malfi Authors Nigri, L Type Article URL This version is available at: http://usir.salford.ac.uk/id/eprint/46784/ Published Date 2018 USIR is a digital collection of the research output of the University of Salford. Where copyright permits, full text material held in the repository is made freely available online and can be read, downloaded and copied for non-commercial private study or research purposes. Please check the manuscript for any further copyright restrictions. For more information, including our policy and submission procedure, please contact the Repository Team at: [email protected]. 1 Malcontented Agents: from the novellas to Much Ado about Nothing and The Duchess of Malfi. Shakespeare’s Much Ado about Nothing (c.1598) and Webster’s The Duchess of Malfi (c. 1613) are two plays in which Matteo Bandello’s portrayal of evil agents in his novellas exert a constant, even if not immediately obvious, influence. Remote from each other chronologically and generically, Shakespeare’s comedy and Webster’s tragedy make common use of a distinctive character-type, which has an equivalent in the Bandello source: the melancholy, embittered, and vindictive outsider known at the time, as well as by modern critics, as the malcontent (Nigri, The Origin of Malcontent). Comparing how and to what purpose each dramatist duplicated, altered or expanded the figures he found in the source story provides an insight into his way of working and informs our understanding of the plays. -

William Shakespeare Twelfth Night
CC – 2 Unit - IV William Shakespeare Twelfth Night Prepared By: Dr. Md Naushad Alam Assistant Professor MMHAPU 1 William Shakespeare William Shakespeare was a renowned English poet, playwright, and actor born in 1564 in Stratford-upon-Avon. His birthday is most commonly celebrated on 23 April, which is also believed to be the date he died in 1616. Shakespeare was a prolific writer during the Elizabethan and Jacobean ages of British theatre (sometimes called the English Renaissance or the Early Modern Period). Shakespeare’s plays are perhaps his most enduring legacy, but they are not all he wrote. Shakespeare’s poems also remain popular to this day. Records survive relating to William Shakespeare’s family that offer an understanding of the context of Shakespeare's early life and the lives of his family members. John Shakespeare married Mary Arden, and together they had eight children. John and Mary lost two daughters as infants, so William became their eldest child. John Shakespeare worked as a glove-maker, but he also became an important figure in the town of Stratford by fulfilling civic positions. His elevated status meant that he was even more likely to have sent his children, including William, to the local grammar school. William Shakespeare would have lived with his family in their house on Henley Street until he turned eighteen. When he was eighteen, Shakespeare married Anne Hathaway, who was twenty- six. It was a rushed marriage because Anne was already pregnant at the time of the ceremony. Together they had three children. Their first daughter, Susanna, was born six months after the wedding and was 2 later followed by twins Hamnet and Judith. -

Twelfth Night
Plays and Pinot: Twelfth Night Synopsis Twelfth Night, or What You Will is a romantic comedy by William Shakespeare, believed to have been written around 1601–1602 as a Twelfth Night's entertainment for the close of the Christmas season. The play centres on the twins Viola and Sebastian, who are separated in a shipwreck. Viola (who is disguised as Cesario) falls in love with Duke Orsino, who in turn is in love with Countess Olivia. Upon meeting Viola, Countess Olivia falls in love with her thinking she is a man. The play expanded on the musical interludes and riotous disorder expected of the occasion, with plot elements drawn from the short story "Of Apollonius and Silla" by Barnabe Rich, based on a story by Matteo Bandello. The first recorded public performance was on 2 February 1602, at Candlemas, the formal end of Christmastide in the year's calendar. The play was not published until its inclusion in the 1623 First Folio. About the Playwright William Shakespeare (also spelled Shakspere) was born in 1564 in Stratford-upon-Avon and died April 23 1616. He was an English poet, dramatist, and actor often called the English national poet and considered by many to be the greatest dramatist of all time. Shakespeare occupies a position unique in world literature. Other poets, such as Homer and Dante, and novelists, such as Leo Tolstoy and Charles Dickens, have transcended national barriers, but no writer’s living reputation can compare to that of Shakespeare, whose plays, written in the late 16th and early 17th centuries for a small repertory theatre, are now performed and read more often and in more countries than ever before. -

Classic Repertory Company STUDY GUIDE William Shakespeare’S ROMEO and JULIET
classic repertory company STUDY GUIDE William Shakespeare’s ROMEO AND JULIET Education Outreach Supporters Funded in part by generous individual contributors, the National Endowment for the Arts, Massachusetts Cultural Council, Foundation for MetroWest, Esther B. Kahn Foundation, Fuller Foundation, The Marshall Home Fund, Peter Fuller Car Rentals, Roy A. Hunt Foundation, and Watertown Community Foundation. This program is also supported in part by grants from the Andover Cultural Council, Framingham Cultural Council, Hudson Cultural Council, Hull Cultural Council, Saugus Cultural Council, Waltham Cultural Council, Watertown Cultural Council, and Westford Cultural Council, local agencies which are supported by the Massachusetts Cultural Council, a state agency. NEW REP ADMINISTRATIVE OFFICE 400 TALCOTT AVENUE | BUILDING 131, 3RD FLOOR WATERTOWN, MA 02472 in residence at the artistic director michael j. bobbitt mosesian center for the arts A Timeline of Shakespeare’s Life 1564 Born in Stratford-upon-Avon 1582 Marries Anne Hathaway 1585 Moves to London to pursue theatre career 1592 London closes theatres due to plague 1593 Starts to write sonnets 1594 Publishes first works of poetry 1594 Starts managing, as well as writing for, the Lord Chamberlain’s Men 1596 Romeo and Juliet first performed 1599 Lord Chamberlain’s Men begin performing at the newly built Globe Theater 1603 The Lord Chamberlain’s Men is renamed the King’s Men in honor of the new King James’ patronage 1604 Retires from acting 1613 The Globe Theatre burns down 1614 The Globe Theatre is rebuilt 1616 Dies and is buried at Holy Trinity Church NATIONAL PORTRAIT GALLERY, LONDON PORTRAIT GALLERY, NATIONAL in Stratford-Upon-Avon C.1600 JOHN TAYLOR THE CHANDOS PORTRAIT, adapted from http://absoluteshakespeare.com/trivia/timeline.htm Biography William Shakespeare was born in Stratford-upon-Avon in 1564. -

Matteo Bandello, O, Vita Italiana in Un Novelliere Del Cinquecento
. ''^n, ^r\;if '':-\*^ 'NààL ,&* •^ ,*?\ ^/ -'^^?^. ^ ,f'vrrif-'(.K,^.|:1 "^^sÉm..^ ,* . J' ki Rnr .nH "''^'K'K^' ^„.^^^, t7<:^^ Vì.^'). sSis^^S^^ •Ti- - vi li Proprietà letteraria. ERNESTO MASI MATTEO RANDELLO VITA ITALIANA IN UN NOVELLIERE DEL CINQUECENTO BOLOGNA DITTA NICOLA ZANI iqOO. -^j\viCtS RùIL^^^l^^.^ CAPITOLO I Dal Boccaccio al Bandello. Di tutta la varia e vasta opera letteraria del Boccaccio quella che diede frutti più numerosi e più duraturi fu, scrive il Symonds, il Decamerone ('). Di fatto, se durante il secolo XV i novellatori non furono numerosissimi, perchè ad altro, com'è noto, era principalmente rivolta ogni attività letteraria, non furono però poco importanti, il Sermini, il Manetti, Sabadino degli Arienti, Masuccio Salerni- tano, Poggio Bracciolini, Lorenzo il Magnifico. Per compenso, in pieno Rinascimento, e cioè nel se- (') Renaissance in Italy — Italian Literatnre — Part II, Chapter X. « Of Boccaccio's legaci/ the »ios( conside- rahle portion and the one ihat bore the richest frtfif, iras the Decameron ». Masi. 1 — 2 — colo seguente, la nota fondamentale (^), per così dire, è data dalla novella ed i novellatori sono una fa- lange, dei quali lungo sarebbe ricordare i nomi soltanto. Basti che ogni regione italiana, quasi ogni città contribuisce a questa fioritura: Toscana col Firen- zuola, il Lasca, il Machiavelli, e coi Senesi For- tini, Nelli, e fino al Bargagli, che tocca il secolo XVII, Roma col Decamerone del Molza modenese, ma romano d' elezione e di dimora, Ferrara cogli Ecatommiti del Giraldi, Venezia colle Piacevoli notti dello Straparola, i Diporti del Parabosco, le Gior- nate dell' Erizzo; Lodi col Gadamosto, Vicenza col Da Porto, Gastelnovo di Scrivia con Matteo Ran- dello, il maggiore senza alcun dubbio di tutti i novellatori del Ginquecento e quello che più e meglio d'ogni altro afferma l' assoluta prevalenza, specie nella novella romanzesca, dell'Italia supe- riore. -

A Rose by Any Other Name: Shakespeare and the Cinematic Bridge of Love
A Rose by Any Other Name: Shakespeare and the Cinematic Bridge of Love Submitted to the School of Interdisciplinary Studies (Western College Program) in partial fulfillment of the requirements for the degree of Bachelor of Philosophy Interdisciplinary Studies Cameron Berner Miami University Oxford, Ohio 2009 APPROVED Advisor ________________________________ Dr. Chris Myers ii Submitted to the Miami University Honors and Scholars Program in partial fulfillment of the requirements for graduation with University Honors with Distinction Approved by: ________________________________, Advisor Dr. Ronald B. Scott ________________________________, Advisor Dr. Christopher A. Myers ________________________________, Reader Dr. William H. Newell Accepted by: ________________________________, Director University Honors Program iii ABSTRACT This project analyzes love in William Shakespeare’s Romeo & Juliet. As part of a case study and practical application of the natural harmony between the cinemas of Hollywood and Bollywood several filmic adaptations are discussed, including Romeo & Juliet (1968) directed by Franco Zeffirelli, William Shakespeare’s Romeo + Juliet (1996) directed by Baz Luhrmann, and Qayamat Se Qayamat Tak (1988) directed by Mansoor Khan. This project advocates for American appreciation of the foreign cinema of Bollywood (Mumbai, India) based on the understanding of the universal human experience of love. iv Table of Contents Introduction . 1 Part One: The Bridge of Love. 6 Chapter One: Fated Love . 7 What is love and how does it happen? . 7 Types of Love . 11 Interpreting Love . 16 Fated Love . 24 Part Two: The Most Excellent and Lamentable Tragedy of Romeo & Juliet . 28 Chapter Two: The Bard . 29 Who was Shakespeare? . .29 Shakespeare and Love . .35 Universality . .37 Chapter Three: The Star-Cross’d Lovers . -

Shakespeare's Twelfth Night As a Comedy
Globus Journal of Progressive Education A Refereed Research Journal Vol 10 / No 1 / Jan-Jun 2020 ISSN: 2231-1335 SHAKESPEARE’S TWELFTH NIGHT AS A COMEDY *Appalal Abdulgaffar Attar Introduction Abstract Shakespeare’s Twelfth Night or What You Will is a William Shakespeare happens to be the greatest comedy, first performed in 1600 and published in writer of the world. He is called the Bard of the First Folio of 1623. The most direct source was Avon. He is a great playwright and poet. His Barnabe Riche’s Apolonius and Silla, a story 37 plays include his tragedies, tragi-comedies, derived from the Italian Matteo Bandello. histories (covering Roman plays), sonnets, and comedies. The present play focuses on his fine Shakepeare’s Twelfth Night is a lovely romantic drafting of upholding the language. The comedy. Shakespeare made use of the other essential spirit of the play ‘Twelfth Night’ is historical literary materials such as Il Sacrificio captured in its title. The world of Twelfth (1537), Charles Estienne’s Les Abuses (1543), Night is one of comedy and comic excess; and Nicolo Secchi’s GiIanganni (1562), Lope de among all of the characters in the play, it is the Rueda’s Los Enganos (1556), Geraldi Cinthio’s drunken, misbehaving and prankish Sir Toby Hecatommithi (1565), Belleforest’s Histories Belch who epitomizes its humorous nature. Traqiques (1570), Barnabe Riche’s Riche His In Twelfth Night, despite the festive spirit of Farewell, and Curzio Conzaga’s GiInganni (1592). the play, Shakespeare invites his audience to notice certain problematic aspects of the story. Shakespeare’s Twelfth Night has the main plot Reductively, the theme of Twelfth Night is the concerning the Italian twins Viola and Sabastian, joy and pain of love.