Tino Di Camaino Inedito
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Master of the Unruly Children and His Artistic and Creative Identities
The Master of the Unruly Children and his Artistic and Creative Identities Hannah R. Higham A Thesis Submitted to The University of Birmingham For The Degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY Department of Art History, Film and Visual Studies School of Languages, Art History and Music College of Arts and Law The University of Birmingham May 2015 University of Birmingham Research Archive e-theses repository This unpublished thesis/dissertation is copyright of the author and/or third parties. The intellectual property rights of the author or third parties in respect of this work are as defined by The Copyright Designs and Patents Act 1988 or as modified by any successor legislation. Any use made of information contained in this thesis/dissertation must be in accordance with that legislation and must be properly acknowledged. Further distribution or reproduction in any format is prohibited without the permission of the copyright holder. ABSTRACT This thesis examines a group of terracotta sculptures attributed to an artist known as the Master of the Unruly Children. The name of this artist was coined by Wilhelm von Bode, on the occasion of his first grouping seven works featuring animated infants in Berlin and London in 1890. Due to the distinctive characteristics of his work, this personality has become a mainstay of scholarship in Renaissance sculpture which has focused on identifying the anonymous artist, despite the physical evidence which suggests the involvement of several hands. Chapter One will examine the historiography in connoisseurship from the late nineteenth century to the present and will explore the idea of the scholarly “construction” of artistic identity and issues of value and innovation that are bound up with the attribution of these works. -

Summary of the Periodic Report on the State of Conservation, 2006
State of Conservation of World Heritage Properties in Europe SECTION II - Criterion (I). Artistically unique because of its spatial design, the Campo dei Miracoli contains four ITALY absolute architectural masterpieces: the Cathedral, the baptistery, the campanile and the Campo Piazza del Duomo, Pisa Santo. Within these monuments are such world- renowned art treasures as the bronze and mosaic doors of the cathedral, the pulpits in the baptistery Brief description and cathedral, the frescoes of the Campo Santo, Standing in a large green expanse, Piazza del and many others. Duomo houses a group of monuments known the - Criterion (II). The monuments of the Campo del world over. These four masterpieces of medieval Miracoli considerably influenced the development of architecture – the cathedral, the baptistery, the architecture and monumental arts at two different campanile (the 'Leaning Tower') and the cemetery times in history. – had a great influence on monumental art in Italy from the 11th to the 14th century. 1) First, from the 11th century up to 1284, during the epitome of Pisa's prosperity, a new type of church characterized by the refinement of 1. Introduction polychrome architecture and the use of loggias was established. The Pisan style that first appeared with Year(s) of Inscription 1987 the Cathedral can be found elsewhere in Tuscany Agency responsible for site management (notably at Lucques and Pistoia), but also within the Pisan maritime territory, as shown in more humble • Opera Primaziale Pisana form by the "pieve" in Sardegna and Corsica. Piazza Duomo 17 56100 Piza 2) Later, during the 14th century, architecture In Tuscany, Italy Tuscany was dominated by the monumental style E-mail: [email protected] of Giovanni Pisano (who sculpted the pulpit of the Website: www.opapiza.it Cathedral between 1302 and 1311), a new era of pictorial art -the Trecento- was ushered in after the epidemic of the black death (Triumph of Death, a 2. -
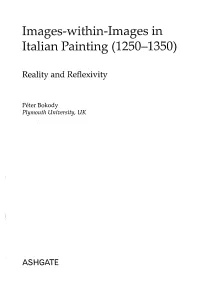
Images-Within-Images in Italian Painting (1250-1350)
Images-within-Images in Italian Painting (1250-1350) Reality and Reflexivity Peter Bokody Plymouth University, UK ASHGATE Contents List of Illustrations vii Acknowledgments xiii Introduction 1 1 Essential Images-within-Images 11 2 Illusionism 37 3 Reality Effect 59 4 Nleta-Images 89 5 Meanings 113 6 Embedded Narrative 141 7 Image and Devotion 171 Conclusion 187 Bibliography 195 Index 221 List of Illustrations Color Plates 1 Model of the Stefaneschi polyptych. 8 Pietro Lorenzetti, St. John the Giotto di Bondone, Stefaneschi polyptych Evangelist Altar, before 1319, fresco. (back), between 1300-1330, tempera on Lower Church, San Francesco, Assisi. wood. Pinacoteca, Vatican. 2014 © Photo © Stefan Diller. Scala, Florence. 9 Reliefs. Expulsion of the Devils from 2 Giotto di Bondone, Envy and Infidelity, Arez20, between 1288-1297, fresco. Upper between 1303-1305, fresco. Arena Chapel, Church, San Francesco, Assisi. © Stefan Padua. Courtesy of Comune di Padua - Diller. Department of Culture. 10 Frieze. Liberation of the Repentant of Francis. St. Francis and 3 Image St. Heretic, between 1288-1297, fresco. Upper stories his between 1260-1280, of life, Church, San Francesco, Assisi. © Stefan on wood. Chiesa di San tempera Diller. Silvestro Museo Diocesano d'Arte Sacra, Orte. 2014 © Photo DeAgostini Picture 11 Verification of the Stigmata, between Library/Scala, Florence. 1288-1297, fresco. Upper Church, San Francesco, Assisi. © Stefan Diller. 4 Painted cross. St. Francis before the Cross in San between Damiano, 12 Crucifixion. Giotto di Bondone, 1288-1297, fresco. Church, San Upper Allegory of Obedience, 1310s, fresco. Lower Francesco, Assisi. © Stefan Diller. Church, San Francesco, Assisi. © Stefan Diller. 5 Twisted column. -

RAR, Volume 16, 1996
The RUTGERS ART REVIEW Published by the Graduate Students of the Department of Art History at Rutgers, The State University of New jersey Volume 16,1996 Copyright © 1997 by Rutgers, The State University of New Jersey All rights reserved Manufactured in the United States of America ISSN 0194-049X Typeset by Gabrielle Rose and Kelly Winquist Benefactors The Graduate Student Association, Rutgers, The State University of New Jersey Johnson & Johnson Family of Companies Contributors Robert Bergman Walter Liedtke Friends Joe Giuffre Sara Harrington Stephanie Leone Judith Totaro The editorial board of the Rutgers Art Review, volume 16, gratefully acknowledges the advice and expertise of the faculty of the department of Art History, Rutgers Univer sity, and, in particular, faculty advisor Matthew Baigell. We would also like to thank Mariet Westermann, without whose invaluable assistance the interview would not have been possible. Finally the board is very grateful to all of the professional readers of papers submitted for this issue. The editors extend special thanks to Anand Commissiong, office director of the Catharine R. Stimpson Graduate Publications Office of Rutgers University, without whom this issue could not have been published. The Rutgers Art Review extends its appreciation to Nikola Stojsin and Kyle Haidet, members of the Graduate Student Association/Graduate Publications Committee, Rutgers University. Their continued professional support has been crucial to the success of the RAR. Rutgers Art Review Volume 16 Co-Editors Gabrielle Rose Kelly Winquist Editorial Board Julia Alderson Alexis Boylan Rachel Buffington Craig Eliason Ron MacNeil Mary Kate O'Hare Faculty Advisor Matthew Baigell CONTENTS Volume 16 1996 Articles A Reexamination of Nicola Pisano's Pulpits for the Pisa Baptistery and Siena Cathedral Lisa Marie Rafanelli 1 Revisioning Queer Identity: AIDS Discourse and the Impenetrable Subject in Phone Sex Advertising Randall R. -

170.2016.57.1.7.Pdf
BOOK REVIEWS BOKODY, Péter: Images-within-Images in Italian Painting (1250–1350). Reality and Reflexivity, Ashgate, Farnham – Burlington, 2015. xiv+229 pages, 20 pages of plates A picture within another picture begins appear- ing from the second half of the thirteenth cen- tury, when a powerful turn can be discerned in Italian painting. Earlier, painters tried to per- suade viewers of the “real presence” of sacred things; from this moment up to about the turn of the nineteenth and twentieth centuries they tried to represent these things, to render them visible. Representations became truer to reality towards the end of the duecento, with an aim of mirroring small details, too. The spatial correla- tion of persons and objects was pondered about, the goal being to grasp real space, to make the third dimension visible. The growing interest in representing reality, in rendering the plasticity and spatial placement of figures gave rise to the possibility of depicting separate pictures within a picture: images-within-images. Though connoisseurs and researchers of painting have been aware of this phenomenon for ages, it was a lecture by André Chastel in 1964 that first analyzed it thoroughly after some occa- sional mentions,1 after which research began to inquire into it as a self-contained phenomenon. Chastel retraced the device to the Eyckian turn Cover illustration: Crucifixion. Giotto di Bondone: in the early fifteenth century and pointed out Allegory of Obedience, 1310s, fresco. Lower Church, some major milestones from then up to the mid- San Francesco, Assisi. (© Stefan Diller) Acta Historiae Artium, Tomus 57, 2016 0001-5830/2012/$20.00 © Akadémiai Kiadó, Budapest 188 BOOK REVIEWS twentieth century, but with two or three excep- than once about a sculpture (!) within the picture tions, he was only concerned with panel and or a relief in a building or on a sarcophagus (!) canvas paintings. -

Bocche Inutili: Incorporating Pisa in the Florentine Imaginary Cristelle L
Early Modern Women: An Interdiciplinary Journal 2006, vol. 1 Bocche Inutili: Incorporating Pisa in the Florentine Imaginary Cristelle L. Baskins wo pictures, today in Dublin at the National Gallery of Ireland, Tserved originally as the front panels of a pair of fifteenth-century Florentine cassoni, or wedding chests, made as containers for the dowry goods of brides.1 These panels represent the Conquest of Pisa in 1406 (figures 1 and 2) and the Battle of Anghiari that took place in 1440 (figure 3). No documentation has yet come to light to inform us about the artist or artists responsible for these pictures or the commission to paint them. The style of the panels suggests a date circa 1460. The subject matter and the heraldry represented point to the Capponi family as likely patrons.2 The Conquest of Pisa features a foreground frieze of soldiers on horseback and on foot, with the tents of their encampment visible along the bottom perimeter of the panel. The city of Florence is seen at the upper left, identified by civic monuments including the Duomo and the tower of the Palazzo della Signoria. Opposite Florence we find a large cityscape of Pisa, including its most famous landmark, the Leaning Tower. The Conquest of Pisa represents the climactic entry of Florentine troops through the gate of S. Marco and the replacement of the Pisan standard with the lily of Florence. Located precisely in the middle ground of the composition, just outside the walls of the conquered city, almost lost amid the chaos of battle, are two groups of women and children, the “useless mouths” (bocche inutili). -

Lucca, Pistoia and Prato
Lucca, Pistoia and Prato Travel Passports Baggage allowance You may need to renew your British Passport if you We advise you to check the baggage allowances are travelling to an EU country. Please ensure your carefully as you are likely to be charged the excess passport is less than 10 years old (even if it has 6 if you exceed the weight limit. Maximum weights months or more left on it) and has at least 6 for single bags apply. months validity remaining from the date of travel. EU, Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino With British Airways your ticket includes one hold and Swiss valid national identification cards are also bag of up to 23kg plus one cabin bag no bigger than acceptable for travel. 56 x 45 x 5 cm and a personal bag (handbag or For more information, please visit: passport computer case) no bigger than 45 x 36 x 20 cm. checker Please contact the airline for further information. Visas http://www.britishairways.com As a tourist visiting from the UK, you do not need a visa for short trips to most EU countries, Iceland, Labels Liechtenstein, Norway and Switzerland. You’ll be Please use the luggage labels provided. It is useful able to stay for up to 90 days in any 180-day period. to have your home address located inside your For all other passport holders please check the visa suitcase should the label go astray. requirements with the appropriate embassy. For further information, please check here: travel Departure Tax to the EU The departure tax is included in the price of your flight tickets. -

Raumkästen« and the Moving Spectator in Medieval Italian
The Public in the Picture / Das Publikum im Bild Involving the Beholder in Antique, Islamic, Byzantine and Western Medieval and Renaissance Art / Beiträge aus der Kunst der Antike, des Islam, aus Byzanz und dem Westen Bilder Diskurs Edited by / Herausgegeben von Ulrich Pfisterer The Public in the Picture / Das Publikum im Bild Involving the Beholder in Antique, Islamic, Byzantine and Western Medieval and Renaissance Art / Beiträge aus der Kunst der Antike, des Islam, aus Byzanz und dem Westen Edited by / Herausgegeben von Beate Fricke and / und Urte Krass diaphanes 1st edition / 1. Auflage ISBN 978-3-03734-478-1 © diaphanes Zürich-Berlin 2015 All rights reserved / Alle Rechte vorbehalten Layout: 2edit, Zürich Printed and bound in Germany www.diaphanes.net Table of Contents / Inhalt Beate Fricke and Urte Krass The Public in the Picture An Introduction 7 Annette Haug Das Auge und der Blick Zum Auftreten von Zuschauern in der griechischen Bilderwelt 23 Andrea Lermer Öffentlicher Raum und Publikum in den Illustrationen der Maqamat al-Hariris im 13. Jahrhundert 57 Andrew Griebeler Audiences on the Walls of St Clement 75 Beate Fricke Complicity in Spectatorship Bystanders and Beholders in the Massacre of Innocents of Giotto and Giovanni Pisano 93 Christopher Lakey From Place to Space Raumkästen and the Moving Spectator in Medieval Italian Art 113 Henrike Haug Anteilnahme Trauernde Begleiter an burgundischen und anderen Grabmälern 137 Daniela Wagner Gegenwart und Zukunft Die Endzeit und ihre Zuschauer in den Fünfzehn Zeichen vor dem Jüngsten -

The-City-Of-Pisa.Pdf
with its beoutifulfoqode feoiuringon intriguingdetoil: eorly 17th-centuryinscriptions by studentssinging the proisesof the Bc condidotesrunning for UniversityRector. th, TheSon Motleo Nofionol Museuma on the LungornoMediceo lni housesimportont collections of medievolPison pointings ond CI sculptures,wood corvingsond illuminotedmonuscripts. Jhe Renoissonce-stylePiozzo dei Covolieriis open for visiis The PolozzoReole NotionolMuseums. formerlv o summer Ps I justo few minutesfrom the Tower.A symbolof the Medici residence of the Eir ruleover the city,it wos commissioned by CosimoI in honour Medici fomily, Gt of the Orderof Knightsof St.Stephen ond wos designedby disploys period Vqsori.lt housesthe mostimportont buildings ond churchesof furnishings ond porticulor (olso Grond DucolPiso, in the PolqzzodeiCovolieri' topestries os well colled Polozzodello os o collection Corovono) with its of orms from the il mojesticfoqode. Gioco del Ponte. The very identity It olso houses o of medievol Piso is plostercost gollery I echoed throughout ond o collection ;l its historic centre, of pointings by ieeming with o AntonioCeci. densenetwork olleys. Other churchesworth o visitore Sonlo Sepolcro6on the The street of Borgo LungornoGolilei, built on on octogonolplon inspiredby the Slretlo2once united model lhe of Churchof the HolySepulchre in Jerusolem,'l230,ond two bridges thot the peculiorChurch of SonloMorio dello SpinoT, built in o ollowed possoge remorkobleexomple of Gothicort in Europe. on the wotenvoys Theorigin of the nomecon be trocedbock to thefoct thot (todoy o Auser Serchio),to the north of the city, ond Arno to "spino"(thorn) from the crownworn by Christot hiscrucifixion, the souih.This is where the Churchof SonMichele in Borgo3is wos preservedhere. Another must-see church is the Chiesoof locoted,on exompleof the rich potrimonyof Pisonchurches, SonPoolo o Ripod'Arno8, olso by the riverside. -

Pisa Attractions: Explore Beyond the Leaning Tower | Dobbernationloves
23/8/2019 Pisa Attractions: Explore Beyond The Leaning Tower | dobbernationLOVES RECEIVE UPDATES WHEN NEW STORIES ARE POSTED Name Email Address SEND ME UPDATES AUGUST 22, 2019 DESTINATION GUIDES EUROPE TRAVEL & RESORTS Pisa Attractions: Explore Beyond The Leaning Tower While the city’s leaning tower is also its most recognizable icon, the best Pisa attractions go far beyond the manicured lawns of Piazza del Duomo. It’s rather unfortunate that the majority of tourists visit the Tuscan city on group tours for just a few hours. They take out their cameras, snap a few photos of Pisa’s famous tower, baptistery and cathedral, and then off they go to Siena! The best Pisa attractions can be found painted on a vintage street map. TABLE OF CONTENTS 1. Best Pisa Attractions 1.1. La Pergoletta Restaurant https://dobbernationloves.com/travel-resorts/pisa-attractions/ 1/22 23/8/2019 Pisa Attractions: Explore Beyond The Leaning Tower | dobbernationLOVES 1.2. Tuttomondo by Keith Haring 1.3. Keith Art Shop Cafe RECEIVE UPDATES WHEN NEW STORIES ARE POSTED 1.4. Grafti by Exit Enter 1.5. Ponte di Mezzo Name 1.6. Gelateria De’ Coltelli Pisa 1.7. Cinema Lumiere 1.8. Piazza Sant’Omobono Market Email Address 1.9. Galileo Galilei’s Birthplace 1.10. Piazza dei Cavalieri SEND ME UPDATES 1.11. Pisa Botanical Gardens 1.12. Grand Hotel Duomo Pisa 1.13. Leaning Tower of Pisa 1.14. Camposanto Monumentale Pisa 1.15. Baptistery of San Giovanni 1.16. Pisa Cathedral Best Pisa Attractions We suggest taking your time to explore Pisa’s best attractions. -

Siena Study Center: Art History
UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS – SIENA PROGRAM HISTORY OF MEDIEVAL AND RENAISSANCE SIENESE ART INSTRUCTOR: FEDERICA FISCALETTI [email protected] CELL. +39 347 37 51 800 COURSE DESCRIPTION This course will trace the development of Sienese art through visual, historical, and critical analyses. Siena has a history steeped in art, religion and politics that makes it a fascinating place to study (and in which to live). Sienese artists were pivotal in shaping medieval and Renaissance Italian painting, sculpture and architecture. From the mid-13th century until the fall of the Sienese Republic to Florence in 1555, Siena experienced its own ‘renaissance’. Particular emphasis will be given to the ‘golden age’ of the Sienese Gothic (Duccio, Simone Martini, etc.) and to the special relationship that the city held (and still holds) with the Virgin Mary and its myriad of saints and blesseds (Saint Catherine of Siena, San Bernardino, the Blessed Agostino Novello, to name but a few). The course will also explore 15th and 16th century Florentine art, focusing on some of the most important paintings and sculptures …..carried out by great Renaissance artists such as Masaccio, Botticelli, Donatello, Leonardo, Michelangelo, Lectures will be accompanied by PowerPoint presentations; on-site lectures and discussions will take place throughout the term. OVERALL GOALS OF THE COURSE Together with learning about developments in Sienese art from the 13th to 16th centuries, students will gain experience in visual analysis (style, iconography, etc.) and develop critical thinking through group discussions and presentations. GRADE BREAKDOWN 20% Attendance and Participation 25% Midterm Exam (in-class exam with slides identifications and multiple choice test) 25% Final Exam (in-class exam with slides identifications, multiple choice test, short essays) 30% Final Oral presentation (on-site presentation, each student will be asked to discuss a work of art in terms of style, iconography, historical context, comparative analysis). -

Sovr + Verbali
Articoli INTRECCI d’arte DOSSIER – n. 4/2018 SUPINO A PISA: LA FOTOGRAFIA TRA «ARCHIVIO STORICO DELL’ARTE», IL PERGAMO DI GIOVANNI E IL MUSEO CIVICO Antonella Gioli Tornato a Pisa dopo studi ampi ma disorganici, Igino Benvenuto Supino intraprende con decisione la strada della ricerca storico-artistica e della tutela del patrimonio, che qui si intende ripercorrere da un particolare punto di vista: quello della fotografia come strumento di documentazione, elaborazione, argomentazione, persino autopromozione1, seguendo il filo delle immagini del Pergamo di Giovanni Pisano tra fotografie, saggi e una lettera. Il 12 novembre 1891 Supino viene nominato, per interessamento di Adolfo Venturi, Ispettore agli Scavi e Monumenti del circondario di Pisa2. Il 23 luglio 1892 il Consiglio comunale lo nomina all’unanimità Conservatore della Pinacoteca, carica onoraria e gratuita, con il compito di realizzare il nuovo Museo civico nell'ex convento di San Francesco. Il 12 novembre 1893, dopo soli 15 mesi, Supino inaugura il Museo di cui è ora direttore; il 19 gennaio 1896 vi apre la Sala dei Medaglieri con le raccolte di Francesco Franceschi, donatore del Medagliere 1 Su Supino e la fotografia vedi: MARINELLA PIGOZZI, Igino Benvenuto Supino e l’occhio della memoria storica e MASSIMO FERRETTI, Igino Benvenuto Supino: frammenti di uno specchio, in Igino Benvenuto Supino 1858-1940 Omaggio a un padre fondatore, a cura di P. Bassani Pacht, Firenze, 2006, pp. 47-58 e 59-70, poi più ampiamente in Firenze 2010; M. FERRETTI, Frammenti di uno specchio: dalla persecuzione razziale agli esordi di Supino storico dell’arte; MARILENA TAMASSIA, Viaggio tra le fotografie storiche del Museo del Bargello al tempo di Supino; MONICA MAFFIOLI, Affinità elettive, Igino Benvenuto Supino e Vittorio Alinari; M.