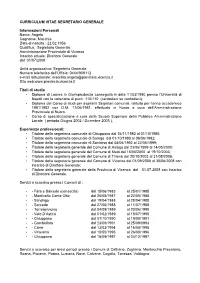GIUSEPPE Co. Dr. PASQUALIGO
POSINA
E IL SUO TERRITORIO
NEI RAPPORTI
FISICO-MEDICO-STORICO-STATISTICI
Estratto dall’Ateneo Veneto, serie IX vol Il e seguenti
VENEZIA, PREM. STAB. TIPO-LIT M. FONTANA
1885
I
Documenti e Monumenti Storici-Artistici
A ben poca cosa riduconsi i documenti e monumenti storici ed artisti reperibili in Posina - tale forse che non meriterebbe non se ne spendesse parola veruna. Tuttavolta a non lasciare inesplorato neppure questo campo ne daremo l’elenco. Nell’archivio parrocchiale se mancano pergamene relative all’istituzione della Chiesa (di cui ignorasi l’epoca precisa) abbiamo al contrario un necrologio completo dal 1655, nelle di cui pagine trovammo spesse volte notizie locali di un qualche interesse. Così tra le carte appartenenti alla fabbriceria reperisconsi non pochi testamenti, donazioni, enfiteusi, contratti dal 1500 al 1600. In quanto al Municipio esso conserva in abbastanza buon’ordine e buono stato vari documenti relativi alla amministrazione comunale sotto i Conti di Velo e sotto la Republica Veneta quanto sotto i governi che le succedettero. Anzi è a dirsi pregievole una completa raccolta esistentevi di tutte le leggi e disposizioni emanate dai primordi del secolo. In fatto d’arti belle non constaci si conservi alcun che di veramente pregevole o che meriti d’esser ricordato "a coloro che questo tempo chiameranno antico ". Tuttavolta non sono a tenere in isprego le poche tavole della Chiesa parrocchiale di Posina, che viene considerata come una delle più belle del territorio. Quella dell’altare dei Carmini p.e. quella di S. Margherita sono opere del Carpioni, l’altra dell’altar di Rosario è fattura di certo Gaetano Scabari di Arzignano. A Fusine nel nuova chiesa innalzatasi nel 1853 (progetto 26 gennaio) non havvi che un quadro rappresentante S. Carlo Borromeo di sufficiente pennello del XVII secolo, che le provenne per donazione dicesi di uno di Schio. - In quanto alle pietre litterate ed alle iscrizioni esse son pure limitate a ben poco nè meritano certo la pena di essere raccolte. La più importante è quella già infitta fuori dal presbiterio della chiesa di Posina dalla parte del Vangelo che porta la data del 24 agosto 1764 ed è ricordante la consacrazione della chiesa. Essa suona così: " D. O. M. In Honorem B. M. Semper Virgin Ecclesia hanc et altare majus Emins ac Rev.mo D. D. Antonius Marinus R. E. Cardinalis Priolus Episcopus Vicentinus Dux Marchiae et Comes die XXIV Augusti A. D. 1764 solemniter consacravit et dedicationis anniversarium quot annis celebrandum Dominica ultima ejusdem mensis constituit Archipresbitero Antonii Floriani cujus diligentia ac populi pietate a fundamentes riaedificata fuit ". Nel frontone esterno della stessa chiesa respiciente la piazza leggesi la Dedicazion della chiesa. A Fusine collocata sul muro del campanile della or abbandonata chiesa di S. Rocco leggesi altra breve iscrizione latina. Nel cimitero come in qualche edicola non troviamo indicato che l’anno delle singole e rispettive erezioni. Veruno, a quanto ci consta, possiede in Posina librerie, o raccolte d’oggetti d’arte o d’antichità. Il solo Municipio conserva oltre alcune opere di poco valore letterario, tre magnifiche carte topografiche una d’Europa, una d’Italia ed una della vicentina provincia.
Per gli amici di “Posina e la sua gente”a cura di [email protected]
3
II
Principali accenni della storia civile e politica di Posina
Tempo è oramai che ci facciamo a ricordare quanto riflette la storia civile ed ecclesiastica di Posina onde rendere meno incompleta l’intrapresa monografia. Necessariamente non avendo questo paese un’importanza di per sè stesso, così a brevissime e circoscritte nozioni deve ridursi e riducesi infatto, la parte storica o cronologica. Anzi se questa non sarà per riescire come l’avremmo desiderata e quale ordinariamente occorre per questo genere di lavori, ci valga a darcene venia il fatto che veruno mai a Posina o vicinanze si prese l’assunto di far accenno di quali fatti locali o di quelli avvenimenti straordinari ch’erano pur, si può dire, la delizia dei nostri antenati. Tutto che abbiamo raccolto in un fascio, dovemmo con somma fatica racimolare qua e là nei pochi libri qui in calce annotati(1). Nè l’archivio municipale d’altronde o l’ecclesiastico parocchiale ci conservano certa copia d’istorici documenti. Il tutto che nelle reiterate compulsazioni ci potè ri-
- sultare, riducesi
- a
- ben superficiali nozioni intorno più che altro
all’amministrazione comunale; comechè incendi, devastazioni, incuria, edulità del tempo ridussero a minime proporzioni pur quelle notizie che avrebbersi potuto reperire anche per Posina nei libri battesimali, nei necrologi della Parocchia, nei libri d’estimo del Comune e ne’ suoi bilanci annuali. Ad ogni modo a non intralciare la narrazione delle politiche vicissitudini noi divideremo questa in due parti cercando nella Ia di parlare di quanto riguarda la sua storia civile, nella IIa diremo delle ecclesiastiche cose. Ciò premesso veniamo a noi: Saggiamente scrive il Marmocchi nella sua storia naturale d’Italia che il nostro globo deve considerarsi per eccellenza il vero libro della natura di cui i capitoli sono i terreni, le pagine sono i loro strati, le parole le roccie, le lettere i minerali che vi si reperiscono. Esaminando infatti questi terreni, questi strati, annotando i minerali che si rinvengono od i fossili che vi si trovano, noi possiamo costituirci la vera istoria perfino delle età che pregressero all’apparizione dell’uomo. Ora, quanto abbiam già accennato intorno alla condizione geologica del territorio di Posina, chiaro ci manifesta l’origine sua; ma per coloro che bene addentro non sono nella geologica e paleontologica scienza ricorderemo che innanzi alla solidificazione del nostro globo, migliaja e migliaja d’anni certamente trascorsero prima che il suo raffreddamento potesse permettere la esistenza dell’uomo. Queste migliaja d’anni la bibbia col nome di 7 jom, od epoche, ci determina. In questo lasso di tempo che abbraccia le remotissime età (le quali paiono ancora un sogno dell’immaginazione) la geologia ci addimostra come l’Italia ancora non esistesse. Il primo suo rudimento, (manifesto dalle roccie serpentinose e granitiche) fu per forza plutonica dal seno dell’amplissimo mare prodotto precisamente nel settimo periodo geologico. Le prime Alpi emerse furono: il Monviso e le Cozie. Poi altre cinque emersioni seguirono a tutto ciò avanti che il mondo soffrisse quella famosa alluvione detta Universale Diluvio. Che dal settimo al tredicesimo periodo qualche parte d’Italia fosse meno abitata, non è ancor certo, quantunque la tradizione lo voglia e la mitologia greca, indiana, fenicia, assiria, egiziana (ponendo e ricordando fatti e miti antichissimi avvenuti nell’Italia prima del diluvio di Deucalione), ci faccian supporre che la cominciasse da quel tempo preistorico ad essere in qualche parte almeno abitata. Se questa poi fosse la parte piana più che la montuosa, non havvi dubbio; perchè oltre ai fatti di Fetonte (che la mitologia disse precipitato nel Po) quello delle colonne d’Ercole (che volle innalzare nell’attual Stretto di Gibilterra per impedire un secondo diluvio di Deucalione)
Per gli amici di “Posina e la sua gente”a cura di [email protected]
4
oltre che il fatto delle Elettridi cui si vuole approdati sian gli Argonauti (Elettridi che oggi pel Cellario, il Cluverio ed il D’Anville sarebbero i colli Euganei) havvi l’indiscutibile fatto addimostratoci dalla geologica scienza che queste alpi per la esistenza dei vasti ghiacciaj non potevano essere in alcun modo abitate dall’uomo, ma appena da alcuni animali di cui oggi sononsi perfino perdute le traccie. Questi vasti ghiacciaj del periodo preistorico o mitologico, solo dopo lungo decorrer di secoli poterono scomparire. Tarda pertanto fu quivi la vegetazione e quindi l’abitabilità, cioè a dire la possibilità di istituirvi abitazioni. Non crediamo quindi di non andar errati di molto facendo risalire a pochi secoli prima di Cristo la abitabilità della vallata di Posina, come la sua reale abitanza non risalga ad epoca anteriore del 1200. Ma qui una domanda logica e naturale può e deve sorgere in argomento della abitabilità, quella cioè che riflette gli abitanti aborigeni cioè a dire i primi, gli originari di questi luoghi, la loro stirpe, lo loro provvenienza? Ardua questione davvero codesta cui è difficile rispondere comecchè frà gli storici vicentini v’ha p. e. chi vuole i primi abitatori della provincia esser stati d’origine Celtica, chi li dice Etruschi, chi Galli, chi Greci, chi Cimbri. E proprio il caso di dire con l’illustre Cabianca. "Oh beati gli scrittori che trecento anni fa si sobbarcavano al compito d’una storia. Qualunque idea passasse loro pel capo era buona, ed anzi eccellente quanto più sapea di bizzarro, perchè appunto in quelle vecchie memorie Vicenza a ben poche città cederebbe sia per l’antichità d’origine che per nobiltà di lignaggio ". V’ha taluno che arriva nient’altro che a Cam figliuolo di Noè chi a Japhet, chi ad Ercole Libio, ad Eridano, a Fetonte. Giustino vorrebbe la città di Vicenza, come il territorio di sua Provincia, fondata ed abitata dai Galli Senoni. Strabone, Dione Crisostomo, Plinio il vecchio, vogliono invece che primi abitanti ne siano stati i Reti, Ferretto e Loschi dicono all’incontro che abitatori primi di Vicenza e de’ suoi monti furono i Cimbri.
Il Cabianca finalmente ed il conte Giovanni Da Schio ai nostri giorni, non si peritarono punto con più critico giudizio dall’asserire come gli aborigeni di Vicenza e della Provincia sua altri non fossero nè potessero essere che gli
(2)
Euganei popolo ch’ebbe come ognun sa l’origine etrusca Siffatta supposizione, accettabile tosto che si voglia por mente che questi Reti, Cimbri, Alemanni che dir si vogliano, non ci lasciarono finalmente monumento veruno di lor antica esistenza, mentre sussistono invece moltissimi sepolcreti etruschi euganei giusto nella Vicentina Provincia, mentre trovansi nomi d’innumerevoli quantità di villaggi, montagne, fiumi, torrenti che ripetono l’etimologia nella loro lingua p. e. Astego (che vuol dir limpido) Velo (cioè a dire trà monti) Piovène (che significa bosco) Leogra (fiume) etc. risentono tutta la dolcezza dell’originario idioma mentre conservansi finalmente moltissime iscrizioni etruscoeuganeee sparse qua e là su tutta la provincia Vicentina. Or questi Euganei sarebbersi stanziati nella provincia Vicentina solo tre secoli prima della caduta di Troja. Dopo la distruzione di questa gli Heneti (popolo di Paflagonia che cogli Euganei aveva però comune l’antichissima origine) scesero non già a sopraffarli (chè non potevano nè per forza nè per coltura) ma ad affratellarsi con essi; per il che immedesimatisi, quivi vissero quietamente edificando in tutto il Veneto delta villaggi e città cui diedero greci nomi a ricordo forse dei patrii siti.
Scesi in progresso per l’Alpi Taurine i tristissimi Galli a funestare la prima volta di loro presenza l’Italia, seguitati da altri popoli non meno barbari) quali i Cenomani, i Saluvii, i Celti ed i Boj) conquistarono la fertile Lombardia e buona parte ancora del Veneto piantandovi sede ed innalzando città cui davan
Per gli amici di “Posina e la sua gente”a cura di [email protected]
5
Galloceltica nomenclatura. Se a quanto abbiam durato nel pacifico possesso di questo provincia o se pur essi siansi immedesimati coi popoli primitivi, la storia non dice. Grazia grande ella è, il sapere come intorno il 619 di G.C. i Romani già signori del mondo, imperassero per tutta l’Italia così, da farsi arbitri e stabilire i confini tra Padova e Vicenza a mezzo del proconsole Sereno, e che facendosi di questi terrieri alleati prima, poi sudditi estendessero loro la protezione e la gloria dal giorno in cui Vicenza fu ascritta alla tribù Messenia. Dalla Romana republica passò, come ogni altra parte della Venezia terrestre (chè l’insulana per un popolo di Eroi cominciava a viver vita da sè, libera e indipendente) passò in potere dei Cesari Occidentali. Per l’irruzione dei barbari andò fatalmente a terminare nello stesso sconvolgimento di tutta Italia. Da quest’epoca si può dire cominci realmente la storia di questa vallata, datando appena dalla erezione delle sue varie contrade. Come già preaccenammo, rude, sassoso oltremodo essendo il terreno, ben difficilmente potevasi desiderarlo e prescieglierlo per innalzarvi villaggi od agglomerati di case: tanto più non essendo la popolazione delle vicine città stragrande allora per modo, da imporre l’emigrazione su larga scala ai loro abitanti. Che se dall’epoca romana (come abbiam detto) erasi pur cominciato in questa Provincia ad abitare le falde dei monti alle loro cime invece non ricorrevano neanche allora che pochi e nomadi pastori, in vista appunto dell’aridità e dell’orridezza del sito che oltremodo boschivo era ricetto ad animali feroci quali i lupi, i cinghiali che con molta difficoltà vennero in pregresso di tempo distrutti. Una delle più antiche se non la più antica località di questi contorni che siasi abitata e coltivata durante il romano dominio, fa la falda del cosidetto Monte Summano comechè reputandosi allora tutte le montagne sacre agli Dei, avevasi consacrato questo monte al Dio Plutone Summano, come il monte Panisacco lo erasi al famoso Dio Pane. L’abitudine di accorrere a quel santuario (dove fin da Roma per titolo di devozione trasportaronsi le salme dei più reputati e distinti cittadini) la fertilità del sito, la rinomanza del Nome cui si attribuivano le più felici cure i più distinti prodigi, diedero pur a quei giorni, se non l’origine, l’ampliamento del vicino borgo nominato Piovene, nel quale diffatto anche tuttodì si ritrovano innumerevoli memorie romane, lapidi, ceppi, armi, monete, per il che, quantunque tardi havvi chi in oggi si sobbarca a destarne la storia. Quasi contemporanea a Piovene cioè dei tempi Romani deve essere egualmente l’erezione d’Arsiero, come è ad arguirsi dal nome di origine latina (arx arcis castello). All’insù peraltro di questi siti, lo ripetiamo, tutto si conservava ancor inane ed incolto. Che d’altronde siffatta nostra opinione non sia destituita di fondamento o di ragione la prova anzitutto il fatto che egli non è possibile punto di reperire per tutti questi nè documenti nè monumenti anteriori all’epoca de’ bassi tempi, ed in secondo luogo che la stessa nomenclatura della maggior parte di questi luoghi accenna e ricorda assolutamente non altro se non se l’epoca delle irruzioni barbariche, l’epoca della bassa latinità. Ed invero - il più antico nome di queste contrade che riscontrisi ricordato (dopo quelli di Piovene, di Velo, d’Arsiero) sarebbe quello di Fusine (Fucine) considerato anzi qual capoluogo dell’intiera vallata fin oltre al 1600. Vuolsi generalmente che il nome di Fusine siale provvenuto dalle varie officine che anche anticamente tenevansi per la lavorazione del ferro spatico... e sarà! - ma con buona pace degli etimologisti, noi non crediamo. Dov’erano infatti, donde poteano essere alimentate queste officine se scarsa prima di tutto mostrasi proprio in questa località la
Per gli amici di “Posina e la sua gente”a cura di [email protected]
6
portata del torrente che non arriva ai tre metri per minuto secondo? Come è mai ciò possibile se nel mentre di antiche miniere d’oro, d’argento ci viene dalla tradizione fatto ricordo (p. e. verso M. Tretto e M. di Velo) nulla ricordasi invece, nulla accenna alla preesistenza di vere, di perfette miniere di ferro in questa località o nei contorni? Nè d’altronde il reperimento di quel pochissimo ferro che occorre talvolta nella cosidetta Val di Rio può dirsi sufficiente per fare ammettere che quei primi abitanti fossero tratti a qui fermarsi ed istituire officine di ferro in tal numero, di tanta importanza da originare perfino il nome al nuovo loro paese.
Un’altra considerazione in proposito sì è quella che non sempre la parola
Fucina, fu adoperata ad indicare un’officina pel lavoro del ferro. Anzi in varie carte dal 900 al 1000 troviamo la parola fucina per indicare una località aspra o deserta, come in tal’altra un ricettacolo di banditi e malviventi. Anche italianamente fucina vale per officina di fabbro come per ricettacolo di tristi " fucina di delitti in cui si serra - Tutto d’Europa il duolo ed il cordoglio " disse già il Monti dell’Inghilterra - e Fucina disse pur Boccaccio al sito ove s’annidavano a suoi giorni i banditi - Fucina per luogo deserto fu parimenti detto dai Veneziani un punto melmoso dell’estuario, come Fusine per luogo aspro e montuoso fu chiamato l’ingresso della Val Madre sulla sinistra dell’Adda. Se d’altronde il nome di Fusine per questa località, com’è un fatto incontroversibile, non si trova indicato prima del 1000, se a quell’epoca tal nome aveva un significato diverso, non sappiamo perchè si deva accettare negli ottimi un’idea popolare destituita di fondamento e di prove per trovarne l’etimologia. D’altronde imporre ai paesi, alle località il nome esprimente la speciale lor condizione o geologica o topografica o politica o commerciale fu vezzo e costume antichissimo, logico e necessario. Altre contrade, altre località, altri punti nell’ambito di questa vallata portan appellativi da cui devesi arguire forzatamente che non siano sorte se non se come fusine, nell’epoca preacennata; in quella ciò è della bassa latinità.
Sono questi per noi i nomi Vanzo, Ronchi, Zerbi, Griso, Posina, Poj, Ligazzoli,
Ganna, Rònzi-Allona, Xanza Bazzoni e varj altri. Ed invero nel Glossario della bassa latinità del Ducange troviamo più volte indicate come sinonimi le voci Xanza-Vanzo Vanza per indicare un luogo incolto(3). La parola semibarbara roncare usitatissima nel 900 di G. C. diede origine in Italia al nome di varie ville, di varie località, p. e. nel territorio Padovano a Roncasette, Roncadizza, Roncaglia, Roncarola, Ronchi, Ronchone, Ronzi, e via via e qui pure noi abbiamo e Ronchi e Ronzi contrade che, ricordandoci l’antica lor condizione di incoltivate, ci danno la prova per effetto dello stesso nome affibbiato che non possono esser sorte se non verso il 1000 e non dopo il 1400 in cui alla parola roncare fu sostituita quella di falciare. A boscaglie di quell’epoca accennano pur le nomenclature di Bezze e di Gazzoe Gazzuolo che usavasi come sinonimi. Con voce sempre dei bassi tempi rinveniamo rammemorata la situazione di sito incolto per le contrade denominate tuttora dei Zerbi e dei Ruari (cioè Rovaj). Il Glossario precitato del sommo Ducange ci indica adoprata allora (e solo allora) la parola di Xomo per monte e qui noi ritroviamo una località con tale significante appellativo. Deducendolo pure dal nome dobbiamo credere che innanzi al mille e precisamente all’epoca dei Longobardi abbiano avuto origine le contrade di Mogentale, di Telder, di Rust, Res, Stonner e Ghemonda soli appellativi in questi luoghi che sentano l’origine germanica comechè; Ghemonda verrebbe da Ghemainde voce germanica che vuoi dire fondo comune Mogentale corruzione di Morghen Thal cioè Valle del Mezzogiorno. - Telder
Per gli amici di “Posina e la sua gente”a cura di [email protected]
7
viene pure da Thal vallata, Rust da Ruster che vuol dire loro Res da Riesein mormorar dei ruscelli. Stoner da Steinarting luogo pietroso (4)
All’incontro siti abitati posteriormente al 1400 e che portan pur nome derivante loro dalle condizione o topografica o geografica o agricola od industriale sarebbero per noi quelli del Collo (Colle) Maso (masso) e Masetto, di Costa (costiera) o Costamala - di Casette, di Fornasa (fornace) Spini, Prà (prateria) Lepora (dalle lepri) Caprin (dalle capre) Cornola (dai cornolari) Bande (ossia versante). Montagna, Valbruna, Bosco Monte, Montefiore, Rotonda, Val-caprara, Val-cotaraste detta così da Gatter cancello ed Ast rami, comecchè in essa eran posti di ordine della Repubblica Veneta appunto dei rastelli per segnar i confini e tutelar la salute pubblica nel caso di epidemie e di contagi come già ebbimo occasione d’indicare altra volta. Ma a comprovare ognor più l’opinione manifestata, che la valle di Posina non abbia cominciato ad essere abitata nè coltivata se non dopo il mille di G. C., valgono pure i nomi affibiati ad altre sue contrade quelli cioè di Lambre, Ganna, Maraschini, Poi, Griso, Bazzoni, Lighezzole, Posina ed Allona voci tutte che se oggidì non hanno significato veruno, l’avevano appunto speciale e caratteristico dal 1000 al
(5)
1300 .
Lo stesso buon senso prova l’asserto nostro, perchè se queste contrade fossero state così battezzate innanzi al 1000 o dopo il 1400 non avrebbero avuto nomenclatura affatto vuota di senso. Neppure è a dirsi che questa sia lor provvenuta dal cognome delle famiglie che prima vennero ad abitarvi, imperocchè noi sappiamo che cognomi in Italia non ve ne erano prima del 1000, secondariamente perchè anche i cognomi s’assunsero in Italia come altrove dalle qualità fisiche e morali degli individui, dall’arte, dalla professione esercitata, dai possessi o dai carichi avuti, dal censo, dall’origine, dalle imprese nè poteano esser per ciò cognomi che non indicassero a qualche fatto, ad una qualche condizione fisica o morale degli individui o che per lo meno non fossero o patrimonici o matrimonici!
Ad ogni modo, se pure queste contrade avessero avuta la loro nomenclatura dai cognomi, come l’ebbero appunto quelle di Lunardelli, Kanderle (6), Tamazzolo, Spagnolo, Ciperle, La Betta (7)., Casa-Raute, Lizza,