“Giuseppe Verdi” CLASSE VA DOCUMENTO DEL
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
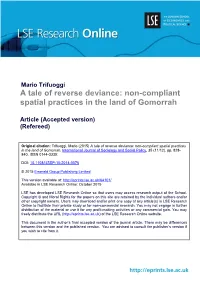
A Tale of Reverse Deviance: Non-Compliant Spatial Practices in the Land of Gomorrah
Mario Trifuoggi A tale of reverse deviance: non-compliant spatial practices in the land of Gomorrah Article (Accepted version) (Refereed) Original citation: Trifuoggi, Mario (2015) A tale of reverse deviance: non-compliant spatial practices in the land of Gomorrah. International Journal of Sociology and Social Policy, 35 (11/12). pp. 828- 840. ISSN 0144-333X DOI: 10.1108/IJSSP-10-2014-0076 © 2015 Emerald Group Publishing Limited This version available at: http://eprints.lse.ac.uk/64101/ Available in LSE Research Online: October 2015 LSE has developed LSE Research Online so that users may access research output of the School. Copyright © and Moral Rights for the papers on this site are retained by the individual authors and/or other copyright owners. Users may download and/or print one copy of any article(s) in LSE Research Online to facilitate their private study or for non-commercial research. You may not engage in further distribution of the material or use it for any profit-making activities or any commercial gain. You may freely distribute the URL (http://eprints.lse.ac.uk) of the LSE Research Online website. This document is the author’s final accepted version of the journal article. There may be differences between this version and the published version. You are advised to consult the publisher’s version if you wish to cite from it. A TALE OF REVERSE DEVIANCE: NON-COMPLIANT SPATIAL PRACTICES IN THE LAND OF GOMORRAH Mario Trifuoggi [email protected] Abstract Racketeering local activities, though less relevant in terms of financial turnover, still represents a distinctive feature of mafia-like organisations for it provides them with striking social power. -

A PARALLEL CONTAGION Is Mafia Entrepreneurship Exploiting the Pandemic?
A PARALLEL CONTAGION Is mafia entrepreneurship exploiting the pandemic? n the midst of the COVID-19 pandemic, which at the time of writing had claimed the lives of almost 120 000 people worldwide, there is increasing concern about mafia activity both during the outbreak and in its Iaftermath. The risk is greatest in Italy, the country that has suffered one of the highest numbers of COVID-19- related deaths, where the pandemic is having a significant impact not only on public health but also on the country’s social fabric and economy. With thousands of establishments put out of business in the past month – including bars, restaurants and shops – business owners and workers alike have been deeply affected by the lockdown. To compound the suffering, the estimated 3.3 million workers engaged in the country’s vast informal economy – which has an estimated value of up to €211 billion – are effectively excluded from government financial support. Italy’s mafia groups have, in response, sought to consolidate their social support by distributing food for free in the community. Concerned with this development, the Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC) has had the privilege of bringing together four leading figures in Italy’s fight against the mafia for a virtual roundtable to discuss how the mafia is repositioning itself during the pandemic, what the implications are and how the Italian government is responding.1 WE FEATURE INTERVIEWS WITH: • Franco Gabrielli, Italian Chief of Police and Director General of Public Security • Nicola Gratteri, Public Prosecutor of Catanzaro, Calabria • Federico Cafiero de Raho, Italian National Anti-Mafia and Counterterrorism Public Prosecutor • Nicola Morra, Chairman of the Parliamentary Anti-Mafia Commission The interviews were led by Sergio Nazzaro, a journalist, writer and adviser to the Parliamentary Anti-Mafia Commission. -

Nomi E Storie Delle Vittime Innocenti Delle Mafie
Nomi e storie delle vittime innocenti delle mafie a cura di Marcello Scaglione e dei ragazzi del Presidio “Francesca Morvillo” di Libera Genova Realizzato in occasione della mostra “900 Nomi vittime di mafia dal 1893 ad oggi” inaugurata ad Imperia il 21 Marzo 2016 in occasione della XXI Giornata della memoria e dell’impegno - ”Ponti di memoria, luoghi di impegno”. I nomi presenti nella mostra sono quelli accertati fino all'anno 2015, ed in particolare quelli letti a Bologna durante la XX Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie (21 marzo 2015). Il lavoro di ricerca, inizialmente limitato a quell'elenco, è stato poi implementato e aggiornato, comprendendo quindi le storie delle vittime innocenti i cui nomi sono stati letti durante la XXI Giornata della Memoria e dell'Impegno (21 marzo 2016). Sarà nostro impegno e cura eseguire successivamente gli aggiornamenti necessari. Siamo inoltre disponibili a intervenire sulle singole storie, laddove dovessero essere ravvisati errori e/o imprecisioni. EMANUELE NOTABARTOLO, 01/02/1893 Nato in una famiglia aristocratica palermitana, presto rimane orfano di entrambi i genitori. Cresciuto in Sicilia, nel 1857 si trasferisce prima a Parigi, poi in Inghilterra, dove conosce Michele Amari e Mariano Stabile, due esuli siciliani che lo influenzeranno molto. Avvicinatosi all'economia e alla storia, diventa sostenitore del liberalismo conservatore (quindi vicino alla Destra storica). Dal 1862 Emanuele Notarbartolo diventa prima reggente, poi titolare, del Banco di Sicilia, al quale si dedica a tempo pieno a partire dal 1876, salvandolo dal fallimento in seguito all'Unità d'Italia. Il suo lavoro al Banco di Sicilia inizia a inimicargli molta gente. -
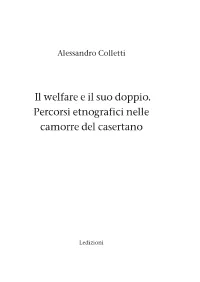
Il Welfare E Il Suo Doppio. Percorsi Etnografici Nelle Camorre Del Casertano
Alessandro Colletti Il welfare e il suo doppio. Percorsi etnografici nelle camorre del casertano Ledizioni © 2016 Ledizioni LediPublishing Via Alamanni, 11 – 20141 Milano – Italy www.ledizioni.it [email protected] Alessandro Colletti, Il welfare e il suo doppio. Percorsi etnografici nelle camorre del casertano Prima edizione: febbraio 2016 ISBN Cartaceo: 978-88-6705-426-8 Copertina e progetto grafico: ufficio grafico Ledizioni I ricavi dai diritti d’autore saranno devoluti al Comitato Don Peppe Diana di Casal di Principe Indice Prefazione di Antonio La Spina 5 Introduzione 11 Metodi e fonti 17 Parte Prima. Un’analisi delle forme di egemonia delle mafie: tra controllo e assistenza 27 1. Il controllo territoriale nella storia delle camorre 29 Il riconoscimento istituzionale del potere camorrista 34 Il controllo territoriale nell’area campana 39 2. Forme organizzative e redistributive: la “cassa comune” 49 Le mafie come organizzazioni professionali 50 Il funzionamento della “cassa comune” 53 I capi cambiano, la struttura resta: dal “clan Bardellino-Iovine” al “clan dei casalesi” 63 3. La protezione sociale delle camorre casertane 73 Il clan La Torre 76 Il clan Belforte 82 I clan Schiavone e Bidognetti: alleati, federati, separati 89 Gerarchia e livelli stipendiali: il clan Schiavone 94 Forme di assistenza nei clan del casertano 101 Parte Seconda. Le politiche socio-assistenziali nella provincia di Caserta: un welfare (s)finito 113 1. Analisi delle forme di welfare pubblico: il sistema italiano 115 I territori del welfare: dallo Stato agli enti locali 118 Il livello territoriale dei servizi sociali 123 2. Zona di contatto: servizi alla persona nella provincia casertana 135 La dimensione territoriale dei servizi nella governance regionale 140 Uno sguardo alle pratiche locali di welfare nell’area casertana 143 Il welfare raccontato da chi lo dirige: le interviste ai coordinatori degli Uffici di Piano 148 3. -

INFOSOURCES™ Empowered in Southeastern Sets up in Prague (Page 7) READ TODAY WHAT YOU WILL ASK TOMORROW Europe (Page 5-6) CRIME
Issue No.3 | www.infosources.info August 2018 Regional organized crime Balkan Organized Crime INFOSOURCES™ empowered in Southeastern Sets up in Prague (page 7) READ TODAY WHAT YOU WILL ASK TOMORROW Europe (page 5-6) CRIME The biggest 5 organized crime groups in the world Organized crime www.picturesdotnews.com Cybercrime is grabbing the headlines these days, ver from its effects, rather than what thieves reached $34 billion annually. but the largest criminal gangs are still making earn from their crimes. When you add the market for other illicit drugs most of their money from drugs, sex, and extor- Compare that to estimates of pure revenue and revenue generators like human trafficking tion. from other forms of organized crime like the and extortion, it becomes clear that organized It’s tough to go even a few months without seeing drug trade and human trafficking: the -Or crime is still making most of its money from its the effects of organized crime on the economy and ganization of American States estimates that legacy businesses, despite the fact that criminals everyday life. The most salient example these days is the rash of thefts of credit card data from big- the revenue for cocaine sales in the U.S. has are always looking for new ways to make a buck. name retail chains like Home Depot and Target. While these threats are headline-grabbing and particularly frightening because e-commerce is a relatively new phenomenon and businesses and consumers aren’t totally sure how to protect them- selves from hackers, it’s still a drop in the bucket in terms of overall organized crime earnings. -

CHAPTER I – Bloody Saturday………………………………………………………………
THE PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY SCHREYER HONORS COLLEGE DEPARTMENT OF JOURNALISM ITALIAN WHITE-COLLAR CRIME IN THE GLOBALIZATION ERA RICCARDO M. GHIA Spring 2010 A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for a baccalaureate degree in Journalism with honors in Journalism Reviewed and approved by Russell Frank Associate Professor Honors Adviser Thesis Supervisor Russ Eshleman Senior Lecturer Second Faculty Reader ABSTRACT At the beginning of the 2000s, three factories in Asti, a small Italian town, went broke and closed in quick succession. Hundreds of men were laid off. After some time, an investigation mounted by local prosecutors began to reveal what led to bankruptcy. A group of Italian and Spanish entrepreneurs organized a scheme to fraudulently bankrupt their own factories. Globalization made production more profitable where manpower and machinery are cheaper. A well-planned fraudulent bankruptcy would kill three birds with one stone: disposing of non- competitive facilities, fleecing creditors and sidestepping Italian labor laws. These managers hired a former labor union leader, Silvano Sordi, who is also a notorious “fixer.” According to the prosecutors, Sordi bribed prominent labor union leaders of the CGIL (Italian General Confederation of Labor), the major Italian labor union. My investigation shows that smaller, local scandals were part of a larger scheme that led to the divestments of relevant sectors of the Italian industry. Sordi also played a key role in many shady businesses – varying from awarding bogus university degrees to toxic waste trafficking. My research unveils an expanded, loose network that highlights the multiple connections between political, economic and criminal forces in the Italian system. -

Dell'arma Dei Carabinieri
dell’Arma dei Carabinieri RassegnaQuaderno n. 5/2016 TESI DI LAUREA DEI FREQUENTATORI DEL 19° E 21° CORSO DI PERFEZIONAMENTO Anno Accademico 2012-2013 Anno Accademico 2014-2015 La teoria ecologica delle aree criminali Il caso Scampia: dal fallimento dell’urbanistica alle faide di camorra (Ten. Salvatore Beneduce) La gestione di quote societarie confiscate alla criminalità organizzata (Ten. Giovanni Riacà) Scuola Ufficiali Carabinieri, 2016 Radells’ArsmaedeigCaranbiniaeri Direttore Responsabile Gen. D. Vittorio Tomasone Redattore Capo Col. Giuseppe Arcidiacono Redazione Lgt. Remo Gonnella M.A. s.UPS. Alessio Rumori Brig. Mario Pasquale App. Sc. Lorenzo Buono Direzione e Amministrazione Via Aurelia, 511 - 00165 Roma - tel. 06-66394680 fax 06-66394746; e-mail:[email protected] Grafica, Fotocomposizione e Impaginazione a cura della Redazione Fonti iconografiche Ministero della Difesa Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri Scuola Ufficiali Carabinieri La «Rassegna dell’Arma dei Carabinieri» è istituita per aggiornare la preparazione specifica dei Quadri dell’Arma offrendo loro argomenti originali sull’evoluzione del pensiero militare e delle discipline giuridiche, professionali e tecnico-scientifiche che più interessano il servizio d’Istituto. La collaborazione alla Rassegna dell’Arma è aperta a tutti. La Direzione è lieta di ricevere articoli o studi su argomenti di interesse, riservandosi il diritto di decidere la loro pubblicazione. Gli articoli di collaborazione diretta sono pubblicati sotto l’esclusiva responsabilità degli autori; le idee e le considerazioni sono personali, non hanno riferimento ad orientamenti ufficiali e non impegnano la Direzione della Rassegna. La Redazione si riserva il diritto di modificare il titolo e l’impostazione grafica degli articoli, secondo le proprie esigenze editoriali. -

A PARALLEL CONTAGION Is Mafia Entrepreneurship Exploiting the Pandemic?
A PARALLEL CONTAGION Is mafia entrepreneurship exploiting the pandemic? n the midst of the COVID-19 pandemic, which at the time of writing had claimed the lives of almost 120 000 people worldwide, there is increasing concern about mafia activity both during the outbreak and in its Iaftermath. This risk, which is felt across Europe, is perhaps greatest in Italy, the country that has suffered one one of the highest numbers of COVID-19-related deaths, where the pandemic is having a significant impact not only on public health but also on the country’s social fabric and economy. With thousands of establishments put out of business in the past month – including bars, restaurants and shops – business owners and workers alike have been deeply affected by the lockdown. To compound the suffering, the estimated 3.3 million workers engaged in the country’s vast informal economy – which has an estimated value of up to €211 billion – are effectively excluded from government financial support. Italy’s mafia groups have, in response, sought to consolidate their social support by distributing food for free in the community. Concerned with this development, the Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC) has had the privilege of bringing together four leading figures in Italy’s fight against the mafia for a virtual roundtable to discuss how the mafia is repositioning itself during the pandemic, what the implications are and how the Italian government is responding.1 WE FEATURE INTERVIEWS WITH: • Franco Gabrielli, Italian Chief of Police and Director General of Public Security • Nicola Gratteri, Public Prosecutor of Catanzaro, Calabria • Federico Cafiero de Raho, Italian National Anti-Mafia and Counterterrorism Public Prosecutor • Nicola Morra, Chairman of the Parliamentary Anti-Mafia Commission The interviews were led by Sergio Nazzaro, a journalist, writer and adviser to the Parliamentary Anti-Mafia Commission. -

STORIA DEL MOVIMENTO ANTIRACKET Ha Scelto Da Che Parte Stare: Grandi Industriali E Piccoli Commercianti DEL MOVIMENTO Marciano Ormai Lungo La Stessa Strada
Venticinque lunghi anni di coraggio. E passione, intelligenza, strategia: ciò che è servito per liberare un pezzo di Italia. È l’inizio degli Anni 4 4 ARCIPELAGO Novanta e, tra i monti Nebrodi e il mar Tirreno, un gruppo di mercanti mafie • economia • impresa rialza la testa. Capo d’Orlando dice no ai signori del pizzo, organizza la prima associazione antiracket. È uno strumento innovativo per sottrarre il singolo operatore economico alla solitudine ed evitare il sacrificio di CONTICELLO FILIPPO altri Libero Grassi. Un modello felice, da riprodurre ovunque ci siano Filippo Conticello imprenditori pronti a ribellarsi all’estorsione mafiosa. Il libro racconta questo contagio positivo, lo sviluppo delle associazioni in piccoli paesi e grandi centri. Nel resto della Sicilia, in Calabria e Puglia, fino allo sbarco a Napoli e in Campania. Un movimento, la Fai (Federazione antiracket italiana), che cresce e produce denunce. Risultati pratici, STORIA perfino una legge di sistema che tutela gli imprenditori ribelli. Se attraverso il consumo critico elaborato dal Comitato Addiopizzo la battaglia si arricchisce di nuovi contenuti, ora anche la Confindustria ANTIRACKET MOVIMENTO DEL STORIA ha scelto da che parte stare: grandi industriali e piccoli commercianti DEL MOVIMENTO marciano ormai lungo la stessa strada. Tra le pagine si affollano, così, uomini e speranze, vittorie ed errori, dentro a un movimento diventato patrimonio del Paese. ANTIRACKET FILIPPO CONTICELLO (Catania, 1983) è giornalista professionista e dal 2008 redattore a Milano della «Gazzetta dello Sport», dove si occupa, oltre che di calcio, di attualità, società e cultura. Si è laureato alla 1990 • 2015 Sapienza di Roma con una tesi sul fenomeno del racket delle estorsioni mafiose, con la quale ha vinto il premio “Giancarlo Siani” a Napoli. -

Chronicles of Ordinary Racism Second White Paper on Racism in Italy Edited by Lunaria, Rome, 2011
Chronicles of Ordinary Racism Second White Paper on Racism in Italy Edited by Lunaria, Rome, 2011 www.lunaria.org with the support of English version of Cronache di ordinario razzismo, Secondo libro bianco sul razzismo in Italia, edited by Lunaria, Edizioni dell’Asino, 2011 English translation by Davide Di Pietro and Clara Marshall The book has been realized thanks to the support of Tavola Valdese and Fondazione Charlemagne Chronicles of ordinary Racism is the result of the collectif work of Paola Andrisani, Sergio Bontempelli, Andrea Callaioli, Serena Chiodo, Giuseppe Faso, Filippo Miraglia, Grazia Naletto, Maria Silvia Olivieri, Alan Pona, Enrico Pugliese, Annamaria Rivera, Ilaria Traina Table of contents Introduction SECTION 1. THE POLITICAL AND CULTURAL CONTEXT Annamaria Rivera Two years of racism in Italy. Main actors and secondary players, victims and rebels Enrico Pugliese Immigrant workers during the crisis and institutional racism Grazia Naletto Institutional racism in the welfare system Maria Silvia Olivieri Reception buckles under the weight of “emergency” Sergio Bontempelli The country of forced evictions (and detention centres). Local policies on Roma and Sinti communities in Italy Giuseppe Faso e Alan Pona Getting to know yourself. Language tests: turning a blind eye Filippo Miraglia The future of citizenship and participation SECTION 2. REGULATIONS AND CASE‐LAW Andrea Callaioli Emergency as the norm. Institutionalised racism in the legislation on immigration from 2008 onwards Ilaria Traina Discrimination and access to the welfare system: lower court rulings SECTION 3. MIGRANTS AND MEDIA Grazia Naletto Immigrants and the media: one step forward, two steps back Paola Andrisani Sanaa’s murder Grazia Naletto The Rosarno riots Grazia Naletto The creativity of the Municipality of Adro Grazia Naletto The death of Maricica Hahaianu Giuseppe Faso The murder of Petre Ciurar Grazia Naletto A cruel diary SECTION 4. -

Les Activites De Blanchiment Des Organisations Criminelles Italiennes
DEPARTEMENT DE RECHERCHE SUR LES MENACES CRIMINELLES CONTEMPORAINES © 2002 Université de Paris Panthéon-Assas – Paris II UNIVERSITE PANTHEON ASSAS – PARIS II DEPARTEMENT DE RECHERCHE SUR LES MENACES CRIMINELLES CONTEMPORAINES LES ACTIVITES DE BLANCHIMENT DES ORGANISATIONS CRIMINELLES ITALIENNES Mémoire présenté dans le cadre du Diplôme d’Université (D.U.) de 3e Cycle Analyse des Menaces Criminelles Contemporaines par Claudio BELISARIO sous la direction de M. Xavier RAUFER 1 DEPARTEMENT DE RECHERCHE SUR LES MENACES CRIMINELLES CONTEMPORAINES © 2002 Université de Paris Panthéon-Assas – Paris II SESSION 2000-2001 LES ACTIVITES DE BLANCHIMENT DES ORGANISATIONS CRIMINELLES ITALIENNES INTRODUCTION PREMIERE PARTIE : LES ACTIVITES DE BLANCHIMENT DES MAFIAS ITALIENNES. I.1. REVENUS CRIMINELS ET PRATIQUES DE BLANCHIMENT DE COSA NOSTRA. I.1.1. LES REVENUS CRIMINELS DE COSA NOSTRA I.1.1.1. L’extorsion de fonds : la collecte du Pizzo. I.1.1.2. La collusion avec les partis politiques, les marchés publics arrangés et les détournements des subventions italiennes et européennes. I.1.1.3. Trafic international de stupéfiants et blanchiment. I.1.2. LES PRATIQUES DE BLANCHIMENT DE COSA NOSTRA. I.1.2.1. Le blanchiment au travers du contrôle des activités agricoles en Sicile. I.1.2.2. L’internationalisation des investissements de Cosa Nostra. I.1.2.3. Trois grandes figures de blanchisseurs au profit de Cosa Nostra : Sindona, Calvi et Gelli. I.1.2.4. Le cas Silvio Berlusconi : proximité ou collusion avec Cosa Nostra ? I.2. REVENUS CRIMINELS ET PRATIQUES DE BLANCHIMENT DE LA CAMORRA. I.2.1. LES REVENUS CRIMINELS DE LA CAMORRA. I.2.1.1. -

Download PDF File: Chronicles of Ordinary Racism. Fifth White Paper
1 Chronicles of Ordinary Racism. Fifth White Paper on Racism in Italy INDEX Introduction PART 1. The political and cultural context A decade of racist infamy Annamaria Rivera The long parable of the Italian reception system Sergio Bontempelli – Giuseppe Faso Lights and shadows of media information on racism Paola Barretta Speaking of hate. A decade of violent and racist rhetoric online and beyond Paola Andrisani 2009-2019: ten years of antiracism in Italy divided between “fear” and welcome Grazia Naletto PART 2. 10 years and more of Chronicles of Ordinary Racism Racism in Italy. Official Data Lunaria Racism documented by Lunaria on Cronache di ordinario razzismo database Lunaria 2008-2019: eleven years of ordinary racism in Italy Grazia Naletto 2.1 Justice and racism: 11 exemplary cases Erba. Guilty for 24 hours. The media lynching of Azouz Marzouk Paola Andrisani Parma. The brutality of institutional racism suffered by Emmanuel Foster Bonsu Grazia Naletto Castel Volturno. Massacre of camorra, racist massacre Grazia Naletto 2 Chronicles of Ordinary Racism. Fifth White Paper on Racism in Italy Tourin. Those “Goodfellas” of Continassa convicted of racism Paola Andrisani Milan. “Zingaropoli”: prohibition of racism even for political parties Grazia Naletto Villa Opicina. Alina, free “against herself”. Nevertheless, “the fact doesn’t exist” Paola Andrisani Stormfront. The success of the world’s largest racist hate site Paola Andrisani Rome. Construction and deconstruction of a prejudice around the murder of Muhammad Shahzad Khan Roberta Salzano Parma. Eugenio Tiraborrelli, who died as a recluse at 82 years of age for a “crime” of solidarity Annamaria Rivera Macerata. It wasn’t a revenge, but an attempted slaughter.