Il Canto Di Giuseppina Turrisi Colonna
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Pacini, Parody and Il Pirata Alexander Weatherson
“Nell’orror di mie sciagure” Pacini, parody and Il pirata Alexander Weatherson Rivalry takes many often-disconcerting forms. In the closed and highly competitive world of the cartellone it could be bitter, occasionally desperate. Only in the hands of an inveterate tease could it be amusing. Or tragi-comic, which might in fact be a better description. That there was a huge gulf socially between Vincenzo Bellini and Giovanni Pacini is not in any doubt, the latter - in the wake of his highly publicised liaison with Pauline Bonaparte, sister of Napoleon - enjoyed the kind of notoriety that nowadays would earn him the constant attention of the media, he was a high-profile figure and positively reveled in this status. Musically too there was a gulf. On the stage since his sixteenth year he was also an exceptionally experienced composer who had enjoyed collaboration with, and the confidence of, Rossini. No further professional accolade would have been necessary during the early decades of the nineteenth century On 20 November 1826 - his account in his memoirs Le mie memorie artistiche1 is typically convoluted - Giovanni Pacini was escorted around the Conservatorio di S. Pietro a Majella of Naples by Niccolò Zingarelli the day after the resounding success of his Niobe, itself on the anniversary of the prima of his even more triumphant L’ultimo giorno di Pompei, both at the Real Teatro S.Carlo. In the Refettorio degli alunni he encountered Bellini for what seems to have been the first time2 among a crowd of other students who threw bottles and plates in the air in his honour.3 That the meeting between the concittadini did not go well, this enthusiasm notwithstanding, can be taken for granted. -

SPECIALE MURA POLIGONALI La Casa Editrice E.S.S
Rivista fondata da Luciano Pasquali Anno XXIV•N. 10/11/12•Ottobre/Novembre/Dicembre 2019 Mensile Tecnico Scientifico € 4,50 E.S.S. Editorial Service System In edicola 27 dicembre 2019 Sped. Abb. Post - D.L. 353/2003 Fondazione Dià Cultura (conv. In L. 27/02/2004 n.46) art.1 comma 1, Aut. N.C/RM/036/2010 SPECIALE MURA POLIGONALI La casa editrice E.S.S. Editorial Service System Srl e la Fondazione Dià Cultura presentano: Trame di storia Metodi e strumenti dellʼarcheologia sperimentale Archeofest 2017 a cura di Massimo Massussi, Sonia Tucci, Romina Laurito 17x24 cm, 408 pp., 25.00 euro ISBN 978-88-8444-194-2 1 2 Insieme per l’Archeologia Forma Urbis Media partner della Fondazione Dià Cultura. La Fondazione Dià Cultura collabora con System Graphic Srl alla realizzazione di Forma Urbis, di cui cura dal 2013 il piano editoriale, i contenuti scientifici e l’impianto grafico. Fondata nel 1995 con l’intento di far conoscere la Roma sotterranea e il mondo romano monumentale a un pubblico ampio, nel corso degli anni la rivista ha ampliato il suo piano editoriale ed è diventata un punto di riferimento anche per gli specialisti. www.formavrbis.com [email protected] [email protected] Fondazione Dià Cultura Siaed S.p.A. La Fondazione Dià Cultura realizza attività culturali e È l’azienda informatica che ha fondato e sostiene tutti i progetti di valorizzazione (tra cui RomArché – Il Salone progetti e le attività della Fondazione Dià Cultura. dell’Editoria Archeologica) con l’obiettivo di connettere Nata nel 1977, la Siaed pensa, sviluppa e realizza saperi e storie del passato al dibattito culturale soluzioni di gestione e processo inerenti il trasferimento contemporaneo. -

Seconda Sessione Di Vendita Sabato 26 Ottobre, Ore 15:00
GONNELLI CASA D’ASTE Seconda sessione di vendita Sabato 26 ottobre, ore 15:00 401. Chabert Joseph Bernard de Voyage fait par ordre du roi en 1750 et 1751, dans l’Amérique septentrionale, pour rectifier les cartes des côtes de l'Arcadie, de l'Isle Royale & de l'Isle de Terreneuve... A Paris: de l’Imprimerie royale, 1753. In-4° (mm 253x194). Pagine [2], VIII, 288, [12], con 1 tabella e 7 carte geografiche incise da Guillaume d’Heulland. Vignetta al frontespizio in xilografia. A carta A1 testatina incisa da I. D. Gobin, finalini in xilografia. Bruniture ad alcuni fascicoli, lievi fioriture sparse, tracce di tarlo restaurate a 7 carte, altro tarlo non restaurato a poche carte e al margine della prima tavola con carta geografica. Legatura in pelle marmorizzata, ampi decori e titolo entro tasselli in oro al dorso, con qualche forellino di tarlo. Tagli colorati di rosso e sguardie marmorizzate. Segnacolo in raso azzurro. Bell’esemplare con inserita lettera manoscritta dell’Autore con restauro. Sabin 11723: «Mr Chabert’s work is highly praised by the commission appointed by the French Academy of Science to examine it, and is recommended as a model to future navigators»; Dionne II, 489; Henze I, 536. € 2300 402. Chiminello Vincenzo Riflessioni su la verità di alcuni paradossi analitici... In Venezia: Nella Stamperia Graziosi, 1784. In-8° (mm 165x115). Pagine 72. Formule matematiche incise in legno nel testo. Lievissime arrossature sparse. Legatura muta in cartonato coevo. Nota di possesso manoscritta al frontespizio. € 150 403. Chénier André Les bucoliques. Publiées d’après le manuscrit original dans un ordre nouveau par José Maria de Heredia.. -

Lucia Di Lammermoor GAETANO DONIZETTI MARCH 3 – 11, 2012
O p e r a B o x Teacher’s Guide table of contents Welcome Letter . .1 Lesson Plan Unit Overview and Academic Standards . .2 Opera Box Content Checklist . .9 Reference/Tracking Guide . .10 Lesson Plans . .12 Synopsis and Musical Excerpts . .44 Flow Charts . .49 Gaetano Donizetti – a biography .............................56 Catalogue of Donizetti’s Operas . .58 Background Notes . .64 Salvadore Cammarano and the Romantic Libretto . .67 World Events in 1835 ....................................73 2011–2012 SEASON History of Opera ........................................76 History of Minnesota Opera, Repertoire . .87 così fan tutte WOLFGANG AMADEUS MOZART The Standard Repertory ...................................91 SEPTEMBER 25 –OCTOBER 2, 2011 Elements of Opera .......................................92 Glossary of Opera Terms ..................................96 silent night KEVIN PUTS Glossary of Musical Terms . .101 NOVEMBER 12 – 20, 2011 Bibliography, Discography, Videography . .105 werther Evaluation . .108 JULES MASSENET JANUARY 28 –FEBRUARY 5, 2012 Acknowledgements . .109 lucia di lammermoor GAETANO DONIZETTI MARCH 3 – 11, 2012 madame butterfly mnopera.org GIACOMO PUCCINI APRIL 14 – 22, 2012 FOR SEASON TICKETS, CALL 612.333.6669 620 North First Street, Minneapolis, MN 55401 Kevin Ramach, PRESIDENT AND GENERAL DIRECTOR Dale Johnson, ARTISTIC DIRECTOR Dear Educator, Thank you for using a Minnesota Opera Opera Box. This collection of material has been designed to help any educator to teach students about the beauty of opera. This collection of material includes audio and video recordings, scores, reference books and a Teacher’s Guide. The Teacher’s Guide includes Lesson Plans that have been designed around the materials found in the box and other easily obtained items. In addition, Lesson Plans have been aligned with State and National Standards. -

Live and Empoisoned by John Yohalem (Parterre.Com) | 8:49 Am | May 13, 2016
live and empoisoned by John Yohalem (parterre.com) | 8:49 am | May 13, 2016 In how many operas does the heroine drink poison and then go lengthily mad? OnlyTsar’s Bride comes to mind. But also: In this opera, the baritone is fought over by two adoring women. That happens to tenors all the time—and, in Mozart, to basses—but a baritone? Add characters named Morna and Wortimer, and if you’re not in a Harry Potter adventure and singers are warbling coloratura, you know it must be an obscure belcanto masterpiece. But whose? Donizetti wrote seventy and, admit it, you only know twenty of them. Mercadante wrote almost as many and you know even fewer. Verdi? Ridiculous. Rossini? Absurd. The Ricci brothers? No, face it, we are dealing with Malvina di Scozia by Giovanni Pacini. It was Pacini’s sad fate to compose eighty operas in the shadow of better-known men. He couldn’t dry up. It was an addiction. He pissed melody. And opera houses kept coming to him for new ones. Once, around the time of Bellini’s I Puritani, Pacini got so discouraged he took the pledge, no more opera, and kept it for nearly five years. But one fatal sip of melody, and there it was: a new one, Saffo, staggering upon the stage, and two busy decades followed. When he died, in 1867, at the age of 72, he had just premiered two new ones and was at work on a third. Pacini was born in 1795, in Catania (like Bellini) to a roving theatrical family (like Rossini) that encouraged his youthful talent. -

LE MIE MEMORIE ARTISTICHE Giovanni Pacini
LE MIE MEMORIE ARTISTICHE Giovanni Pacini English translation: Adriaan van der Tang, October 2011 1 2 GIOVANNI PACINI: LE MIE MEMORIE ARTISTICHE PREFACE Pacini’s autobiography Le mie memorie artistiche has been published in several editions. For the present translation the original text has been used, consisting of 148 pages and published in 1865 by G.G. Guidi. In 1872 E. Sinimberghi in Rome published Le mie memorie artistiche di Giovanni Pacini, continuate dall’avvocato Filippo Cicconetti. The edition usually referred to was published in 1875 by Le Monnier in Florence under the title Le mie memorie artistiche: edite ed inedite, edited by Ferdinando Magnani. The first 127 pages contain the complete text of the original edition of 1865 – albeit with a different page numbering – extended with the section ‘inedite’ of 96 pages, containing notes Pacini made after publication of the 1865-edition, beginning with three ‘omissioni’. This 1875- edition covers the years as from 1864 and describes Pacini’s involvement with performances of some of his operas in several minor Italian theatres. His intensive supervision at the first performances in 1867 of Don Diego di Mendoza and Berta di Varnol was described as well, as were the executions of several of his cantatas, among which the cantata Pacini wrote for the unveiling of the Rossini- monument in Pesaro, his oratorios, masses and instrumental works. Furthermore he wrote about the countless initiatives he developed, such as the repatriation of Bellini’s remains to Catania and the erection of a monument in Arezzo in honour of the great poet Guido Monaco, much adored by him. -

Yes, Virginia, Another Ballo Tragico: the National Library of Portugal’S Ballet D’Action Libretti from the First Half of the Nineteenth Century
YES, VIRGINIA, ANOTHER BALLO TRAGICO: THE NATIONAL LIBRARY OF PORTUGAL’S BALLET D’ACTION LIBRETTI FROM THE FIRST HALF OF THE NINETEENTH CENTURY DISSERTATION Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy in the Graduate School of The Ohio State University By Ligia Ravenna Pinheiro, M.F.A., M.A., B.F.A. Graduate Program in Dance Studies The Ohio State University 2015 Dissertation Committee: Karen Eliot, Adviser Nena Couch Susan Petry Angelika Gerbes Copyright by Ligia Ravenna Pinheiro 2015 ABSTRACT The Real Theatro de São Carlos de Lisboa employed Italian choreographers from its inauguration in 1793 to the middle of the nineteenth century. Many libretti for the ballets produced for the S. Carlos Theater have survived and are now housed in the National Library of Portugal. This dissertation focuses on the narratives of the libretti in this collection, and their importance as documentation of ballets of the late eighteenth and early nineteenth centuries, from the inauguration of the S. Carlos Theater in 1793 to 1850. This period of dance history, which has not received much attention by dance scholars, links the earlier baroque dance era of the eighteenth century with the style of ballet of the 1830s to the 1850s. Portugal had been associated with Italian art and artists since the beginning of the eighteenth century. This artistic relationship continued through the final decades of the eighteenth and the first half of the nineteenth century. The majority of the choreographers working in Lisbon were Italian, and the works they created for the S. Carlos Theater followed the Italian style of ballet d’action. -

From the Glicibarifono to the Bass Clarinet.Pdf
From the Glicibarifono to the Bass Clarinet: A Chapter in the History of Orchestration in Italy* Fabrizio Della Seta From the very beginnings of opera, the work of the theatre composer was carried out in close contact with, if not founded upon, the performer. At least until half-way through the nineteenth century, a composer would be judged in large part on his ability to make best use of the vocal resources of the singers for whom he was writing in a given season, to model his music on their individual qualities in the same way as (in terms of an often- repeated image) a tailor models the suit to the contours of his client's body, or (to use a more noble comparison) as a sculptor exploits the particular material characteristics of a block of marble. Even Verdi at the time of his greatest prestige, when he was in a position to impose his dramatic ideas in an almost dictatorial manner, drew inspiration from the abilities of respected performers, e.g. from Teresa Stolz for Aida or Giuseppina Pasqua for Falstaff. To a less decisive extent, but according to a concept similar in every respect, the same principle had been applied to the instrumental aspect of opera since the early decades of the eighteenth century, when the orchestra began to assume growing importance in the structure of a work. Often the presence in the theatre orchestra of a gifted instrumentalist would lead the composer to assign to him a prominent solo, almost always as if competing with voice as an obbligato part, and there were cases in which instrumentalist and composer coincided, as happened in certain operas by Handel. -

Parola Scenica: Towards Realism in Italian Opera Etdhendrik Johannes Paulus Du Plessis
Parola Scenica: Towards Realism in Italian Opera ETDHendrik Johannes Paulus du Plessis A thesis submitted to the Faculty of Arts, University of the Witwatersrand, Johannesburg, in fulfilment of the requirements for the degree of PhD by Thesis Abstract This thesis attempts to describe the emergence of a realistic writing style in nine- teenth-century Italian opera of which Giuseppe Verdi was the primary architect. Frequently reinforced by a realistic musico-linguistic device that Verdi would call parola scenica, the object of this realism is a musical syntax in which nei- ther the dramatic intent of the text nor the purely musical intent overwhelms the other. For Verdi the dramatically effective depiction of a ‘slice of a particular life’—a realist theatrical notion—is more important than the mere mimetic description of the words in musical terms—a romantic theatrical notion in line with opera seria. Besides studying the device of parola scenica in Verdi’s work, I also attempt to cast light on its impact on the output of his peers and successors. Likewise, this study investigates how the device, by definition texted, impacts on the orchestra as a means of realist narrative. My work is directed at explaining how these changes in mood of thought were instrumental in effecting the gradual replacement of the bel canto singing style typical of the opera seria of Rossini, Donizetti, and Bellini, by the school of thought of verismo, as exemplified by Verdi’s experiments. Besides the work of Verdi and the early nineteenth-cen- tury Italian operatic Romanticists, I touch also briefly on the œuvres of Puccini, ETDGiordano and the other veristi. -

Territori 25.Pdf
Quadrimestrale dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Frosinone Reg. Tribunale di Viterbo n. 408 del 31/05/1994 maggio-dicembre 2011 - anno XVIII - n. 25 SOMMARIO EDITORIALE In copertina: Maurizio Gattabuia, I viaggi nelle città del Lazio fondate da Saturno progetto per l’asse Casilina Direttore responsabile La scrittura di viaggio di Marianna Dionigi Giovanni Fontana pag. 2 Giovanni Fontana Comitato Scientifico Redazionale Daniele Baldassarre L’ARCHITETTURA E LA STORIA Luigi Bevacqua Francesco Maria De Angelis Antonio Provenzano Architetto Alessandra Digoni Razionalità del progetto e monumentalità delle forme, Giovanni Fontana Wilma Laurella attitudine urbana dell’architettura e interpretazione Stefano Manlio Mancini stilistica della tradizione costruttiva dei luoghi Francesco Cianfarani pag. Giorgios Papaevangeliu 4 Maurizio Pofi Alessandro M. Tarquini SPAZIO E PROGETTO Massimo Terzini Responsabile Dipartimento Informazione e Comunicazione L’asse Casilina Francesco Maria De Angelis Linee guida allo schema preliminare Maurizio Gattabuia pag. 12 Segreteria di redazione Antonietta Droghei Sandro Lombardi OGGETTI - TEORIA E TECNICA DEL DESIGN Impaginazione e grafica Giovanni D’Amico Glocal Handmade Coordinamento pubblicità Quando il design diventa strumento di marketing D’Amico Graphic Studio 03100 Frosinone - via Marittima, 225 territoriale per il rilancio dell’artigianato e del made in Italy Paolo Emilio Bellisario pag. 18 tel. e fax 0775.202221 e-mail: [email protected] Stampa TESI DI LAUREA Tipografia Editrice Frusinate 03100 Frosinone - via Tiburtina, 123 Recupero e valorizzazione della chiesa e della piazza San Michele ad Anagni Maria Claudia Nardoni pag. 25 ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA MOSTRE DI FROSINONE Presidente: Bruno Marzilli Castellinaria. Sui disegni di Alessandro Tarquini Vice Presidente: Alessandro Tarquini Brevi annotazioni di un ammiratore di passaggio Massimo Terzini pag. -
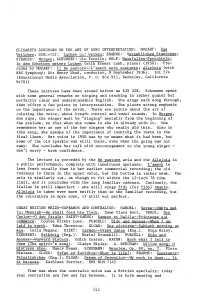
ARSC Journal
ELISABETH SCHU}~.NN ON THE ART OF SONG INTERPRETATION: MOZART: Das Veilchen; SCHLiF::rr: Lachen unc~ weinen; BRAHMS: Vergebliches Standchen; STRAUSS: Morgen; SCHUBERT: Die Forelle; WOLF: Mausfallen-Spruchlein; In dem Schetteil°meiner Locken (with Ernest Lush, piano) (1950). Pre ceded by MOZART: Il Re pastore--L'amero sero costante; Alleluia (with BBC Symphony; Sir Henry Wood, conductor, 8 September 1936). IGI 274 (Educational Media Association, P. 0. Box 921, Berkeley, California 94701) These lectures have been around before as EJS 328. Schumann opens with some general remarks on singing and teaching in rather quaint but perfectly clear and understandable English. She sings each song through, then offers a few points on interpretation. She places strong emphasis on the importance of the words. There are points about the art of coloring the voice, about breath control and vowel sounds. In Morgen, she says, the singer must be "singing" mentally from the beginning of the prelude, so that when she comes in she is already with it. One remembers her as one of the few singers who really did this. Also in this song, she speaks of the importance of counting the rests in the final lines. Her voice in 1950 was by no means what it had been, but some of the old sparkle was still there, even when the going was not easy. She concludes her talk with encouragement to the young singer - don't worry - have confidence. The lecture is preceded by the Re pastore aria and the Alleluia in a public performance, complete with tumultuous applause. L'amero is less fresh vocally than in her earlier commercial recording; the old radiance is there in the upper voice, but the bottom is rather weak. -

The Journal of John Waldie Theatre Commentaries, 1799-1830
UCLA The Journal of John Waldie Theatre Commentaries, 1799-1830 Title The Journal of John Waldie Theatre Commentaries, 1799-1830: no. 32 [Journal 45] December 1, 1819-May 23, 1820 Permalink https://escholarship.org/uc/item/337260v6 Author Burwick, Frederick Publication Date 2008-06-18 eScholarship.org Powered by the California Digital Library University of California [Box4] no.32 [ Journal 45] December 1, 1819-May 23, 1820. Travels in France, Spain, Germany, 1818-1820 (vol.4). Waldie: tXLV Travels in France, Spain, Italy, and Germany in the years 1818, 1819, and 1820 Vol. 4th. tXLV, 6 [ 6. December. 1819 ] Rome ... went with Captain Gordon and Mr. Pell and 2 others to Canova's Studio.... Canova and I had much talk as the rest do not speak Italian. We saw all the beauties of his Studio again -- the 2 dancing Nymphs, the Venus's, the Magdalen, and at the other Studio the equestrian statue of Charles 3d of Naples, changed from that of Napoleon. He is soon to make one of Ferdinand. These are not his forte. The group of the Centaur is very fine, and Washington a noble figure. In the evening I went to Rufini's music. ... The music was better than last week. La Tresmondi was in better voice and there was a good tXLV, 7 flute and violin and bass trio, and 2 harp pieces by the Marchesa Moroni -- some fine tros by Mayer. tXLV, 11 [ 11. December. 1819 ] ... We went next to the Studio of Thorwaldsen, who is now in Denmark -- he is making the whole frieze of Alexander's triumphs for the Count Sommariva in marble -- it will be the most beautiful bas relief as well as the longest in the world.