I Processi Formativi Ed Evolutivi Della Città in Area Adriatica
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Umbria from the Iron Age to the Augustan Era
UMBRIA FROM THE IRON AGE TO THE AUGUSTAN ERA PhD Guy Jolyon Bradley University College London BieC ILONOIK.] ProQuest Number: 10055445 All rights reserved INFORMATION TO ALL USERS The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted. In the unlikely event that the author did not send a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if material had to be removed, a note will indicate the deletion. uest. ProQuest 10055445 Published by ProQuest LLC(2016). Copyright of the Dissertation is held by the Author. All rights reserved. This work is protected against unauthorized copying under Title 17, United States Code. Microform Edition © ProQuest LLC. ProQuest LLC 789 East Eisenhower Parkway P.O. Box 1346 Ann Arbor, Ml 48106-1346 Abstract This thesis compares Umbria before and after the Roman conquest in order to assess the impact of the imposition of Roman control over this area of central Italy. There are four sections specifically on Umbria and two more general chapters of introduction and conclusion. The introductory chapter examines the most important issues for the history of the Italian regions in this period and the extent to which they are relevant to Umbria, given the type of evidence that survives. The chapter focuses on the concept of state formation, and the information about it provided by evidence for urbanisation, coinage, and the creation of treaties. The second chapter looks at the archaeological and other available evidence for the history of Umbria before the Roman conquest, and maps the beginnings of the formation of the state through the growth in social complexity, urbanisation and the emergence of cult places. -

Discovery Marche.Pdf
the MARCHE region Discovering VADEMECUM FOR THE TOURIST OF THE THIRD MILLENNIUM Discovering THE MARCHE REGION MARCHE Italy’s Land of Infinite Discovery the MARCHE region “...For me the Marche is the East, the Orient, the sun that comes at dawn, the light in Urbino in Summer...” Discovering Mario Luzi (Poet, 1914-2005) Overlooking the Adriatic Sea in the centre of Italy, with slightly more than a million and a half inhabitants spread among its five provinces of Ancona, the regional seat, Pesaro and Urbino, Macerata, Fermo and Ascoli Piceno, with just one in four of its municipalities containing more than five thousand residents, the Marche, which has always been Italyʼs “Gateway to the East”, is the countryʼs only region with a plural name. Featuring the mountains of the Apennine chain, which gently slope towards the sea along parallel val- leys, the region is set apart by its rare beauty and noteworthy figures such as Giacomo Leopardi, Raphael, Giovan Battista Pergolesi, Gioachino Rossini, Gaspare Spontini, Father Matteo Ricci and Frederick II, all of whom were born here. This guidebook is meant to acquaint tourists of the third millennium with the most important features of our terri- tory, convincing them to come and visit Marche. Discovering the Marche means taking a path in search of beauty; discovering the Marche means getting to know a land of excellence, close at hand and just waiting to be enjoyed. Discovering the Marche means discovering a region where both culture and the environment are very much a part of the Made in Marche brand. 3 GEOGRAPHY On one side the Apen nines, THE CLIMATE od for beach tourism is July on the other the Adriatic The regionʼs climate is as and August. -

Frank Vermeulen Review Of: Michele Silani, 2017
GROMAdocumenting archaeology | dept. of history and cultures, university of bologna Open-Access E-Journal about methodology applied to archaeology http://groma.unibo.it Frank Vermeulen Review of: Michele Silani, 2017. “Città e terri- torio: la formazione della città romana nell’ager Gallicus” Volume 3-2018 ISSN: 1825-411X pp. 1-14 Publisher: BraDypUS [http://books.bradypus.net] Publication date: 27/12/2018 License: CC BY-NC-ND 4.0 International Section: Book review FRANK VERMEULEN Review of: Michele Silani, 2017. “Città e territorio: la formazione della città romana nell’ager Gallicus” This well written study on the formation of Roman towns in northern Marche, is crucial for our understanding of the colonisation and rule by Rome of the so-called ager Gallicus, between the con- quest in 295 BC and the reign of Augustus. As I have underlined in a recent volume that approaches the same subject for the somewhat wider central Adriatic region of Italy (F. Vermeulen, From the Mountains to the Sea. The Roman Colonisation and Urbanisation of Central Adriatic Italy, 2017) the book by Silani is a successful attempt to describe and analyse the formation and growth of towns in this still somewhat under-studied area of central Italy. The young scholar contributes significantly to a better understanding of the lasting Roman impact on conquered societies in this area south of the fertile Po plain, squeezed between the Apennines, the Adriatic and the area of the focal maritime harbour of Ancona. The first phase of Romanisation especially, coinciding with the later centuries of the Republic (third to first centuries BC), and culminating in the reign of Augustus, is essential to deciphering forms of transmission, assimilation and cultural integration. -

The Slave Systems of Greek and Roman Antiquity
THE SLAVE SYSTEMS OF GREEK AND ROMAN ANTIQUITY WILLIAM L. WESTERMANN THE SLAVE SYSTEMS OF GREEK AND ROMAN ANTIQUITY Memoirs of the AMERICAN PHILOSOPHICAL SOCIETY Held at Philadelphia for Promoting Useful Knowledge Volume 40 THE SLAVE SYSTEMS OF GREEK AND ROMAN ANTIQUITY WILLIAM L. WESTERMANN Professor Emeritus of History Columbia University THE AMERICAN PHILOSOPHICAL SOCIETY INDEPENDENCE SQUARE PHILADELPHIA 1955 Copyright 1955 by the American Philosophical Society Library of Congress Catalog Card No. 54-9107 ISBN 0-87169-040-3 Reprinted 1984 TO THE MEMORY OF MICHAEL IVANOVICH ROSTOVTZEFF CONTENTS PAGE Prefatory Statement and Acknowledgments xi Abbreviations xi I. Greek Slavery from Homer to the Persian Wars 1 II. From the Persian Wars to Alexander. Slave Supply and Slave Numbers 5 III. From the Persian Wars to Alexander. Slave Employment and Legal Aspects of Slavery . 12 IV. From the Persian Wars to Alexander. The Social Setting of Polis Slavery 22 V. The Eastern Mediterranean Lands from Alexander to Augustus. Recruitment of Slaves and Numbers 28 VI. The Eastern Mediterranean Lands from Alexander to Augustus. The Delphic Manumissions: Slave Origins, Economic and Legal Approaches 34 VII. The Eastern Area from Alexander to Augustus. Basic Differences Between Pre-Greek and Greek Slavery 39 VIII. Slavery in Hellenistic Egypt. Pharaonic Tradition and Greek Intrusions 46 IX. War and Slavery in the West to 146 B. C 57 X. The Roman Republic. Praedial Slavery, Piracy, and Slave Revolts 63 XI. The Later Republic. The Slave and the Roman Familia 69 XII. The Later Republic. Social and Legal Position of Slaves 77 XIII. Slavery Under the Roman Empire to Constantine the Great. -

Il Buon Vino Sanseverinate Dei Tempi Passati
Raoul Paciaroni IL BUON VINO SANSEVERINATE DEI TEMPI PASSATI Raoul Paciaroni Il buon vino sanseverinate dei tempi passati Sanseverino Marche 2012 Testo edito in Proposte e ricerche. Economia e società nella storia dell’Italia centrale anno XXVI, n. 51 (estate/autunno 2003), pp. 99-110. Si ringrazia la Direzione della Rivista per il permesso di riproduzione. Ristampa a cura dell’Azienda Vinicola Fattoria Colmone della Marca Località Colmone, San Severino Marche, Macerata, Italia tel e fax +39 0733 637944 www.fattoriacolmone.it - [email protected] In copertina: Storie di San Giovanni Battista(particolare) Affresco di Lorenzo e Jacopo Salimbeni (1416) Urbino, Oratorio di San Giovanni Battista. Realizzazione grafica e impaginazione: Lorenzo Paciaroni | www.lorenzopaciaroni.com Stampato in Italia nel mese di Luglio 2012. Il territorio collinare del Comune di Sanseverino, posto geograficamente al centro delle Marche, è stato sempre tra le zone più felici per il prosperare rigoglioso della vite e per la produzione di uva delle migliori qualità. Il vino di Sanseverino aveva nei secoli trascorsi una notevole rinomanza1 che è andata man mano sce- mando ed oggi, nonostante i suoi meriti, è pochissimo conosciuto essendo mancata per esso quella propaganda di cui altri in- vece si sono avvalsi per acquistare fama e successo. Gettiamo perciò uno sguardo su questo delizioso prodotto della nostra terra per vedere come era considerato nel passato. I documenti e le memorie storiche offrono interessanti e molteplici riferimenti in proposito. Le carte più antiche dei nostri ar- chivi ricordano solo due qualità di vini che venivano qui prodotti: il trebbiano e il vizzago. Il 19 aprile 1349 il Consiglio Generale e di Credenza, affinché il vino potesse trovarsi sempre disponibile e in abbondanza nella città, stabilì che per il futuro ogni sanseverinate potesse liberamente vendere vino trebbiano, purché il prezzo di un «petictus» (boccale) non avesse superato i diciotto denari. -

Identification of Suitable Sites for Burial of Animal Carcasses in The
ACTA SCIENTIFIC AGRICULTURE (ISSN: 2581-365X) Volume 3 Issue 4 April 2019 Research Article Identification of Suitable Sites for Burial of Animal Carcasses in the Province of Macerata Matteo Gentilucci* School of Science and Technology, University of Camerino, Italy *Corresponding Author: Received: MatteoPublished: Gentilucci, School of Science and Technology, University of Camerino, Italy. January 17, 2019; March 08, 2019 Abstract This study aims to solve the problem of the disposal of animal carcasses, firstly through a provincial-based analysis (province of Macerata) to introduce a new landfill suitable for this purpose, while secondly very small sites have been analysed to ensure a possi- ble emergency solution. In addition to the legal constraints, further analyses based on the morphology of the territory and the climate have been introduced in order to avoid any risk to the environment. In addition, the innovation of this research also passes through the extensive use of geographical information systems that have allowed the spatialization of constraints, climate analysis using ge- ostatisticalKeywords: techniques, topographic survey and the screening of the intervisibility. Burial; Animal; Environment; Climate Introduction a further issue will be examined concerning the identification of The disposal of animal carcasses is very costly and difficult for micro-sites, treated as mini-dumps (due to the reduced territorial operators in the Province of Macerata, given the lack of facilities extension and the much lower quantity of material hosted), which for this service within the Marche Region; in this context, it is should be identified in areas where disposal becomes more one- important to set up a system to ensure hygiene and profitability, rous and difficult, depending on the harsh morphology and the in order to prevent uncontrolled burial or, even more seriously, significant extension of the mountain territory of Macerata provin- abandonment of carcasses directly on pastureland, guaranteeing ce. -
© in This Web Service Cambridge University
Cambridge University Press 978-1-107-01318-6 - Peasants, Citizens and Soldiers: Studies in the Demographic History of Roman Italy 225 BC–AD 100 Luuk De Ligt Index More information Index Abella, 310 Allifae, 310 Abellinum (Campania), 310 Alsium, 320 Abellinum Marsicum, 329 Altinum, 265, 289 Acelum, 298 Ameria, 315 Acerrae, 311 Amiternum, 323 Aceruntia, 334 Amitinum, 320 Acherusia, 334 Anagnia, 306 Aecae, 329 Ancona, 312 Aeclanum, 329 Angera, 265 Aegetium, 329 Angitia, 325 Aemilia, 264; viritane settlers, 81, 131; population Angulum, 324 in 28 bc, 195, 224 Anxa, 325 Aesernia, 324 Anxa (Callipolis), 330 aes equestre, 84 Anxanum, 325 aes hordiarium, 84 Antinum, 324 Aesis, 316 Antium, 260, 304 Affilae, 306 Antonine Plague, 2, 13 age at first marriage, 3, 144–9, 159, 166 Apama, 330 age groups, in Roman armies, 55–6, 83, 145, 166;in Appian, on background to Gracchan crisis, 158–9, Greek armies, 56–7; see also iuniores, seniores 164, 167–9, 178, 181, 192 Ager Brundisinus, 266 Aprusta, 334 Ager Caeretanus, 271 Apulia, confiscations after 201 bc, 131; viritane Ager Cosanus, 259, 267, 281; see also Albegna settlers, 81; decline of pre-Roman towns, 229, Valley Survey 262; evidence of population decline, 262–3; ager publicus, 158–9, 185–7 realignment of settlement system, 262; shape of Ager Tiburtinus, 272 urban network, 235–6; see also Brundisium agro-towns, 230, 266 Apulians, 68; anomalous ratio between horse Alba Fucens, 323 and foot in Polybius, 42, 67; manpower Alba Longa, 306 resources, 70 Alba Pompeia, 293 Aquae Statiellae, 293 Albegna Valley Survey, -
![An Atlas of Antient [I.E. Ancient] Geography](https://docslib.b-cdn.net/cover/8605/an-atlas-of-antient-i-e-ancient-geography-1938605.webp)
An Atlas of Antient [I.E. Ancient] Geography
'V»V\ 'X/'N^X^fX -V JV^V-V JV or A?/rfn!JyJ &EO&!AElcr K T \ ^JSlS LIBRARY OF WELLES LEY COLLEGE PRESENTED BY Ruth Campbell '27 V Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from Boston Library Consortium Member Libraries http://www.archive.org/details/atlasofantientieOObutl AN ATLAS OP ANTIENT GEOGRAPHY BY SAMUEL BUTLER, D.D. AUTHOR OF MODERN AND ANTJENT GEOGRAPHY FOR THE USE OF SCHOOLS. STEREOTYPED BY J. HOWE. PHILADELPHIA: BLANQHARD AND LEA. 1851. G- PREFATORY NOTE INDEX OF DR. BUTLER'S ANTIENT ATLAS. It is to be observed in this Index, which is made for the sake of complete and easy refer- ence to the Maps, that the Latitude and Longitude of Rivers, and names of Countries, are given from the points where their names happen to be written in the Map, and not from any- remarkable point, such as their source or embouchure. The same River, Mountain, or City &c, occurs in different Maps, but is only mentioned once in the Index, except very large Rivers, the names of which are sometimes repeated in the Maps of the different countries to which they belong. The quantity of the places mentioned has been ascertained, as far as was in the Author's power, with great labor, by reference to the actual authorities, either Greek prose writers, (who often, by the help of a long vowel, a diphthong, or even an accent, afford a clue to this,) or to the Greek and Latin poets, without at all trusting to the attempts at marking the quantity in more recent works, experience having shown that they are extremely erroneous. -

Mama Box for Your Stay Marca Maceratese in the Marca Maceratese Mama Box Marca Maceratese
A box of ideas MaMa Box for your stay Marca Maceratese in the Marca Maceratese MaMa Box Marca Maceratese A box of ideas for your stay in the Marca Maceratese Lago di Fiastra - photo by Federica Baldi 2 Index Guide to MaMa box ................................ 7 Thematic areas ................................ 8 Marca Maceratese Portal ...............................11 MaMa in blue .............................. 13 The sea ................................. 14 MaMa sea ................................. 20 Water parks ................................. 25 Thermal baths ................................. 26 MaMa’s tips ................................. 27 Web experiences ................................. 28 Gentle hills and ancient villages .............................. 31 The most beautiful villages of Italy ................................. 32 / i"À>}iy>}ð°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°{x -«iÃ>`Àiiy>}ð°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°{n The ancient villages ................................. 54 Fortresses and towers ................................. 58 MaMa’s tidbits ................................. 64 MaMa’s tips ................................. 69 Web experiences ................................. 70 MaMa mia what a show! .............................. 73 Mountain, parks, sports and active nature .............................. 97 National Park of Sibillini Mountains ................................. 98 Centres of Environmental Education ................................100 Natural reserves ................................102 Lakes ................................104 -
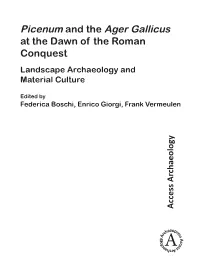
Picenum and the Ager Gallicus at the Dawn of the Roman Conquest
Picenum and the Ager Gallicus at the Dawn of the Roman Conquest Landscape Archaeology and Material Culture Edited by Federica Boschi, Enrico Giorgi, Frank Vermeulen Access Archaeology aeopr ch es r s A A y c g c e o l s o s e A a r c Ah Archaeopress Publishing Ltd Summertown Pavilion 18-24 Middle Way Summertown Oxford OX2 7LG www.archaeopress.com ISBN 978-1-78969-699-8 ISBN 978-1-78969-700-1 (e-Pdf) © the individual authors and Archaeopress 2020 Cover: View of the Tronto Valley in the heart of the ancient Picenum. Drawing by Giorgio Giorgi. All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying or otherwise, without the prior written permission of the copyright owners. This book is available direct from Archaeopress or from our website www.archaeopress.com Picenum and the Ager Gallicus at the Dawn of the Roman Conquest. Landscape Archaeology and Material Culture Federica Boschi, Enrico Giorgi, Frank Vermeulen (eds.) Contents Introduction - F. Boschi, E. Giorgi, F. Vermeulen I. P. Attema, Data integration and comparison in landscape archaeology: towards analysis beyond sites and valleys II. A. Gamberini, P. Cossentino, S. Morsiani, Romanization dynamics through the material culture analysis in the Ager Gallicus et Picenum III. O. Mei, L. Cariddi, Forum Sempronii and the Romanization of the Metauro Valley IV. F. Boschi, Methodological approaches to the study of the Cesano and Misa River Valleys (2010- 2020). New data: some thoughts and perspectives V. -

Una Vez Más Sobre Tuscilius Nominatus Y Ricina (C.I.L. Ix 5746) *
MARC MAYER I OLIVÉ UNA VEZ MÁS SOBRE TUSCILIUS NOMINATUS Y RICINA (C.I.L. IX 5746) * La inscripción que recuerda un beneficio de Trajano a Ricina , hoy Villa Potenza, que forma parte del municipio de Macerata, ha sido recien - temente objeto de un trabajo en estas mismas páginas 1 y de importantes consideraciones en razón del beneficium imperial que representó para esta ciudad 2. Creemos, sin embargo, que puede resultar interesante proponer algunas precisiones sobre cuál pudo ser la causa o, por lo menos, sobre qué fundamentos jurídicos pudo basarse la concesión del emperador que do - cumenta dicha inscripción 3 (Fig. 1) : * El presente trabajo ha sido realizado en el ámbito del proyecto FFF2011-25113 y del Grup de Recerca Consolidat 2009SGR1254. 1 M. M AYER , Documentos sobre beneficia imperiales e intervenciones privadas en algu - nas ciudades de las regiones V y VI durante el siglo II d.C.: Ricina, Tifernum Tiberinum y Tu - ficum: ¿ejemplos de un procedimiento?, in «Picus» XXIII (2013), pp. 129-143, esp. pp. 131-138. 2 G. P ACI , Sovvenzioni imperiali alle città picene in crisi nel II secolo d.C., in Atti del XLI Convegno di Studi Maceratesi. Abbadia di Fiastra (Tolentino) 26-27 novembre 2005 , Pol - lenza 2007, pp. 41-64, esp. pp. 58-59. 3 C.I.L. IX 5746 = I.L.S. 05675, conservado en el Palazzo Comunale di Macerata; cfr. G. P ACI , Le iscrizioni latine di età imperiale , en L. G ASPERINI - G. P ACI - R. A VESANI - M. M ODENA MAYER , Il lapidario del Palazzo Comunale di Macerata , in «Ann. -

Rankings Municipality of Castelleone Di Suasa
9/30/2021 Maps, analysis and statistics about the resident population Demographic balance, population and familiy trends, age classes and average age, civil status and foreigners Skip Navigation Links ITALIA / Marche / Province of Ancona / Castelleone di Suasa Powered by Page 1 L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Adminstat logo DEMOGRAPHY ECONOMY RANKINGS SEARCH ITALIA Municipalities Powered by Page 2 Agugliano Stroll up beside >> L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Falconara AdminstatAncona logo Marittima DEMOGRAPHY ECONOMY RANKINGS SEARCH Arcevia ITALIA Filottrano Barbara Genga Belvedere Jesi Ostrense Loreto Camerano Maiolati Camerata Spontini Picena Mergo Castelbellino Monsano Castelfidardo Monte Roberto Castelleone di Suasa Monte San Vito Castelplanio Montecarotto Cerreto d'Esi Montemarciano Chiaravalle Morro d'Alba Corinaldo Numana Cupramontana Offagna Fabriano Osimo Ostra Ostra Vetere Poggio San Marcello Polverigi Rosora San Marcello San Paolo di Jesi Santa Maria Nuova Sassoferrato Senigallia Serra de' Conti Serra San Quirico Sirolo Staffolo Powered by Page 3 Trecastelli L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Provinces Adminstat logo DEMOGRAPHY ECONOMY RANKINGS SEARCH ANCONA FERMOITALIA ASCOLI PICENO MACERATA PESARO E URBINO Regions Abruzzo Liguria Basilicata Lombardia Calabria Marche Campania Molise Città del Piemonte Vaticano Puglia Emilia-Romagna Repubblica di Friuli-Venezia San Marino Giulia Sardegna Lazio Sicilia Toscana Trentino-Alto Adige/Südtirol Umbria Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste Veneto Municipality