ALLEGATO B Foto 1
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Umbria from the Iron Age to the Augustan Era
UMBRIA FROM THE IRON AGE TO THE AUGUSTAN ERA PhD Guy Jolyon Bradley University College London BieC ILONOIK.] ProQuest Number: 10055445 All rights reserved INFORMATION TO ALL USERS The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted. In the unlikely event that the author did not send a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if material had to be removed, a note will indicate the deletion. uest. ProQuest 10055445 Published by ProQuest LLC(2016). Copyright of the Dissertation is held by the Author. All rights reserved. This work is protected against unauthorized copying under Title 17, United States Code. Microform Edition © ProQuest LLC. ProQuest LLC 789 East Eisenhower Parkway P.O. Box 1346 Ann Arbor, Ml 48106-1346 Abstract This thesis compares Umbria before and after the Roman conquest in order to assess the impact of the imposition of Roman control over this area of central Italy. There are four sections specifically on Umbria and two more general chapters of introduction and conclusion. The introductory chapter examines the most important issues for the history of the Italian regions in this period and the extent to which they are relevant to Umbria, given the type of evidence that survives. The chapter focuses on the concept of state formation, and the information about it provided by evidence for urbanisation, coinage, and the creation of treaties. The second chapter looks at the archaeological and other available evidence for the history of Umbria before the Roman conquest, and maps the beginnings of the formation of the state through the growth in social complexity, urbanisation and the emergence of cult places. -

Discovery Marche.Pdf
the MARCHE region Discovering VADEMECUM FOR THE TOURIST OF THE THIRD MILLENNIUM Discovering THE MARCHE REGION MARCHE Italy’s Land of Infinite Discovery the MARCHE region “...For me the Marche is the East, the Orient, the sun that comes at dawn, the light in Urbino in Summer...” Discovering Mario Luzi (Poet, 1914-2005) Overlooking the Adriatic Sea in the centre of Italy, with slightly more than a million and a half inhabitants spread among its five provinces of Ancona, the regional seat, Pesaro and Urbino, Macerata, Fermo and Ascoli Piceno, with just one in four of its municipalities containing more than five thousand residents, the Marche, which has always been Italyʼs “Gateway to the East”, is the countryʼs only region with a plural name. Featuring the mountains of the Apennine chain, which gently slope towards the sea along parallel val- leys, the region is set apart by its rare beauty and noteworthy figures such as Giacomo Leopardi, Raphael, Giovan Battista Pergolesi, Gioachino Rossini, Gaspare Spontini, Father Matteo Ricci and Frederick II, all of whom were born here. This guidebook is meant to acquaint tourists of the third millennium with the most important features of our terri- tory, convincing them to come and visit Marche. Discovering the Marche means taking a path in search of beauty; discovering the Marche means getting to know a land of excellence, close at hand and just waiting to be enjoyed. Discovering the Marche means discovering a region where both culture and the environment are very much a part of the Made in Marche brand. 3 GEOGRAPHY On one side the Apen nines, THE CLIMATE od for beach tourism is July on the other the Adriatic The regionʼs climate is as and August. -

Frank Vermeulen Review Of: Michele Silani, 2017
GROMAdocumenting archaeology | dept. of history and cultures, university of bologna Open-Access E-Journal about methodology applied to archaeology http://groma.unibo.it Frank Vermeulen Review of: Michele Silani, 2017. “Città e terri- torio: la formazione della città romana nell’ager Gallicus” Volume 3-2018 ISSN: 1825-411X pp. 1-14 Publisher: BraDypUS [http://books.bradypus.net] Publication date: 27/12/2018 License: CC BY-NC-ND 4.0 International Section: Book review FRANK VERMEULEN Review of: Michele Silani, 2017. “Città e territorio: la formazione della città romana nell’ager Gallicus” This well written study on the formation of Roman towns in northern Marche, is crucial for our understanding of the colonisation and rule by Rome of the so-called ager Gallicus, between the con- quest in 295 BC and the reign of Augustus. As I have underlined in a recent volume that approaches the same subject for the somewhat wider central Adriatic region of Italy (F. Vermeulen, From the Mountains to the Sea. The Roman Colonisation and Urbanisation of Central Adriatic Italy, 2017) the book by Silani is a successful attempt to describe and analyse the formation and growth of towns in this still somewhat under-studied area of central Italy. The young scholar contributes significantly to a better understanding of the lasting Roman impact on conquered societies in this area south of the fertile Po plain, squeezed between the Apennines, the Adriatic and the area of the focal maritime harbour of Ancona. The first phase of Romanisation especially, coinciding with the later centuries of the Republic (third to first centuries BC), and culminating in the reign of Augustus, is essential to deciphering forms of transmission, assimilation and cultural integration. -

The Slave Systems of Greek and Roman Antiquity
THE SLAVE SYSTEMS OF GREEK AND ROMAN ANTIQUITY WILLIAM L. WESTERMANN THE SLAVE SYSTEMS OF GREEK AND ROMAN ANTIQUITY Memoirs of the AMERICAN PHILOSOPHICAL SOCIETY Held at Philadelphia for Promoting Useful Knowledge Volume 40 THE SLAVE SYSTEMS OF GREEK AND ROMAN ANTIQUITY WILLIAM L. WESTERMANN Professor Emeritus of History Columbia University THE AMERICAN PHILOSOPHICAL SOCIETY INDEPENDENCE SQUARE PHILADELPHIA 1955 Copyright 1955 by the American Philosophical Society Library of Congress Catalog Card No. 54-9107 ISBN 0-87169-040-3 Reprinted 1984 TO THE MEMORY OF MICHAEL IVANOVICH ROSTOVTZEFF CONTENTS PAGE Prefatory Statement and Acknowledgments xi Abbreviations xi I. Greek Slavery from Homer to the Persian Wars 1 II. From the Persian Wars to Alexander. Slave Supply and Slave Numbers 5 III. From the Persian Wars to Alexander. Slave Employment and Legal Aspects of Slavery . 12 IV. From the Persian Wars to Alexander. The Social Setting of Polis Slavery 22 V. The Eastern Mediterranean Lands from Alexander to Augustus. Recruitment of Slaves and Numbers 28 VI. The Eastern Mediterranean Lands from Alexander to Augustus. The Delphic Manumissions: Slave Origins, Economic and Legal Approaches 34 VII. The Eastern Area from Alexander to Augustus. Basic Differences Between Pre-Greek and Greek Slavery 39 VIII. Slavery in Hellenistic Egypt. Pharaonic Tradition and Greek Intrusions 46 IX. War and Slavery in the West to 146 B. C 57 X. The Roman Republic. Praedial Slavery, Piracy, and Slave Revolts 63 XI. The Later Republic. The Slave and the Roman Familia 69 XII. The Later Republic. Social and Legal Position of Slaves 77 XIII. Slavery Under the Roman Empire to Constantine the Great. -
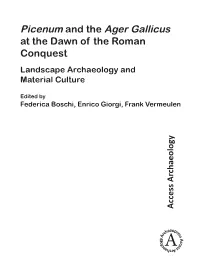
Picenum and the Ager Gallicus at the Dawn of the Roman Conquest
Picenum and the Ager Gallicus at the Dawn of the Roman Conquest Landscape Archaeology and Material Culture Edited by Federica Boschi, Enrico Giorgi, Frank Vermeulen Access Archaeology aeopr ch es r s A A y c g c e o l s o s e A a r c Ah Archaeopress Publishing Ltd Summertown Pavilion 18-24 Middle Way Summertown Oxford OX2 7LG www.archaeopress.com ISBN 978-1-78969-699-8 ISBN 978-1-78969-700-1 (e-Pdf) © the individual authors and Archaeopress 2020 Cover: View of the Tronto Valley in the heart of the ancient Picenum. Drawing by Giorgio Giorgi. All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying or otherwise, without the prior written permission of the copyright owners. This book is available direct from Archaeopress or from our website www.archaeopress.com Picenum and the Ager Gallicus at the Dawn of the Roman Conquest. Landscape Archaeology and Material Culture Federica Boschi, Enrico Giorgi, Frank Vermeulen (eds.) Contents Introduction - F. Boschi, E. Giorgi, F. Vermeulen I. P. Attema, Data integration and comparison in landscape archaeology: towards analysis beyond sites and valleys II. A. Gamberini, P. Cossentino, S. Morsiani, Romanization dynamics through the material culture analysis in the Ager Gallicus et Picenum III. O. Mei, L. Cariddi, Forum Sempronii and the Romanization of the Metauro Valley IV. F. Boschi, Methodological approaches to the study of the Cesano and Misa River Valleys (2010- 2020). New data: some thoughts and perspectives V. -

Rankings Municipality of Castelleone Di Suasa
9/30/2021 Maps, analysis and statistics about the resident population Demographic balance, population and familiy trends, age classes and average age, civil status and foreigners Skip Navigation Links ITALIA / Marche / Province of Ancona / Castelleone di Suasa Powered by Page 1 L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Adminstat logo DEMOGRAPHY ECONOMY RANKINGS SEARCH ITALIA Municipalities Powered by Page 2 Agugliano Stroll up beside >> L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Falconara AdminstatAncona logo Marittima DEMOGRAPHY ECONOMY RANKINGS SEARCH Arcevia ITALIA Filottrano Barbara Genga Belvedere Jesi Ostrense Loreto Camerano Maiolati Camerata Spontini Picena Mergo Castelbellino Monsano Castelfidardo Monte Roberto Castelleone di Suasa Monte San Vito Castelplanio Montecarotto Cerreto d'Esi Montemarciano Chiaravalle Morro d'Alba Corinaldo Numana Cupramontana Offagna Fabriano Osimo Ostra Ostra Vetere Poggio San Marcello Polverigi Rosora San Marcello San Paolo di Jesi Santa Maria Nuova Sassoferrato Senigallia Serra de' Conti Serra San Quirico Sirolo Staffolo Powered by Page 3 Trecastelli L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Provinces Adminstat logo DEMOGRAPHY ECONOMY RANKINGS SEARCH ANCONA FERMOITALIA ASCOLI PICENO MACERATA PESARO E URBINO Regions Abruzzo Liguria Basilicata Lombardia Calabria Marche Campania Molise Città del Piemonte Vaticano Puglia Emilia-Romagna Repubblica di Friuli-Venezia San Marino Giulia Sardegna Lazio Sicilia Toscana Trentino-Alto Adige/Südtirol Umbria Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste Veneto Municipality -

Problems of Implementation of Local Agenda 21 in Ancona (Italy): the Case of the “Peter Pan” Environmental Project*
Studi e Ricerche socio-territoriali Napoli, 2(2012), pp. 209-230 Problems of implementation of local Agenda 21 in Ancona (Italy): the case of the “Peter Pan” environmental project* Salvatore Cannizzaro** - Gian Luigi Corinto*** Riassunto La sostenibilità ha tre dimensioni, economica, ambientale e sociale, che sono distinte ma collegate tra loro, allo stesso livello di rilevanza. La dimen- sione sociale dà speciale importanza all’occupazione del lavoro, alle reti di sicurezza sociale, all’equità e alla partecipazione democratica nel processo de- cisionale. Il nostro lavoro mira a descrivere e valutare la rilevanza sociale di un’esperienza di Agenda 21 Locale, di un progetto ambientale, il Peter Pan (Progetto di Ecosviluppo del Territorio della Provincia di Ancona) adottato dalla Provincia di Ancona nelle Marche. A tale scopo abbiamo condotto una ricerca con metodo qualitativo, mediante interviste al personale coinvolto nella pianificazione e realizzazione del progetto. Nel mese di settembre 2010 sono state effettuate interviste ad amministratori pubblici, project manager e facili- tatori presso l’ufficio di Agenda 21 Locale di Ancona. I risultati principali della nostra ricerca consistono nella individuazione delle procedure democratiche per la pianificazione ecologica del territorio nella provincia di Ancona e del ruolo tenuto dagli uffici pubblici nell’incoraggiare la popolazione alla coscienza am- bientale e alla conseguente partecipazione al piano d’azione di sviluppo locale. Parole chiave: Agenda 21 Locale, ambiente, sviluppo sostenibile, caso studio, provincia di Ancona 1. Introduction Agenda 21 is the United Nations Action Plan to achieve global * Contributors: SC and GLC contributed to conception and design. SC wrote the 1, 2 and 7 paragraphs, GLC wrote the 3, 4, 5 and 6 paragraphs. -

Progetto Di Legge Della XIII Legislatura
Atti Parlamentari —1— Camera dei Deputati XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI N. 669 CAMERA DEI DEPUTATI — PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI SBARBATI, DUCA, GALDELLI, GASPERONI, GIACCO, LENTI, POLENTA, SGARBI Istituzione del Parco archeologico « Da Sentinum a Suasa » Presentata il 10 maggio 1996 ONOREVOLI COLLEGHI ! — La maggior parte invasori, si determino` l’abbandono defini- dei centri minori ma anche delle citta` delle tivo e l’esodo dei superstiti verso localita` Marche sorgono oggi su alture, poste lungo piu` sicure. i crinali che separano le vallate. Le strade A tale evoluzione non si sottrassero ne´ che collegano il settore appenninico alla Sentinum ne´ Suasa. costa tagliano i terreni di fondovalle che L’antica citta` romana di Sentinum sorge sono cosparsi di case coloniche e di paesi, nella prossimita` del punto d’incontro di tre che devono la loro origine e la loro espan- fiumi: il Sentino, la Marena e il Sangue- sione alla presenza della bisettrice di valle. rone. La stessa vallata del Sentino, proprio Questo tipo di distribuzione urbana e` pe- per la sua conformazione geografica, ha raltro piuttosto recente, non risalendo ol- favorito le comunicazioni tra i due versanti tre l’alto Medio Evo. dell’Appennino. In eta` romana, infatti, le citta` sorgevano Da Sentinum partivano anche strade in basso, sui terreni di fondovalle o lungo che univano la citta` con Attidium e Tufi- le strade che risalivano le vallate, mentre cum e, seguendo il corso dei fiumi Misa e sulle colline e sui crinali vi erano piccoli Cesano, con Suasa e Sena Gallica. villaggi o isolate fattorie. -

Vinum Picenum and Oliva Picena II Further Thoughts on Wine and Oil Presses in Central Adriatic Italy
BABESCH 94 (2019), 97-126. doi: 10.2143/BAB.94.0.3286781 Vinum picenum and oliva picena II Further Thoughts on Wine and Oil Presses in Central Adriatic Italy Dimitri Van Limbergen Abstract This paper is a continuation of a previous article by the author on Roman wine and oil production in central Marche and northern Abruzzo, published in this journal in 2011. In essence, it reflects on what five years of complementary research have contributed to our knowledge on the wine and oil business in this area between the Late Republican and the late antique period (2nd century BC-5th century AD). Through a substantial expan- sion of the original press database and a fresh blend of both older and newer data, the author further stresses the importance of this sector in central Adriatic Italy, while at the same time expanding our view on how it is represented archaeologically. In doing so, he revisits and refines several key-aspects of this topic, such as the chronology and layout of the production plants, as well as their relationship with wider processes of colonisation, urbanisation and agricultural exploitation in Roman Italy.* INTRODUCTION In a 2011 paper published in this journal, I set out This paper builds on this earlier work and aims to assess the role of wine and olive oil production at further deepening and expanding our knowl- in the agrarian economy of the Marche region edge on the wine and oil sector in this particular and northern Abruzzo in Late Republican and area of central Italy in Roman times. -

Scheda Progetto Per L'impiego Di Volontari In
SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE IN ITALIA Unpli SCN cod. Accr. UNSC NZ01922 Ufficio per il Servizio Civile Nazionale Via Provinciale, 88 - 83020 Contrada Av) ENTE 1) Ente proponente il progetto: UNPLI NAZIONALE 2) Codice di accreditamento: NZ01922 3) Albo e classe di iscrizione: NAZIONALE 1^ CARATTERISTICHE PROGETTO 4) Titolo del progetto: ALLA RISCOPERTA DELLE ACQUE MARCHIGIANE 5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3): SETTORE PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE D/03 – VALORIZZAZIONE STORIE E CULTURE LOCALI 1 6) Descrizione dell’area d’intervento e del contesto territoriale entro il quale si realizza il progetto con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori misurabili; identificazione dei destinatari e dei beneficiari del progetto: Sono interessate alla realizzazione del presente progetto le seguenti Pro Loco: PROVINCIA DI ANCONA 1. CASTELFIDARDO 2. “FELIX CIVITAS LAURETANA” LORETO 3. OSTRA 4. “SUASA” CASTELLEONE DI SUASA 5. SANTA MARIA NUOVA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO 6. COLLI DEL TRONTO PROVINCIA DI MACERATA 7. CASTELRAIMONDO 8. MORROVALLE 9. PIEVEBOVIGLIANA 10. PORTO RECANATI 11. TREIA PROVINCIA DI PESARO-URBINO 12. CARTOCETO 13. FERMIGNANO capofila del progetto 14. MOMBAROCCIO 15. MONDAVIO 16. SAN COSTANZO 17. SANTA MARIA DELL’ARZILLA La morfologia del territorio marchigiano, prevalentemente collinare e montuoso, ha consentito all‟uomo, sin dall‟antichità, di godere del bene prezioso che è l‟acqua e di sfruttarlo mediante la costruzione -

I Processi Formativi Ed Evolutivi Della Città in Area Adriatica
UNIVERSITÀ SISTEMA MUSEALE DEGLI STUDI DELLA PROVINCIA DI MACERATA DI MACERATA I processi formativi ed evolutivi della città in area adriatica A cura di G. de Marinis G.M. Fabrini G. Paci R. Perna M. Silvestrini BAR International Series 2419 2012 Published by Archaeopress Publishers of British Archaeological Reports Gordon House 276 Banbury Road Oxford OX2 7ED England [email protected] www.archaeopress.com BAR S2419 I processi formativi ed evolutivi della città in area adriatica © Archaeopress and the individual authors 2012 Coordinamento e cura editoriale: S. Cingolani Segreteria scientifica: C. Capponi Impaginazione: R. Nocelli Immagine di copertina: Tabula Peutingeriana (segm. IV,V,VI) ISBN 978 1 4073 1018 3 Printed in England by CMP (UK) Ltd All BAR titles are available from: Hadrian Books Ltd 122 Banbury Road Oxford OX2 7BP England www.hadrianbooks.co.uk The current BAR catalogue with details of all titles in print, prices and means of payment is available free from Hadrian Books or may be downloaded from www.archaeopress.com R. Perna - Nascita e sviluppo della forma urbana in età romana nelle città del Piceno e dell’Umbria adriatica NASCITA E SVILUPPO DELLA FORMA URBANA IN ETÀ ROMANA NELLE CITTÀ DEL PICENO E DELL’UMBRIA ADRIATICA ROBERTO PERNA The contribution uses analysis of archaeological records from the main urban sites of the Regio V (Picene) and Regio VI (Umbria) Roman periods referred to the Adriatic coast, aiming to identify how the urban model became established in those territories. However undeniable it may be that several specific historical moments actually carved deep divisions separating them from preceding periods, causing accelerations and evolutions in the development of the urban geography and monumental system of several centres, there is an obvious and significant continuity in progressive acquisition processes of monumental typologies and organization models of urban areas, from the end of the Iron Age to the early Imperial age. -

The Sea the Mountains Music and Theatre Pageants the Culinary
THE MARVELS OF NATURE THE MARVELS OF NATURE THE CULTURAL HERITAGE THE CULTURAL HERITAGE The sea The mountains Archaeological sites Where silence reigns All the provinces of the Marches are on the Adriatic Sea and, Not only is this a region with splendid sandy beaches and According to Festus the name Pi- After the fall of the Roman Empire, the Marches were on the coast, there are cities with ancient origins that have a SPORT AT THE SEASIDE clear seas, but there are also outstanding areas of natural THE KEY TO GOOD HEALTH: SPA RESORTS cenum derives from the fact ARCHAEOLOGICAL PARKS dominated by the Byzantine exarchate north of long history as ports and markets. For travellers arriving beauty in its mountains: the splendid Monti Sibillini, with that the insignia of the Ancona and the Longobards of the Duchy of Spoleto from Rome on the Via Flaminia, the first town they reached on The varying types of landscapes that, in places, are Alpine in character; the spec- There are numerous spas specialized in the treatment of Sabines who migrated to- Archaeology is a key part of the cultural heritage. The va- to the south; they were then contended by the Em- the sea was Fano; Senigallia – at the mouth of the River Misa beaches, and the prox- tacular caves of Frasassi; and the forest-clad mountains in various ailments. In the province of Pesaro there are the wards Asculum Picenum rious provinces in the region are home to 7 archaeolo- pire and the Papal State until the latter gained con- – hosts the Fiera di Sant’Agostino, a traditional fair which re- imity of the hills and the Montefeltro area, forming a backdrop to craggy spurs.