Il Naufragio Degli Ideali Risorgimentali in Luigi Capuana
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Doubles and Doubling in Tarchetti, Capuana, and De Marchi By
Uncanny Resemblances: Doubles and Doubling in Tarchetti, Capuana, and De Marchi by Christina A. Petraglia A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy (Italian) At the University of Wisconsin-Madison 2012 Date of oral examination: December 12, 2012 Oral examination committee: Professor Stefania Buccini, Italian Professor Ernesto Livorni (advisor), Italian Professor Grazia Menechella, Italian Professor Mario Ortiz-Robles, English Professor Patrick Rumble, Italian i Table of Contents Introduction – The (Super)natural Double in the Fantastic Fin de Siècle…………………….1 Chapter 1 – Fantastic Phantoms and Gothic Guys: Super-natural Doubles in Iginio Ugo Tarchetti’s Racconti fantastici e Fosca………………………………………………………35 Chapter 2 – Oneiric Others and Pathological (Dis)pleasures: Luigi Capuana’s Clinical Doubles in “Un caso di sonnambulismo,” “Il sogno di un musicista,” and Profumo……………………………………………………………………………………..117 Chapter 3 – “There’s someone in my head and it’s not me:” The Double Inside-out in Emilio De Marchi’s Early Novels…………………..……………………………………………...222 Conclusion – Three’s a Fantastic Crowd……………………...……………………………322 1 The (Super)natural Double in the Fantastic Fin de Siècle: The disintegration of the subject is most often underlined as a predominant trope in Italian literature of the Twentieth Century; the so-called “crisi del Novecento” surfaces in anthologies and literary histories in reference to writers such as Pascoli, D’Annunzio, Pirandello, and Svevo.1 The divided or multifarious identity stretches across the Twentieth Century from Luigi Pirandello’s unforgettable Mattia Pascal / Adriano Meis, to Ignazio Silone’s Pietro Spina / Paolo Spada, to Italo Calvino’s il visconte dimezzato; however, its precursor may be found decades before in such diverse representations of subject fissure and fusion as embodied in Iginio Ugo Tarchetti’s Giorgio, Luigi Capuana’s detective Van-Spengel, and Emilio De Marchi’s Marcello Marcelli. -

Tradition and Experimentation in Capuana and Capuana Studies
TRADITION AND EXPERIMENTATION IN CAPUANA AND CAPUANA STUDIES Annamaria Pagliaro Monash University Brian Zuccala University of the Witwatersrand The concept of artistic and literary experimentation is a crucial ele- ment for Capuana and consequently for Capuana studies. As we shall argue, it may in fact be considered the critically productive point of junc- ture between Capuana’s oeuvre and recent scholarly work on it, as well as the ideal point of departure for framing the diverse range of excursions into Capuana’s body of work by the contributors to this critical collection. Capuana himself, like all the main Italian writers who contributed to naturalist literary production, such as Verga, Serao and De Roberto, in the 1870s and 1880s did conceive his artistic and theoretical endeavours as a pioneering attempt to radically change the Italian literary landscape, to update and render it competitive within a European – mostly French – literary scene, which had been in the previous thirty years at the forefront of literary innovation (see Capuana 1972a). For just over a decade Capuana pursued what has been critically regarded, in a rather reductive way we would like to argue, as an orthodox naturalist practice à la Zola, in which he wrote, along with the 1877 collection Profili di donne, his first naturalist novel Giacinta (in at least three main editions: 1879, 1886, 1889), dedicated to Zola himself, and a number of short stories about psychopathological cases (mostly female), such as Storia fosca (1880), Precocità (1884), Tortura (1889). Equally limiting is another critically established position, according to which in the 1880s a shift began, and Capuana’s by-then fading adher- ence to the naturalist doctrine of Verismo was reflected in both his later critical work (Per l’arte, 1885, Libri e teatro, 1892, Gli ‘ismi’ contempora- nei, 1898, and Cronache letterarie, 1899) and in his creative production. -

Subalternità Siciliana Nella Scrittura Di Luigi Capuana E Giovanni Verga
STUDI E SAGGI – 171 – STUDI DI ITALIANISTICA MODERNA E CONTEMPORANEA NEL MONDO ANGLOFONO STUDIES IN MODERN AND CONTEMPORARY ITALIANISTICA IN THE ANGLOPHONE WORLD Comitato scientifico / Editorial Board Joseph Francese, Direttore / Editor-in-chief (Michigan State University) Zygmunt G. Barański (University of Cambridge) Laura Benedetti (Georgetown University) Joseph A. Buttigieg (University of Notre Dame) Michael Caesar (University of Birmingham) Fabio Camilletti (University of Warwick) Derek Duncan (University of Bristol) Stephen Gundle (University of Warwick) Charles Klopp (The Ohio State University) Marcia Landy (University of Pittsburgh) Silvestra Mariniello (Université de Montréal) Annamaria Pagliaro (Monash University) Lucia Re (University of California at Los Angeles) Silvia Ross (University College Cork) Suzanne Stewart-Steinberg (Brown University) Titoli pubblicati / Published Titles Francese J., Leonardo Sciascia e la funzione sociale degli intellettuali Rosengarten F., Through Partisan Eyes. My Friendships, Literary Education, and Political Encounters in Italy (1956-2013). With Sidelights on My Experiences in the United States, France, and the Soviet Union Ferrara M.E., Il realismo teatrale nella narrativa del Novecento: Vittorini, Pasolini, Calvino Francese J., Vincenzo Consolo: gli anni de «l’Unità» (1992-2012), ovvero la poetica della colpa-espiazione Bilenchi R., The Conservatory of Santa Teresa Ross S. and Honess C. (edited by), Identity and Conflict in Tuscany Colucci D., L’Eleganza è frigida e L’Empire des signes. Un sogno fatto in Giappone Cauchi-Santoro R., Beyond the Suffering of Being: Desire in Giacomo Leopardi andSamuel Beckett Anita Virga Subalternità siciliana nella scrittura di Luigi Capuana e Giovanni Verga FIRENZE UNIVERSITY PRESS 2017 Subalternità siciliana nella scrittura di Luigi Capuana e Giovanni Verga / Anita Virga. -

Una Lettera Inedita Di Luigi Capuana, Uomo Politico, Al Barone Francesco Spadaro Di Passanitello
(Pubblicato su “Ricerche” a. XI n. 1 Gennaio-Giugno 2007 pp. 33-47)) Una lettera inedita di Luigi Capuana, uomo politico, al barone Francesco Spadaro di Passanitello di Alvise Spadaro Sembrerebbe che l’unico rapporto tra il celebre scrittore ed il maggiorente del suo paese natale si debba ridurre a quanto dichiarato nella relazione che Luigi Capuana, sindaco di Mineo, fece pubblicare nel 1875.1 Ma anche a quanto non esplicitamente dichiarato. Infatti il capitolo Le liti di questa relazione trova la sua conclusione con un vero e proprio rimprovero nei confronti del suo predecessore:2 “Col Sig. Barone Francesco Spadaro il Municipio non ha mancato di usare le stesse cortesie che con gli altri: ha scritto, ha riscritto pregandolo di liquidare alla buona; ma il Sig. Barone, scordando che anche tra nemici (amministrativi, si intende) il galateo non guasta, serbò un ostinato silenzio fino al dì che il Municipio si risolvette, dopo due anni, ad intentargli la lite…”.3 Questo è quanto dichiarato. Quanto non esplicitamente dichiarato si evince dalle grandi lodi che nello stesso testo, Capuana riserva invece ad Antonio Bellone4 (1785-1860), suocero di Francesco Spadaro (1823-1901) e altro suo predecessore nella sindacatura: “…Sarebbe vera ingratitudine non richiamare qui alla memoria il nome del Sig. Antonio Maria Bellone Sindaco di quel tempo. Con un’attività infaticabile che gli stessi contemporanei dissero «non mai veduta per l’innanzi in alcuno dei passati agenti comunali» egli promosse ed in parte condusse vittoriosamente a fine tutte le importantissime pratiche dei diritti promiscui del Comune. Mente acuta, cuore ardente di affetto cittadino, nutriva il più generoso disinteresse alla più ferma volontà nel patrocinare l’assestamento del patrimonio comunale allora mille volte più ingarbugliato di oggi. -

The Liberal Imagination of Giovanni Verga: Verismo As Moral Realism
This is a repository copy of The liberal imagination of Giovanni Verga: verismo as moral realism. White Rose Research Online URL for this paper: http://eprints.whiterose.ac.uk/123637/ Version: Accepted Version Article: Baldini, A orcid.org/0000-0001-7783-9283 (2018) The liberal imagination of Giovanni Verga: verismo as moral realism. The Italianist, 37 (3). pp. 348-368. ISSN 0261-4340 https://doi.org/10.1080/02614340.2017.1409313 © The Departments of Italian Studies at the Universities of Cambridge, Leeds and Reading. This is an Accepted Manuscript of an article published by Taylor & Francis in The Italianist on 16 March 2018, available online: http://www.tandfonline.com/10.1080/02614340.2017.1409313 Reuse Items deposited in White Rose Research Online are protected by copyright, with all rights reserved unless indicated otherwise. They may be downloaded and/or printed for private study, or other acts as permitted by national copyright laws. The publisher or other rights holders may allow further reproduction and re-use of the full text version. This is indicated by the licence information on the White Rose Research Online record for the item. Takedown If you consider content in White Rose Research Online to be in breach of UK law, please notify us by emailing [email protected] including the URL of the record and the reason for the withdrawal request. [email protected] https://eprints.whiterose.ac.uk/ The liberal imagination of Giovanni Verga: Verismo as moral realism Abstract In this article, I argue that Verga’s Verismo should be seen against the backdrop of the writings of the meridionalisti, as well as of his own early works. -

THE PICTURESQUE in GIOVANNI VERGA's SICILIAN COLLECTIONS Jessica Turner Newth Greenfi
THE PICTURESQUE IN GIOVANNI VERGA’S SICILIAN COLLECTIONS Jessica Turner Newth Greenfield A dissertation submitted to the faculty of the University of North Carolina at Chapel Hill in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Department of Romance Languages and Literatures (Italian). Chapel Hill 2011 Approved by: Dr. Federico Luisetti Dr. Dino Cervigni Dr. Ennio Rao Dr. Amy Chambless Dr. Lucia Binotti ©2011 Jessica Turner Newth Greenfield ALL RIGHTS RESERVED ii ABSTRACT JESSICA TURNER NEWTH GREENFIELD: The Picturesque in Giovanni Verga’s Sicilian Collections (Under the direction of Federico Luisetti) Giovanni Verga’s Sicilian short story collections are known for their realistic portrayal of the Sicilian peasant farmers and their daily struggles with poverty, hunger and injustice. This study examines the way in which the author employs the pictruresque in his Sicilian novelle and argues that there is an evolution in this treatment from picturesque to non-picturesque. Initially, this study will examine the elements and techniques that Verga uses to represent the picturesque and how that treatment changes and is utilized or actively destroyed as his writing progresses. For the purposes of this dissertation, a definition of the picturesque will be established and always associated with descriptions of nature. In this study, the picturesque will correspond to those descriptions of nature that prove pleasing for a painting. By looking at seven particular novelle in Vita dei campi and Novelle rusticane, I will show that Verga’s earlier stories are littered with picturesque elements. As the author’s mature writing style, verismo, develops, Verga moves through a transtitional phase and ultimately arrives at a non-picturesque portrayal of Sicily in his short stories. -

«È Dunque Vano Il Tuo Nome, Patria?» Luigi Capuana, Uno Scrittore “Politico”
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA CULTURA, DELL‟UOMO E DEL TERRITORIO DOTTORATO DI RICERCA IN STORIA (STORIA DELLA CULTURA, DELLA SOCIETÀ E DEL TERRITORIO IN ETÀ MODERNA) XXIV CICLO ______________________________________________________________________________ SALVINA ROSARIA AGRIPPINA MONACO «È DUNQUE VANO IL TUO NOME, PATRIA?» LUIGI CAPUANA, UNO SCRITTORE “POLITICO” ______ TESI DI DOTTORATO DI RICERCA ______ Coordinatore: Chiar.mo Prof. Enrico Iachello Tutor: Chiar.mo Prof. Antonio Di Grado TRIENNIO ACCADEMICO 2008 - 2011 INDICE INTRODUZIONE «E FUI LIETISSIMO DI SENTIRMI SICILIANO…» ………….………….…p. 4 CAPITOLO PRIMO DALL‟ISOLA SOTTO INCHIESTA ALL‟ISOLA DEL SOLE I.1. La Destra alla guida dell‟Italia unita…………………………………………p. 13 I.2. La rivolta di Palermo………………………………………………………..p. 17 I.3. L‟inchiesta Pisanelli-Fabrizi e il «governatorato» del generale Medici……..…p. 20 I.4. L‟ultimo decennio della Destra: la Sinistra si prepara ad assumere la guida del Paese………………………………………………………………...……………..p. 25 I.5. Le elezioni del 1874 ……………..………………………………………….p. 31 I.6. Villari e Le lettere meridionali……………………………………...…………..p. 34 I.7. I provvedimenti «straordinari» di Pubblica Sicurezza del 1875………...…….p. 39 I.8. L‟inchiesta parlamentare Borsani-Bonfadini ………………………………..p. 43 I.9. L‟inchiesta privata di Franchetti e Sonnino……………………………….....p. 52 I.10. Luigi Capuana e la difesa dell‟Isola del sole…………………………………..p. 65 CAPITOLO SECONDO TRA MERIDIONALISMO E VERISMO: CAPUANA E IL BASSO POPOLO SICILIANO II.1. Da Villari alla «Rassegna Settimanale»: l‟urgenza della questione meridionale………………………………………………………………………...p. 73 II.2. Uno studio del mondo contadino: l‟Inchiesta Jacini………………………..p. 78 II.3. Le lacrime delle cose: tra naturalismo e verismo ………………………………p. -
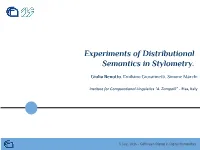
Experiments of Distributional Semantics in Stylometry
Experiments of Distributional Semantics in Stylometry. Giulia Benotto, Emiliano Giovannetti, Simone Marchi Institute for Computational Linguistics “A. Zampolli” - Pisa, Italy 5 July, 2016 - Göttingen Dialog in Digital Humanities First things first: Introduction and A little bit of background knowledge 5 July, 2016 - Göttingen Dialog in Digital Humanities Theoretic Background- Stylometry ● Stylometry: the statistical analysis of literary style ● It offers a means of capturing the elusive character of an author’s style by quantifying some of its features ● The basic stylometric assumption is that each writer has certain stylistic idiosyncrasies (a “human stylome” [Van Halteren et al., 2005]) that define their style. ● Analysis based on stylometry are used for Authorship Attribution (AA) tasks: by measuring some textual features, we can distinguish between texts written by different authors. 5 July, 2016 - Göttingen Dialog in Digital Humanities Theoretic Background- Authorship Attribution ● Simple lexical features: sentence length counts and word length counts, that can be applied to any language and corpus with no additional requirements ● Character measures: a text can be viewed as a mere sequence of characters, so that measures such as alphabetic, digit, uppercase and lowercase characters count can be defined ● Syntactic information: authors tend to use similar syntactic patterns unconsciously, so syntactic information is considered a reliable authorial fingerprint ● Application independent features: they can be extracted from any textual data. 5 July, 2016 - Göttingen Dialog in Digital Humanities Theoretic Background- Authorship Attribution ● Full syntactic parsing, semantic analysis, or pragmatic analysis cannot yet be handled adequately by current NLP technologies for unrestricted text: few attempts have been made to exploit high-level features for stylometric purposes ● The most important method of exploiting semantic information is based on the theory of Systemic Functional Grammar (SFG) [Halliday, 1994]. -

Sicilian Intellectual and Cultural Resistance to Piedmont's Appropriation (1860-1920) Giordana Poggioli-Kaftan University of Wisconsin-Milwaukee
University of Wisconsin Milwaukee UWM Digital Commons Theses and Dissertations December 2016 Sicilian Intellectual and Cultural Resistance to Piedmont's Appropriation (1860-1920) Giordana Poggioli-Kaftan University of Wisconsin-Milwaukee Follow this and additional works at: https://dc.uwm.edu/etd Part of the Comparative Literature Commons, and the History Commons Recommended Citation Poggioli-Kaftan, Giordana, "Sicilian Intellectual and Cultural Resistance to Piedmont's Appropriation (1860-1920)" (2016). Theses and Dissertations. 1401. https://dc.uwm.edu/etd/1401 This Dissertation is brought to you for free and open access by UWM Digital Commons. It has been accepted for inclusion in Theses and Dissertations by an authorized administrator of UWM Digital Commons. For more information, please contact [email protected]. SICILIAN INTELLECTUAL AND CULTURAL RESISTANCE TO PIEDMONT’S APPROPRIATION (1860-1920) by Giordana Poggioli-Kaftan A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy in Modern Studies at The University of Wisconsin-Milwaukee December 2016 ABSTRACT SICILIAN INTELLECTUAL AND CULTURAL RESISTANCE TO PIEDMONT’S APPROPRIATION (1860-1920) by Giordana Poggioli-Kaftan The University of Wisconsin-Milwaukee, 2016 Under the Supervision of Professor Gregory Jay Through my analysis of literary works, I endeavor to bring to the fore a cultural and intellectual counter-hegemonic discourse that came to be articulated by three Sicilian writers in the years following Italy’s unification. Their intent was that of debunking a national discourse that constructed Italian Southerners as “Otherness.” My study focuses on six primary texts, five short stories, and one novel, written at the turn of the twentieth century. -

Royal Holloway, University of London
ROYAL HOLLOWAY UNIVERSITY OF LONDON 2016 Imago Urbis: Federico De Roberto’s Catania Sebastiano Arena Thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy A B S T R A C T The aim of this dissertation is to analyse the relationship between the city, literature and geography in order to study the birth of Catania as a modern city as seen through Federico De Roberto’s newspaper articles, his novel I Viceré and his guidebook to Catania. The analysis of the three literary genres can help to understand the relationship between the writer and his idea and depiction of the city. To this end, it will be useful to analyse, firstly, the connections between urban space and society, and the descriptions of the city through its literary transposition; secondly, the relationship between the leading characters of a novel and the urban space they inhabit; and lastly, the relationship between literature, history and geography. I will firstly concentrate on De Roberto’s 1880s articles about his city to demonstrate the image of Catania that De Roberto was promoting in order to understand his attitude as a journalist towards its cityscapes and his ideological viewpoint. Then, I will examine De Roberto’s novel, I Viceré (1894), as an iconographic source and as a meta- language, by which I mean that I will consider the novel both as a reflection on and of Catania and as a work of literature in which the reader can interpret the narrative to discover the connections between urban space and society. Then, I will study De Roberto’s guidebook to Catania to compare the urban space as represented in I Viceré with that he wanted to promote to a tourist audience. -

Sicily (Sicilia)
Sicily (Sicilia) General Sicily (Italian: Sicilia) is an autonomous region of Italy, in Southern Italy along with surrounding minor islands, officially referred to as Regione Siciliana. Sicily is located in the central Mediterranean Sea, south of the Italian Peninsula, from which it is separated by the narrow Strait of Messina. Its most prominent landmark is Mount Etna, the tallest active volcano in Europe, and one of the most active in the world, currently 3,329 m (10,922 ft.) high. The island has a typical Mediterranean climate. Administrative Divisions Administratively, Sicily is divided into 9 administrative provinces, each with a capital city of the same name as the province. The areas and populations of these provinces are: Province of Agrigento ......................................... 3,042 km2 ....... pop. 453,594 Province of Caltanissetta .................................... 2,128 km2 ....... pop. 271,168 Province of Catania ............................................ 3,552 km2 .... pop. 1,090,620 Province of Enna ................................................ 2,562 km2 ....... pop. 172,159 Province of Messina ........................................... 3,247 km2 ....... pop. 652,742 Province of Palermo ........................................... 4,992 km2 .... pop. 1,249,744 Province of Ragusa ............................................ 1,614 km2 ....... pop. 318,980 Province of Siracusa ........................................... 2,109 km2 ....... pop. 403,559 Province of Trapani ............................................. 2,460 km2 ....... pop. 436,240 The City of Palermo is the Capital City of the region Small surrounding islands are also part of various Sicilian provinces: Aeolian Islands (Messina), The isle of Ustica (Palermo), Aegadian Islands (Trapani), The isle of Pantelleria (Trapani) and Pelagian Islands (Agrigento). Geography Sicily is the largest island in the Mediterranean Sea. It has a roughly triangular shape, earning it the name Trinacria. -

1 Capuana Naturalista Malgré Lui: 'Classics' and 'New Turns'
A Self-Reflexive Verista Metareference and Autofiction in Luigi Capuana’s Narrative Brian Zuccala 1 Capuana naturalista malgré lui: ‘Classics’ and ‘New Turns’ in Capuana Studies Summary 1.1 ‘Genre Studies’ in Early Criticism and ‘Classic’ Monographs. – 1.2 History and Philology. – 1.3 Ideology. – 1.4 Gender and Intermedial ‘Turns’. – 1.5 Occultism. – 1.6 Structure of This Study. Before delving into a close reading of a selection of Capuana’s texts, it is appropriate to show why such a far-reaching self-reflexive ap- proach is more than just exegetically useful. By reflecting on those recent ‘turns’ in Capuana’s criticism that have aimed to break away from a long-standing Verismo/Naturalism-centred line of enquiry, it must be shown how such an approach is critically needed at this stage of capuanistica. In other words, it is important to focus on why and how the issue of (self-)reflexivity increasingly appears to position it- self at the point of intersection of many still-open and cogent ques- tions in Capuana studies and to offer itself as a potential answer to a significant proportion of those questions. 1.1 ‘Genre Studies’ in Early Criticism and ‘Classic’ Monographs With the exception of individual magazine reviews of specific works and an insightful 1896 overview by Luigi Pirandello, Capuana criti- cism begins with the well-known, widely investigated and enormously influential essay by Benedetto Croce, “Luigi Capuana – Neera” (1905). Italianistica. Nuova serie 2 DOI 10.30687/978-88-6969-398-4/002 21 Zuccala 1 • Capuana naturalista malgré lui: ‘Classics’ and ‘New Turns’ in Capuana Studies Croce’s essay addresses Capuana’s theoretical activity and creative writing separately, and argues that Capuana’s primary literary mer- it was that of theorising Verismo and promoting the verista work of fellow writer, Giovanni Verga, rather than being a result of his own creative writing.1 Yet, even in the formulation of Capuana’s artistic theories there are, for Croce, some rather significant contradictions.