PUU Kalendarium 2009-2010
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

International Conference: International Conference
International Conference: “Business Leaders as Agents of Economic and Social Inclusion” 17th - 18th November 2016 Vatican City - New Synod Hall Via di Porta Cavalleggeri (Petrian Gate) Silver sponsor Welcome Bronze sponsor Dear Participant, elcome to the International Conference “Business Leaders as Agents of Economic and Social Inclusion”, organized by the Pon- tificalW Council for Justice and Peace in association with UNIAPAC. During this congress, we hope to foster constructive reflection and dis- Supporters cussion on the mechanisms that we can build together to help bring about a sustainable inclusive economy—an economy that develops human dignity, and that includes the excluded and the poor in overall prosperity by ensuring fair paid work. This includes identifying effective ways for business enterprise to bring about greater improvements in areas that matter most in people´s lives, using subsidiarity as a process to dignify human development, which can be achieved through the joint effort of governments, civil society The generous financial individual contribution of several businesswoman and businessman and the business community. “We are not simply talking about ensuring nourishment or a “dignified sustenance” for all people, but also their “general temporal welfare and prosperity”. This means education, access to health care, and above all employment, for it is through free, creative, participatory and mutually “….today we also have to say “thou shalt not” to an economy of exclusion supportive labor that human beings express -

The Irish Catholic That “The Various Church Bod- Feeling of Communion and He Would Be Concerned That Ies Concerned Urgently Need Community More Difficult
The way things were: Conflicting views on the 1970 Arms Trial – Page 36 SCHOOLS YOUTH MARTIN THREAT LEADERS MANSERGH Programme may lead to Pope looks to young New Programme for education Referendum people to show the Government will need – Michael Kelly Page 13 way Pages 14 & 15 political will Page 8 f L Thursday, June 18, 2020 €2.00 (Stg £1.70) The-Irish-Catholic-Newspaper @IrishCathNews www.irishcatholic.com Archbishop Catholics urged to fight any in plea for shorter plan to target Faith schools homilies for change and the process Chai Brady Staff reporter of divesting some Catholic Lilies for the gentlest of saints Catholics have been urged to schools must continue “where Archbishop Diarmuid fight any proposal to weaken there is local demand”. Martin has asked priests to Catholic schools after the Prof. Eamonn Conway of shorten their homilies as Programme for Government Mary Immaculate College in public Masses begin at the published this week proposed Limerick said he believed “it end of the month. a citizens’ assembly on the is time for a well-thought In a note sent to future of education. out negotiated settlement priests this week, he said Theologian Dr John Mur- in regard to education that “it is obvious that ray of Dublin City University between Church and State. safe distancing makes a told The Irish Catholic that “The various Church bod- feeling of communion and he would be concerned that ies concerned urgently need community more difficult. “such an assembly could be to seize the initiative by pre- “Distancing could also used to give the illusion paring their own programme lead to a deeper reflection that there is a huge desire for appropriate divestment in on silence in the liturgy. -

Saint James Minor C
National Gallery of Art NATIONAL GALLERY OF ART ONLINE EDITIONS Italian Paintings of the Thirteenth and Fourteenth Centuries Master of Saint Francis Umbrian, active third quarter 13th century Saint James Minor c. 1272 tempera on panel painted surface: 48.3 × 22.5 cm (19 × 8 7/8 in.) overall size: 49.8 x 24.2 cm (19 5/8 x 9 1/2 in.) framed: 58.7 x 33 x 6 cm (23 1/8 x 13 x 2 3/8 in.) Inscription: on the arch: SANCTVS JACOB [A]LPHEI Q[VI] COGNOMINAT[VS] E[ST] IV[STVS] [1] Samuel H. Kress Collection 1952.5.15 ENTRY This panel and its companion, Saint John the Evangelist, originally formed part of an altarpiece painted on both sides. The side displayed to the faithful presumably showed four stories of Christ flanked by saints and prophets [fig. 1] (see also Reconstruction), while the rear side showed the apostles and Saint Francis, full length [fig. 2] (see also Reconstruction). Of the main side of the altarpiece, which had already been dismembered by 1793, [1] only the components of the right part have survived, namely Prophet Isaiah ([fig. 3], treasury of the basilica of San Francesco, Assisi) [2] and Deposition [fig. 4], Lamentation [fig. 5], and Saint Anthony of Padua [fig. 6], all three now in the Galleria Nazionale dell’Umbria in Perugia. [3] Nothing has survived of the left part of the dossal, which perhaps showed Jeremiah (or another prophet), the counterpart of Isaiah on the other side, flanked by two other scenes of the Passion and another full-length saint, corresponding to Saint Francis on the back. -

Sfoglia La Guida
In occasione del 50° anniversario delle relazioni tra UE e Santa Sede, le Ambasciate degli Stati Membri e la Delegazione dell'Unione Europea hanno sviluppato l’Iter Europaeum, un cammino di chiese a Roma che racconta il legame storico tra la Santa Sede e l’Unione Europea con i suoi 27 Stati Membri. Le chiese e basiliche selezionate tra le strade di Roma sono cattoliche, ma anche evangeliche luterane e IL CMMINO DELLE ortodosse, e sono ognuna connessa ad uno Stato CHIESE EUROPEE ROM Membro, che sia per ragioni storiche e/o per la comu- nità presente in loco. Questa guida è elaborata in diverse lingue – secondo il volere delle Ambasciate – per poter abbracciare tutte le comunità europee presenti a Roma. Prima di visitare le chiese, si consiglia di controllare gli orari di apertura ed eventuali restrizioni Covid-19 sui siti web delle chiese. www.itereuropaeum.eu 50 anni di relazioni tra UE e Santa Sede IterLa Giustiniana Europaeum 1 23 3 6 4 21 7 19 22 7-8-28 10 9 24 6 26 2 20 3 25 5-12 4 5 4 27 8 1 | Austria 6 | Croazia 11 | Germania 15 | Lettonia 21 | Portogallo 25 | Spagna Santa Maria dell'Anima San Girolamo Chiesa del Cristo Santi Quattro Coronati Sant'Antonio San Pietro in Montorio 2 | Belgio dei Croati in Urbe (evangelica luterana) 16 | Lituania dei Portoghesi 26 | Svezia San Giuliano 7 | Danimarca 12 | Grecia Chiesa del Gesù 22 | Romania Santa Brigida dei Fiamminghi Campo Santo Teutonico San Teodoro al Palatino 17 | Lussemburgo San Salvatore a Campo de' Fiori 3 | Bulgaria 8 | Estonia 13 | Irlanda Sacro Cuore di Gesù alle Coppelle -
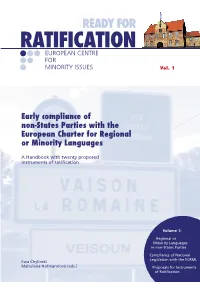
Ratification
READY FOR RATIFICATION Vol. 1 Early compliance of non-States Parties with the European Charter for Regional or Minority Languages A Handbook with twenty proposed instruments of ratification Volume 1: Regional or Minority Languages in non-States Parties Compliance of National Legislation with the ECRML Ewa Chylinski Mahulena Hofmannová (eds.) Proposals for Instruments of Ratification READY FOR RATIFICATION Vol. 1 Imprint Preface Publisher: European Centre for Minority Issues (ECMI) For a number of years, the European Centre for Minority Issues (ECMI) and the Council of Europe co-operated on the © ECMI 2011 publication of a handbook series on various minority issues. The topical areas were legal provisions for the protection and promotion of minority rights under the Framework Convention for the Protection of National Minorities (FCNM), Editors: Ewa Chylinski/Mahulena Hofmannová power sharing arrangements and examples of good practice in minority governance. The present Handbook concerns the other Council of Europe convention dealing with minorities: the European Charter for Regional or Minority Languages (ECRML). The ECRML represents the European legal frame of reference for the The opinions expressed in this work are the responsibility protection and promotion of languages used by persons belonging to traditional minorities. of the authors and do not necessarily reflect the position of the ECMI. Regrettably, the importance of the ECRML is not reflected by the number of ratifications. While the FCNM has 39 States Parties, the ECRML has so far been ratified by 25 member States of the Council of Europe and signed by Any person who does any unauthorized act in relation a further eight member States. -

Brochure Consultabile Online
FONDAZIONE VATICANA JOSEPH RATZINGER BENEDETTO XVI 6 Ratzinger Prize Il Premio Ratzinger 12 Grants Borse di studio 14 Ratzinger Library La Biblioteca Ratzinger 18 A growing website Un sito in crescita The courage Fondazione Vaticana Joseph Ratzinger – Benedetto XVI to go on Joseph Ratzinger – Benedict XVI Vatican Foundation Via della Conciliazione, 5 Twenty-four pages: words and images to describe 00120 Città del Vaticano an experience of life. tel. 06.69882856 www.fondazioneratzinger.va It is the brief history – only five years – of the Foundation, expressly desired by Pope Benedict. He wanted the Church to be thankful to those who join culture and the academic world and spend their whole life in the name of the Gospel and the Son of God. In copertina e qui sotto / In the cover and at the bottom of the page These are the pages of a story that is still to be Alcuni momenti dell’inaugurazione lived. Five years ago Benedict XVI gave the first pages dell’Aula Papa Benedetto – Joseph Ratzinger presso il Pontificio Collegio Teutonico. to the Church as a present. They tell about his pecu- Some moments of the opening ceremony liar, gentle and generous act of love. And the Church – of the Pope Benedict – Joseph Ratzinger Hall at the Pontifical Teutonic College. that is the people that God loves – received this pres- ent and made it part of the Church, keeping it and Chiuso per la stampa: novembre 2015 wishing it to grow, as we can read in the last page. Printed: November 2015 When he gave the Ratzinger Prize, Pope Francis re- minded us that “Christians are those who have the courage to go on”. -

073-Santa Maria Dell'anima
(073/31) Santa Maria dell'Anima Santa Maria dell'Anima (Our Lady of the Souls) is a 16th Catholic church in central Rome dedicated to the Blessed Virgin as patroness of the souls of the departed in purgatory, located just west of the Piazza Navona and near the Santa Maria della Pace church. It was the church of the Holy Roman Empire and is now the church of the German and Austrian community in Rome. History: 14 th and 15 th century Santa Maria dell'Anima is one of the many medieval charity institutions built for pilgrims in Rome. The church found its origin in 1350, when Johannes (Jan) and Katharina Peters of Dordrecht bought three houses and turned it into a pilgrims hostel, at the occasion of the Jubilee of 1350. Jan Peters may have been a Dutch merchant or papal soldier. A marble group was discovered here, so they named the hostel "Beatae Mariae Animarum" ("Saint Mary of the Souls"). A copy of this group is on the tympanium over the main doorway. (5) (8) (b) The hostel was first mentioned in 1398 in a bull of Pope Boniface IX, and on May 21, 1406 Pope Innocent VII in his bull Piae Postulatio declared the hostel protected by the Holy See. In 1431 a full- sized church was built to replace the former small chapel, which was made possible because of a large legacy provided by the famous German mediaeval historian Diedrich of Niem. The new (073/31) church was consecrated by Pope Eugene IV in 1444. In the 15th century Santa Maria dell'Anima expanded to be a hostel for visitors from the entire Holy Roman Empire, though initially the occupants were primarily from the Low Countries and (from the middle 15th century) the Rhineland. -

Acta Apostolicae Sedis
ACTA APOSTOLICAE SEDIS COMMENTARIUM OFFICIALE ANNUS V. - VOLUMEN V. ROMAE TYPIS POLYGLOTTIS VATICANIS MDCCCCXIII Annus V. - Vol. V. Die 25 Ianuarii 1913. Num. 1. ACTA APOSTOLICAE SEDIS COMMENTAEIUM OFFICIALE ACTA PII PP. X MOTU PROPRIO QUO PROVIDETUR REGIMEN ORDINIS FRATRUM MINORUM CONVENTUALIUM DU RANTE INFIRMA VALETUDINE MINISTRI GENERALIS. Supremum officium in universa Ecclesia humilitati Nostrae commissum rei sacrae procurationis gerendae postulat, ut rectae cuiuscumque Ordinis actioni pro videamus. Quum porro dilecto filio Victori Mariae Sottaz, Fratrum Minorum Conventualium generali Ministro, diuturna invaletudo a laboribus quiescendi necessitatem faciat; ipso in Ministri generalis munere perma nente, ad totius Ordinis Conventualium administrationem re ligiosum virum Franciscum Mariam Dall'Olio, eiusdem Ordinis Procuratorem, etiam in Vicarium generalem cum omnibus facultatibus eidem debitis eligimus. Duobus vero modo Adsi- stentibus, dilectis Hieronymo Mariae Mileta et Stephano Mariae Ignudi, duos alios adiungimus, dilectos Aloisium Mariam San toro, in Basilica Vaticana Poenitentiarium, et Dominicum Ma riam Tavani in collegio seraphico S. Theodori de Urbe modera torem, qui in officio, quod obtinent, permanentes, eidem Vica rio generali in cunctis praesto erunt, et quorum ipse vota deli berativa exposcere tenebitur. In omnibus vero Curiae generalis conventibus etiam religiosi Francisci Mariae Formenti consilia et vota erunt exquirenda, praecipue si de sacris expeditionibus populis ad pietatem excolendis aliquid erit pertractandum. 6 Acta Apostolicae Sedis. - Commentarium Officiale. Haec a Nobis, uti supra, decreta et statuta, usque ad Congre gationem generalem anno 1913 habendam ab universis Ordinis Conventualium sodalibus ita erunt servanda, ut unicuique reli giosum sit moderatorum voluntati morem gerere, iisdemque obedientiam et reverentiam prompto hilarique animo in omni bus praestare : non obstantibus Constitutionibus et Ordinatio nibus apostolicis, etiam speciali mentione dignis, ceterisque contrariis quibuscumque. -

St. Louis, Mo., Will Baltimore
National Circulation, 4481)38; Denver Catholic Register, 21J08 WASHINGTON, D.C., MADE SEAT OF ARCHDIOCESE Contents Copyrighted by the Catholic Press Society, Inc., 1939— Permission to Reproduce, Excepting 3-Day Observance to Mark Little Sisters’ on Articles Otherwise Marked, Given After 12 M. Friday Following Issue Archbishop Curley Centenary; Bishop Will Sing Mass Of Raltimore Will A three-day celebration of their Very Rev. Wm. Coyne, president Vincent’s home will give plays and DENVER CATHOLIC order’s centenary will be held by of St. Thomas’, will preach and a other entertainment. the Little Sisters of the Poor in choir from St. Francis de Sales’ Came to Denver in 1916 Denver Oct. 26, 27, and 28. A pari.sh, under the direction of Ar The Little Sisters of the Poor Rule New District Solemn Pontifical Mass to be cele thur Alcorn, will sing. A .special came to Denver in 1916 at the re brated by Bishop Urban J. Vehr invitation to attend the services quest of the Most Rev. Nicholas in the chapel of the J. K. Mullen this day is extended to all bene C. Matz, second Bishop of Denver. home for the aged conducted by factors and friends of the home The modern home for the nuns and Same Curia Will Serve Both Sees, Which Are the nuns will open the observance. and to the general public. Bene their 170 charges at W. 30th ave REGISTER The Very Rev. Wm. Higgins of St. diction will be held at 4 p. m. nue and Newton street was erected The National Catholic Welfare Conference News Service Supplies The Denver Catholic Register. -

Friars Witness Papal History in Rome
SUMMER 2013 FRIARS WITNESS PAPAL HISTORY IN ROME ALSO IN THIS ISSUE: Breaking the Spring Break Mold • (Hall of) Fame and Friars PROVIDENCE COLLEGE MAGAZINE SUMMER 2013 04 EMBRACED BY HISTORY From students and faculty in Rome to former Vatican Ambassador Raymond L. Flynn ’63 & ’84Hon., the papal shakeup proved a startling time in history. 24 Really GREAT SPORTS The 2013 Athletics Hall of Fame class — eight athletes, a head coach, and an NCAA Championship team — is framed by one overwhelming trait: character. IN this ISSUE 12 03 SAVE THE DATE Regional & College Events 22 PC NEWS/BRIEFLY Recent College Developments 24 FRIARTOWN Athletics News & Features 32 CONNECTIONS Alumni News, Features, & Class Notes 47 IN MEMORIAM/DEATHS 48 THE LAST WORD Cover: Peter Macdiarmid / Getty Images News / Getty Images Note: New regulations and fees established by the U.S. Postal Service affecting the address lines on third-class mail have prompted the College to modify its addressing practices. As always, we welcome your feedback at editormagazine@ providence.edu. Time © Providence College 2013 FOR A BREAK? Providence College Magazine is published three times yearly by Providence College for alumni, parents, and friends. Think Spring Break means beaches, parties, and relaxation? Opinions expressed in Providence College Magazine do not necessarily reflect those of the entire College community. Hundreds of PC students say, “Not so fast!” Correspondence: [email protected] or: Providence College, Marketing and Communications 1 Cunningham Square, Harkins Hall 404 Providence, RI 02918-0001 1 EDITOR Charles C. Joyce Director of Editorial Services ART DIRECTOR Alexi Drago Director of Creative Services MANAGING EDITOR Joseph F. -

CONVENTIO Conventio Inter Sanctam Sedem Et Gubernium Reipublicae Italiae De Rebus Fiscalibus
Acta Francisci Pp. 1263 CONVENTIO Conventio inter Sanctam Sedem et Gubernium Reipublicae Italiae de rebus fiscalibus. La Santa Sede ed il Governo della Repubblica Italiana, qui di seguito denominati anche Parti contraenti; tenuto conto della speciale rilevanza dei rapporti tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana, caratterizzati da mutua collaborazione ed improntati alla ricerca di soluzioni condivise in materie di interesse comune; avendo al riguardo presenti, da parte della Repubblica Italiana, i principi sanciti dalla propria Costituzione, e, da parte della Santa Sede, gli insegna- menti del Concilio Ecumenico Vaticano II e le norme del diritto canonico; considerato che i rapporti tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana sono regolati dai Patti lateranensi e, in particolare, dal Trattato tra la Santa Sede e l’Italia, sottoscritto l’11 febbraio 1929 (d’ora in avanti, Trattato del Laterano); tenuto conto del processo in atto verso l’affermazione a livello globale della trasparenza nel campo delle relazioni finanziarie e concordando sull’op- portunità di assicurare la più ampia trasparenza anche attraverso lo scambio di informazioni ai fini fiscali nell’ambito della cooperazione amministrativa; attesa la peculiarità geografica dello Stato della Città del Vaticano, a motivo della cui limitata estensione furono individuate le zone extraterri- toriali di cui agli articoli 13, 14 e 15 del Trattato del Laterano; concordando inoltre sull’opportunità di prevedere che i contribuenti residenti in Italia possano adempiere pienamente ai propri obblighi fiscali, nonché sull’esigenza di dare piena attuazione all’articolo 16, alinea primo, del Trattato del Laterano; hanno convenuto di concludere la presente Convenzione: ARTICOLO 1 (Scambio di informazioni) 1. -

Culture E Fede – Cultures and Faith Cultures Et Foi – Culturas Y Fe Vol
CULTURE E FEDE – CULTURES AND FAITH CULTURES ET FOI – CULTURAS Y FE VOL. XIV – N° 2 – 2006 SUMMARIUM ASSEMBLEA PLENARIA 2006 Paul Card. POUPARD, Discours d’ouverture aux travaux .......... 98 Pasquale IACOBONE, Presentazione dell’Instrumentum Laboris . 107 J.-M.-Laurent MAZAS, Présentation de l’Instrumentum Laboris. 111 Post-Plenary Document: The «Via Pulchritudinis», Beauty as a Way for Evangelisation and Dialogue ....................... 116 Bernard ARDURA, Rapporto di attività del Pontificio Consiglio della Cultura: marzo 2004 – marzo 2006 ................. 144 Antonio Card. ROUCO VARELA, La Belleza frente a la Ideología Laicista................................... 166 Paul Card. POUPARD, Conclusions finales .................... 171 PLENARIA 2006 ______________________________________________________________ The PLENARY ASSEMBLY of the Pontifical Council for Culture has the task of evaluating and planning the Dicastery’s programmes with a view to promoting evangelisation and the Church’s dialogue with cultures. The last Plenary Assembly toke place 27-28 March 2006 on the theme The «Via Pulchritudinis», Beauty as a Way for Evangelisation and Dialogue. This issue of the Review offers a selection of contributions and interventions. The publication of the Acts is forthcoming. * * * L’ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE du Conseil Pontifical de la Culture a pour mission d’étudier et de définir les programmes d’action du Dicastère, dans la perspective de l’évangélisation et du dialogue de l’Église avec les cultures. La dernière Assemblée Plénière s’est tenue du 27 au 28 mars 2006, sur le thème : La « via pulchritudinis », chemin d’évangélisation et de dialogue. Ce numéro de la Revue présente une sélection d’interventions et de contributions. La publication des Actes est en préparation. * * * L’ASSEMBLEA PLENARIA del Pontificio Consiglio della Cultura ha il compito di studiare e definire i programmi del Dicastero, nella prospettiva dell’evangelizzazione e del dialogo della Chiesa con le culture.