Medicina E Shoah Eugenetica E Razzismo Del
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

From Humiliation to Humanity Reconciling Helen Goldman’S Testimony with the Forensic Strictures of the Frankfurt Auschwitz Trial
S: I. M. O. N. Vol. 8|2021|No.1 SHOAH: INTERVENTION. METHODS. DOCUMENTATION. Andrew Clark Wisely From Humiliation to Humanity Reconciling Helen Goldman’s Testimony with the Forensic Strictures of the Frankfurt Auschwitz Trial Abstract On 3 September 1964, during the Frankfurt Auschwitz trial, Helen Goldman accused SS camp doctor Franz Lucas of selecting her mother and siblings for the gas chamber when the family arrived at Birkenau in May 1944. Although she could identify Lucas, the court con- sidered her information under cross-examination too inconsistent to build a case against Lucas. To appreciate Goldman’s authority, we must remove her from the humiliation of the West German legal gaze and inquire instead how she is seen through the lens of witness hospitality (directly by Emmi Bonhoeffer) and psychiatric assessment (indirectly by Dr Walter von Baeyer). The appearance of Auschwitz survivor Helen (Kaufman) Goldman in the court- room of the Frankfurt Auschwitz trial on 3 September 1964 was hard to forget for all onlookers. Goldman accused the former SS camp doctor Dr Franz Lucas of se- lecting her mother and younger siblings for the gas chamber on the day the family arrived at Birkenau in May 1944.1 Lucas, considered the best behaved of the twenty defendants during the twenty-month-long trial, claimed not to recognise his accus- er, who after identifying him from a line-up became increasingly distraught under cross-examination. Ultimately, the court rejected Goldman’s accusations, choosing instead to believe survivors of Ravensbrück who recounted that Lucas had helped them survive the final months of the war.2 Goldman’s breakdown of credibility echoed the experience of many prosecution witnesses in West German postwar tri- als after 1949. -

VWI Im Fokus 2020
2020 VWI im Fokus 02 Editorial 03 Rückblick & Ausblick 08 Interview 13 Veranstaltungskalender 16 Ausschreibung Fellowships 17 VWI-Fellows 2020/2021 21 Neue MitarbeiterInnen 22 EHRI-Preparatory Phase 24 Projekte des VWI 25 Fundstücke 26 Kurz notiert & Kleinode 27 Kurz notiert 28 Service & Impressum VWI im FOKUS | 2020 EDITORIAL DAS INSTITUT as VWI eröffnete den diesjährigen Veranstaltungsreigen mit einer Erinnerungsmatinee an seinen Mentor und Initiator Simon Wiesen thal,D der die neueste Geschichte Österreichs nachhaltig geprägt hat und dem die Republik so viel verdankt. An sechs aufeinanderfolgenden Sonn tagnachmittagen im Jänner und Februar 2020 präsentierte das VWI in Kooperation mit dem Österreichischen Filmmuseum das im November 1997 von Albert Lichtblau (heute Vorstandsmitglied des VWI) für die USC Shoah Foundation geführte elfstündige Interview mit Simon Wiesenthal. Niemand, weder die OrganisatorInnen der Veranstaltung noch ich, hätten auf eine so gewaltige Resonanz zu hoffen gewagt. Das Interesse, schon am ersten Nachmittag beachtlich, stieg von Vorführung zu Vorführung. Kaum jemand im Publikum verließ den Kinosaal vor Ende der mehr als zweieinhalbstündigen Präsentationen und den im Anschluss geführten, das jeweilige Thema des Nachmittages vertiefenden Gesprächen mit gelade nen ExpertInnen. Der Saal blieb gesteckt voll. Aufgrund des vollbesetzten Kinosaals mussten am letzten ScreeningNachmittag BesucherInnen sogar Foto: privat Foto: abgewiesen werden. Terezija Stoisits. Der nächste vorgesehene große Programmpunkt des Arbeitsjahres, die Konferenz zu den Folgen der Pariser Vorortverträge 1919/1920, die Ende März im repräsentativen Palais Trautson unter Patronanz von Bundesmi DAS VWI IN ZEITEN VON CORONA nisterin Dr.in Alma Zadić hätte stattfinden sollen, musste coronabedingt abgesagt, das heißt auf das kommende Jahr verschoben werden. -

Titel Strafverfahren
HESSISCHES LANDESARCHIV – HESSISCHES HAUPTSTAATSARCHIV ________________________________________________________ Bestand 461: Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht Frankfurt am Main Strafverfahren ./. Robert Mulka u.a. (1. Auschwitz-Prozess) Az. 4 Ks 2/63 HHStAW Abt. 461, Nr. 37638/1-456 bearbeitet von Susanne Straßburg Allgemeine Verfahrensangaben Delikt(e) Mord (NSG) Beihilfe zum Mord (NSG) Laufzeit 1958-1997 Justiz-Aktenzeichen 4 Ks 2/63 Sonstige Behördensignaturen 4 Js 444/59 ./. Beyer u.a. (Vorermittlungen) Verfahrensart Strafverfahren Verfahrensangaben Bd. 1-133: Hauptakten (in Bd. 95-127 Hauptverhandlungsprotokolle; in Bd. 128-133 Urteil) Bd. 134: Urteil, gebundene Ausgabe Bd. 135-153: Vollstreckungshefte Bd. 154: Sonderheft Strafvollstreckung Bd. 155-156: Bewährungshefte Bd. 157-165: Gnadenhefte Bd. 166-170: Haftsonderhefte Bd. 171-189: Pflichtverteidigergebühren Bd. 190-220: Kostenhefte Bd. 221-224: Sonderhefte Bd. 225-233: Entschädigungshefte Bd. 234-236: Ladungshefte Bd. 237: Anlage zum Protokoll vom 3.5.1965 Bd. 238-242: Gutachten Bd. 243-267: Handakten Bd. 268: Fahndungsheft Baer Bd. 269: Auslobung Baer Bd. 270: Sonderheft Anzeigen Bd. 271-272: Sonderhefte Nebenkläger Bd. 273-274: Ermittlungsakten betr. Robert Mulka, 4 Js 117/64 Bd. 275-276: Zuschriften Bd. 277-279: Berichtshefte Bd. 280-281: Beiakte betr. Josef Klehr, Gns 3/80, Handakten 1-2 Bd. 282: Sonderheft Höcker Bd. 283: Zustellungsurkunden Bd. 284: Übersetzung der polnischen Anklage vom 28.10.1947 Bd. 285: Fernschreiben Bd. 286; Handakte Auschwitz der OStA I Bd. 287-292: Pressehefte Bd. 293-358: Akten der Zentralen Stelle der Landesjustizverwaltungen Ludwigsburg Bd. 359-360: Anlageband 12 Bd. 361: Protokolle ./. Dr. Lucas Bd. 362: Kostenheft i.S. Dr. Schatz Bd. 363: Akte der Zentralen Stelle des Landesjustizverwaltungen Ludwigsburg Bd. -

Over Oordelen Bij Hannah Arendt Na 'Eichmann in Jeruzalem'
Arendt, Eichmann en Auschwitz. Over oordelen bij Hannah Arendt na ‘Eichmann in Jeruzalem’ Mascha Teirlinck (391577) 11 augustus 2009 Faculteit Geesteswetenschappen Departement Filosofie Eerste begeleider: dr. D.J.M.S Janssens Tweede begeleider: prof. dr. D.A.A. Loose 1 Inhoud Afkortingen.................................................................................. 3 Inleiding....................................................................................... 4 Hoofdstuk 1 - Arendt in Jeruzalem: het Eichmann-proces............ 6 Inleiding..................................................................................................................... 6 De tijd - de jaren ‘60.................................................................................................. 6 De procesgang............................................................................................................ 8 De verdachte............................................................................................................. 11 De joodse raden........................................................................................................ 11 De rechter................................................................................................................. 12 Hoofdstuk 2 - Oordelen bij Arendt............................................ 14 Inleiding................................................................................................................... 14 De doxa bij Socrates............................................................................................... -

Zeugnisformen Berichte, Künstlerische Werke Und Erzählungen Von NS‑Verfolgten
Bildungsarbeit mit Zeugnissen ZEUGNISFORMen Berichte, künstlerische Werke und Erzählungen von NS‑Verfolgten Herausgegeben von Dagi Knellessen und Ralf Possekel Was bleibt, wenn die Zeuginnen und Zeugen der nationalsozialistischen Verbrechen gestorben sein werden? Seit Jahren ist diese Frage in allen gesellschaftlichen, wissenschaftlichen und pädagogischen Debatten über den Umgang mit der NS-Geschichte präsent. Was bleibt, sind die Zeugnisse, die Überlebende in ganz unterschiedlicher Form abgelegt haben: ihre Berichte, ihre literarischen, musikalischen und bildnerischen Verarbeitungen, ihre lebensgeschichtlichen Erzählungen, ihre Zeugenaussagen vor Gericht. Sie vermitteln eindrücklich die Auswirkungen und Schrecken der nationalsozialistischen Verfolgung. Aber sind sie Ga- ranten dafür, dass die spezifische Erfahrungsgeschichte der NS-Opfer auch künftig in der öffentlichen Erinnerungskultur und in der Bildung bewahrt werden wird? Welchen Stellenwert haben sie in der Geschichtsforschung zu Nationalsozialismus und Holocaust? Und wie lassen sie sich in der Bildungs- praxis am besten einsetzen? Die Veranstaltungsreihe „Entdecken und Ver- stehen. Bildungsarbeit mit Zeugnissen von Opfern des Nationalsozialismus“ der Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ (EVZ) ist diesen Fragen nachgegangen. In fünf Seminaren wurden neueste Forschungser- gebnisse sowie konkrete Bildungsmodule zu den wichtigsten Zeugnisfor- men vorgestellt und diskutiert. Die Resultate der Reihe sind in diesem Band dokumentiert. Reihe Bildungsarbeit mit Zeugnissen, Band -
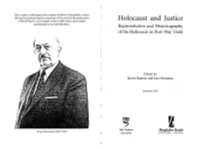
Holocaust and Justice Contributing to Its Materialization
This volume is dedicated to the memory of Sirnon Wiesenthal, a major driving force preserving the awareness of the need for the prosecution ofWorld War II war criminals in the world's mind, and actually Holocaust and Justice contributing to its materialization. Representation and Historiography of the Holocaust in Post-War.,., Trials Edited by David Bankier and Dan Michman '' Jerusalem 2010 \ ~ Yad Vashem Sirnon Wiesenthai (1908-2005) Berghahn Books Jerusalem NEW YORK • OXFORD '·' Copyright© 20 l 0 by Yad Vashem, Jerusalem Published in association with Berghahn Books The responsibility for the views expressed in this publication rests solely with the authors. Contents All rights reserved. No part ofthis publication may be reproduced in any form or any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording or any information storage or retrieval system, without permission in writing from the publisher Yad Vashem The Holocaust Martyrs' and Heroes' Remembrance Authority. Introduction . 7 This publication and the conference on which it is based The Nurernberg Trialsand Their Long-Range Impact were made possible through the generous support of the Gertner Center for International Holocaust Conferences The Didactic Trial: Fittering History and Memory into the endowed by the late Danek D. and Jadzia B. Gertner Courtroom . 11 and The Gutwirth Family Fund Lawrence Douglas Prosecuting the Past in the Postwar Decade: Political Strategy and National Myth-Making . 23 Language Editor: Heather Rockman Donald Bloxham Typesetting: Judith Sternberg Printing: Printiv, Jerusalem The Holocaust, Nurernberg and the Birth of Modem International Law . 45 Michael J. Bazyler The Role ofthe Genocide ofEuropean Jewry in the Preparations for the Nurernberg Trials . -

Právnická Fakulta Masarykovy Univerzity
Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra dějin státu a práva Vrahové mezi námi. Frankfurtský osvětimský proces 1963-1965 Rigorózní práce PhDr. Tomáš Vojta Brno 2020 1 2 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem rigorózní práci na téma „Vrahové mezi námi. Frankfurtský osvětimský proces 1963-1965“ zpracoval sám. Veškeré prameny a zdroje informací, které jsem použil k sepsání této práce, byly citovány v poznámkách pod čarou a jsou uvedeny v seznamu použitých pramenů a literatury. V Brně dne 29. června 2020 .......................................... PhDr. Tomáš Vojta 3 4 Poděkování Rád bych na tomto místě poděkoval panu profesorovi JUDr. Ladislavu Vojáčkovi, CSc., a to za příjemný lidský i profesionální přístup ke studentům a také za upevnění vztahu k historii jako takové skrze výuku právních dějin. 5 6 Abstrakt Rigorózní práce „Vrahové mezi námi. Frankfurtský osvětimský proces 1963-1965“ se zabývá analýzou soudního procesu s esesmany z nacistického koncentračního a vyhlazovacího tábora Osvětim, který byl klíčovou součástí nacistického plánu industrializovaného vyvraždění židů v Evropě. Autor v této práci řeší otázku významu frankfurtského procesu, který probíhal v západoněmeckém Frankfurtu nad Mohanem a který byl největším soudním procesem, jehož předmětem byla genocida židů. Tento proces má mimořádný a nepominutelný význam pro právní i obecné dějiny Evropy. Justice nástupnické země Třetí říše během tohoto řízení čelila naprosto bezprecedentní výzvě v moderních dějinách práva, a to jak nalézt a identifikovat vinu a trest u několika (spolu)pachatelů nejextrémnější masové vraždy v dějinách. Tento unikátní a zajímavý soudní proces přinesl mnoho zajímavých právních momentů, o nichž tato práce pojednává. Klíčová slova Druhá světová válka, Osvětim, holocaust, židé, německá justice, frankfurtský proces Abstract Rigorous thesis „Murderers Among Us. -

Prozesse Wichtig Für Die Wissenschaftl
DIPLOMARBEIT Titel der Diplomarbeit Erinnern und Vergessen. Die 60er-Jahre und der öffentliche Diskurs über nationalsozialistische Gewaltverbrechen in Österreich am Beispiel des Falls Franz Novak Verfasserin Nicole Schneider angestrebter akademischer Grad Magistra der Philosophie (Mag. phil) Wien, im Oktober 2008 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A 312 Studienrichtung lt. Studienblatt: Geschichte Betreuerin / Betreuer: Univ. Doz. Dr. Florian Freund 2 3 I. Einleitung 5 II. Methodik 11 III. Franz Novak – der „Fahrdienstleiter des Todes“ 16 1. Franz Novak – eine Biographie 16 Exkurs: Ungarische Juden in Auschwitz 33 2. Schreibtischtäter – die Diskussion um „normale Deutsche“ und das „banale Böse“ 36 IV. Der Fall Novak im Spiegel der Öffentlichkeit 44 1. Die Vorgeschichte der justiziellen Auseinandersetzung mit nationalsozialistischen Verbrechen in Österreich 44 Exkurs: Die mediale Berichterstattung in den Jahren 1945/46 in Beispielen 52 2. Das Jahr 1961 58 2.1. Die Entwicklung der Gerichtsbarkeit ab 1955 58 2.2. Der Fall Eichmann 60 2.3. Die Verhaftung von Franz Novak 64 2.4. Die Berichterstattung der Medien 69 2.4.1. Arbeiterzeitung (AZ) 69 2.4.2. Neues Österreich (NÖ) 72 2.4.3. Kurier 75 2.4.4. Illustrierte Kronen Zeitung (IKZ) 76 2.4.5. Volksstimme (VS) 77 2.4.6. Zusammenfassung 84 3. Das Jahr 1964 88 3.1. Die „Auschwitz-Prozesse“ 88 3.2. Der Fall Murer 93 3.3. Die erste Hauptverhandlung gegen Franz Novak 97 3.4. Die Berichterstattung der Medien 99 3.4.1. Arbeiterzeitung 99 4 3.4.2. Neues Österreich (NÖ) 108 3.4.3. Kurier 117 3.4.4. Illustrierte Kronen Zeitung (IKZ) 128 3.4.5. -

Auschwitz Im Bild
ARTIKEL Stefan Hördler · Christoph Kreutzmüller · Tal Bruttmann Auschwitz im Bild Zur kritischen Analyse der Auschwitz-Alben Auschwitz ist besonders in den letzten Jahrzehnten zu dem zentralen Symbol dessen geworden, was wir Holocaust oder Shoah nennen. Neben der Größe des Lager- komplexes, seiner Spezifik als Vernichtungs- und Arbeitslager, der Vielzahl der Opfer wie auch der relativ hohen Zahl von Überlebenden, die Zeugnis ablegen konnten, ist der Umfang der überlieferten zeitgenössischen Fotos sicherlich einer der Gründe für die Strahlkraft und die Wirkmächtigkeit von Auschwitz.1 In einem wechselseitigen Prozess haben die überlieferten Fotos nicht nur die Symbolkraft des Lagerkomplexes verstärkt, sondern auch unsere Vorstellungen von der Ermordung der Juden in Europa nachhaltig geprägt.2 Über die Luftbilder der Royal Air Force, die unter Lebensgefahr heimlich aufgenommenen Fotos des jüdischen Sonderkommandos in den Krematorien von Birkenau, die Bilder und Alben der Zentralbauleitung der Waffen-SS und Polizei Auschwitz, des SS-Standortarztes und weiterer Akteure der SS hinaus sind jedoch im Wesentlichen zwei Alben von besonderer Bedeutung. Während das eine Album mit dem Namen der jüdischen Finderin Lili Jacob verbunden ist, trägt das andere den Namen des ehemaligen Besitzers aus den Reihen der Lager-SS, Karl Höcker. Präsentiert das mit Lili Jacob verbundene Album gleichsam die Abwicklung des Massenmords aus Sicht der SS, erlauben uns Karl Höckers Fotos Einblicke in das Personalsystem der SS. Auch wenn die Alben eine ganz unterschiedliche Provenienzgeschichte besitzen und zwischen ihrer öffentlichen Entdeckung mehrere Jahrzehnte liegen, gehören sie, wie im Folgenden gezeigt werden soll, doch inhaltlich eng zusammen. Mit einer verschränkenden Analyse können aus 1 Christoph Kreutzmüller, Auschwitz als Symbol, in: Bundeszentrale für politische Bildung (Hrsg.), Auschwitz heute. -

Judgment and the Order of Passivity
Judgment and the Order of Passivity An Investigation of the Banality of Evil in the Cases of the Rwandan and Cambodian Genocides, and Modern Bureaucracy by Benjamin Waterman A thesis presented to the University of Waterloo in fulfillment of the thesis requirement for the degree of Doctor of Philosophy in Sociology Waterloo, Ontario, Canada, 2018 © Benjamin Waterman 2018 Examining Committee Membership The following served on the Examining Committee for this thesis. The decision of the Examining Committee is by majority vote. External Examiner Dr. Michael Dorland Professor, School of Journalism and Communication, Carleton University Supervisor Dr. Kieran Bonner Professor, Department of Sociology and Legal Studies, St. Jerome’s University in the University of Waterloo Internal Member Dr. Alan Blum Adjunct Faculty, Department of Sociology and Legal Studies, University of Waterloo Internal Member Dr. Marta Marin-Domine Adjunct Faculty, Department of Sociology and Legal Studies, University of Waterloo Internal-external Member Dr. Tristanne Connolly, Associate Professor, Department of English, St. Jerome’s University in the University of Waterloo ii Author’s Declaration I hereby declare that I am the sole author of this thesis. This is a true copy of the thesis, including any required final revisions, as accepted by my examiners. I understand that my thesis may be made electronically available to the public. iii Abstract In the controversy surrounding Hannah Arendt’s coverage of the Eichmann trial in Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil the discussion of her work has come to recognize that Arendt’s account of the banality of evil is not meant to excuse Adolf Eichmann for serving as the SS officer charged with overseeing the logistical arrangements needed to enact the Final Solution. -

The Frankfurt Auschwitz Trial and the German Press, 1963-1965, 12 Yale J.L
Yale Journal of Law & the Humanities Volume 12 | Issue 2 Article 4 January 2000 "I didn't know what Auschwitz was": The rF ankfurt Auschwitz Trial and the German Press, 1963-1965 Devin O. Pendas Follow this and additional works at: https://digitalcommons.law.yale.edu/yjlh Part of the History Commons, and the Law Commons Recommended Citation Devin O. Pendas, "I didn't know what Auschwitz was": The Frankfurt Auschwitz Trial and the German Press, 1963-1965, 12 Yale J.L. & Human. (2000). Available at: https://digitalcommons.law.yale.edu/yjlh/vol12/iss2/4 This Article is brought to you for free and open access by Yale Law School Legal Scholarship Repository. It has been accepted for inclusion in Yale Journal of Law & the Humanities by an authorized editor of Yale Law School Legal Scholarship Repository. For more information, please contact [email protected]. Pendas: "I didn't know what Auschwitz was" "I didn't know what Auschwitz was": The Frankfurt Auschwitz Trial and the German Press, 1963-1965 Devin 0. Pendas* On December 20, 1963, the Frankfurt Auschwitz trial opened before the State Court (Schwurgericht) at Frankfurt am Main. Ginther Leicher, covering the trial for the Allgemeine Zeitung/Neuer Mainzer Anzeiger, described the scene thus: "A huge mass of journalists, photographers and camera people from all over the world and half-empty seats in the visitors' gallery: these are the contradictory emblems of the public interest in the Auschwitz trial, which opened last Friday, four days before Christmas, in the Frankfurt City Council chambers."' In this Article, I examine the seeming paradox that the Auschwitz trial could attract such considerable attention from the mass media while remaining a matter of indifference, if not open hostility, for much of the German public. -

WAR TRIALS and CONSEQUENCES Professor Susan Benedict UT
1 IX. POST-WAR TRIALS AND CONSEQUENCES Professor Susan Benedict UT Health Science Center Houston, Texas, USA 77030 [email protected] 001-713-500-2039 Purpose of the Module: To descriBe the fate of the Nazi perpetrators in post-war trials. Suggested Readings: Pellegrino, E. (2010). “When Evil was Good and Good Evil: RememBrances of NUremBerg.” In Medicine after the Holocaust, edited bY Sheldon RUBenfeld. New York, Palgrave McMillan, p. 11. de Mildt, D. (1996). In the Name of the People: Perpetrators of Genocide in the Reflection of their Post- War ProsecUtion in West GermanY: The “EUthanasia” and “Aktion Reinhard” Trial Cases. The HagUe: MartinUs Nijhoff PUBlishers. Goldensohn, L. (2004). The NUremBerg Interviews, edited bY RoBert GellatelY. New York: Alfred A. Knopf. Annas, G. and Grodin, M. (1992). “The Doctors’ Trial and the Nuremberg Code.” In The Nazi Doctors and the NUremBerg Code. New York: Oxford UniversitY Press, p. 59. Jaworski, L. (1961). After Fifteen Years. New York: Gulf PUBlishing CompanY. Suggested Videos: “JUdgment at NUremBerg” availaBle from Amazon.com. “Verdict on AUschwitz: The FrankfUrt AUschwitz Trial 1963-1965” available from www.firstrUnfeatUres.com. Objectives: 1. To discUss the oUtcomes of the varioUs trials. 2. To evalUate the jUstice of the oUtcomes. Discussion Questions: 1. Was there a difference in oUtcomes depending Upon how soon after the war theY were held? 2. Was there a difference in oUtcomes depending Upon the coUntrY in which the trials were held? 3. Having committed and admitted to the same crimes, whY were some perpetrators execUted whereas others were acqUitted? 2 Synopsis: Trials of the perpetrators of Nazi GermanY Began in 1945, even Before the war ended, and were still Being prepared as recentlY as 2008.