Il Censimento Permanente Della Popolazione in Emilia-Romagna
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Landscape of the Great Land Reclamation
ra st ai BOLZANO·TRENTO·MANTOVA VENEZIA M i d o ROVIGO·PADOVA Villanova P Marchesana Landscape of the great land reclamation Bosaro Guarda o Ro - Copparo - Ostellato Crespino P F Veneta Fiume ium Berra e P Serravalle o Polesella ia GORINO FERRARESE Albersano Po di Venez Guarda Alberone Cologna Ferrarese 1 Ponte Punzetti Oasi Ariano Mulino del Po Ferrarese Zerbinate Oasi Stellata Bosco di Pilastri Ro Santa Malcantone Massenzatica Giustina FERRARA Coccanile Contane Ponti Oasi Isola Zocca Oasi Spagna Bonello Pepoli Oasi Bosco Ravalle Monticelli MesolaPineta di S. Giustina di Porporana Cesta Mesola Sabbioni Ambrogio S. Biagio Porporana Salvatonica Ruina Ponte S. Pietro Dune Fossili di Fossadalbero Mezzogoro Massenzatica Gavello Burana Oasi Isola Pescara FE206 Camatte Bianca P Casaglia Zenzalino o d Francolino P i G Francolino Italba o no Settepolesini c Oasi Isola d ca Saletta i o Ospitale Copparo G d Bianca Jolanda e o l Corlo Bosco r l Diamantina o a di Savoia Torbiera Mesola D Bondeno o Scortichino Pontelagoscuro n z Tamara Caprile e Correggio l Oasi Bacini Pontelangorino l Santa Gradizza Oasi Valle a Boara Zuccherificio Brazzolo Dindona Bianca Vigarano Oasi Goro Ponte Pieve Barco Gran Bosco Malborghetto Baura FE211 Oasi S. Bianca Rodoni di Boara 5 Fossalta Pomposa della Mesola Cassana Sabb. Formignana Oasi Bacini Pontemaodino Boschetti Vigarano Sabb. Gherardi Zuccherificio Pomposa Mizzana S. Pietro S. Vittore di Valle oleonico Giralda Sacca di Goro p Mainarda Porotto Viconovo a Gorino MODENA e Contrapò Albarea Pontegradellarares Ferrarese -

A Geophysical Transect Across the Central Sector of the Ferrara Arc: Detailed Gravimetric Survey – Part I F
GNGTS 2015 SESSIONE 1.2 A GEOPHYSICAL TRANSECT ACROSS THE CENTRAL SECTOR OF THE FERRARA ARC: DETAILED GRAVIMETRIC SURvey – pART I F. Palmieri1, A. Mantovani2, G. Santarato2 1 OGS (Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale) Trieste, Italy 2 Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra, Università degli Studi di Ferrara, Italy Introduction. The investigated area for this study is the eastern sector of the Po Plain that represents the foredeep basin of both Southern Alps and northern Apennines. We focused our attention on the Ferrara Arc (Fig. 1a), which is one of the major arcs, consisting of blind, north- verging thrusts and folds, which represent the external northern Apennines front (Pieri and Groppi, 1981; Bigi et al., 1982; Boccaletti et al., 2004). The recent tectonic activity of this area is well documented by the occurrence of moderate earthquakes, such as the 1570 Ferrara, and 1624 Argenta earthquakes (Guidoboni et al., 2007; Rovida et al., 2011) and recently in May 2012, when two moderate (Mw 6.1 and 5.9; e.g. Pondrelli et al., 2012) earthquakes affected the western Ferrara province. The bending of the topographic surface and the consequent uplift of the broader epicentral area are among the major coseismic effects due to the reactivation of reverse blind faults as, for example, in the case of the northern Apennines underlying the Po Plain: in fact, as a consequence of the fault geometry and kinematics, the rock volume above the co-seismic rupture tip is characterised by a typical fault-propagation folding process (Okada, 1985). Depending on the seismotectonic parameters of the underlying seismogenic source, the uplifted area has an 127 GNGTS 2015 SESSIONE 1.2 Fig. -

Piano Strutturale Comunale in Forma Associata ARGENTA-MIGLIARINO-OSTELLATO PORTOMAGGIORE-VOGHIERA
Copparo Piano Strutturale Comunale in Forma Associata ARGENTA-MIGLIARINO-OSTELLATO PORTOMAGGIORE-VOGHIERA PROVINCIA DI FERRARA Formignana Ferrara Codigoro Tresigallo PSC Gallumara L.R. 20/2000 Cona Quartesana Massa Fiscaglia SCHEMA DI ASSETTO STRUTTURALE DEL TERRITORIO: Migliaro UNITA' DI PAESAGGIO, INFRASTRUTTURE, AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE Masi -Torello Ducentola Tavola 1 Cornacervina Bivio Correggio Gualdo Valcesura Medelana MIGLIARINO Scala 1:50.000 Lagosanto Ponte Arzana Voghenza Rovereto stesura approvata Alberlungo VOGHIERA Campolungo Dogato San Vito Corte Centrale Sindaco di Argenta Antonio Fiorentini Sindaco di Migliarino Sabina Mucchi Sindaco di Ostellato Andrea Marchi Sindaco di Portomaggiore Gian Paolo Barbieri Sindaco di Voghiera Claudio Fioresi Gambulaga Libolla OSTELLATO GRUPPO DI LAVORO Coordinamento generale Runco arch. Natascia Frasson - responsabile dell'Ufficio di Piano Intercomunale Ufficio di Piano Montesanto San Giovanni Comune di Argenta - arch. Natascia Frasson, arch. Leonardo Monticelli Sandolo collaboratori - geom. Nicola Baldassari, dr.ssa Nadia Caucci, geom. Paolo Orlandi San Bartolomeo Maiero Comune di Migliarino - arch. Antonio Molossi in Bosco Comune di Ostellato - geom. Claudia Benini Comune di Portomaggiore - ing. Luisa Cesari, geom. Gabriella Romagnoli Comune di Voghiera - arch. Marco Zanoni collaboratori - geom. Massimo Nanetti Consulente responsabile del presente elaborato: tecnicoop Quartiere arch. Rudi Fallaci arch. Franco Tinti San Nicolò dott. agr. Fabio Tunioli Portorotta Comacchio dott. Paolo Trevisani arch. Barbara Marangoni PORTOMAGGIORE arch. Filippo Boschi cartografia - Andrea Franceschini Portoverrara LEGENDA Confini amministrativi Ripapersico UNITA' DI PAESAGGIO Limite delle unità di paesaggio Benvignante 3 - U.P. delle Masserie 4 - U.P. delle Valli del Reno 5 - U.P. delle Terre Vecchie Ospital Monacale 6 - U.P. della Gronda Santa Maria 7 - U.P. -

REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti Amministrativi GIUNTA REGIONALE Delibera Num
REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE Delibera Num. 2405 del 19/12/2019 Seduta Num. 45 Questo giovedì 19 del mese di dicembre dell' anno 2019 si è riunita nella residenza di via Aldo Moro, 52 BOLOGNA la Giunta regionale con l'intervento dei Signori: 1) Bianchi Patrizio Assessore 2) Corsini Andrea Assessore 3) Costi Palma Assessore 4) Gazzolo Paola Assessore 5) Mezzetti Massimo Assessore 6) Petitti Emma Assessore 7) Venturi Sergio Assessore Presiede l'Assessore Bianchi Patrizio attesa l'assenza del Presidente, ai sensi dell'art. 3, comma 2 L.R. 14/89 Funge da Segretario l'Assessore: Costi Palma Proposta: GPG/2019/2215 del 14/11/2019 Struttura proponente: SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOCIO EDUCATIVE DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE Assessorato proponente: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE Oggetto: APPROVAZIONE DELL'ELENCO DEI COMUNI E LORO FORME ASSOCIATIVE DA AMMETTERE AL FINANZIAMENTO DELLE RISORSE DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE. PROGRAMMAZIONE REGIONALE ANNO 2019. Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria Responsabile del procedimento: Gino Passarini pagina 1 di 56 Testo dell'atto LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Visti: - la Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, art. 1, commi 180 e 181 e specificamente lettera e); - il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della Legge 13 luglio 2015, n. -

Giorn Fase 2
2 DICEMBRE 2010 -La lista si riferisce ai passaggi delle reti Rai e Mediaset COMUNE REGIONE PROVINCIA RESIDENTI Argenta EMILIA ROMAGNA Ferrara 22.570 Codigoro EMILIA ROMAGNA Ferrara 12.615 Comacchio EMILIA ROMAGNA Ferrara 23.084 Formignana EMILIA ROMAGNA Ferrara 2.817 Goro EMILIA ROMAGNA Ferrara 3.976 Lagosanto EMILIA ROMAGNA Ferrara 4.846 Masi Torello EMILIA ROMAGNA Ferrara 2.402 Massa Fiscaglia EMILIA ROMAGNA Ferrara 3.682 Mesola EMILIA ROMAGNA Ferrara 7.187 Migliarino EMILIA ROMAGNA Ferrara 3.713 Migliaro EMILIA ROMAGNA Ferrara 3.139 Ostellato EMILIA ROMAGNA Ferrara 6.592 Portomaggiore EMILIA ROMAGNA Ferrara 12.397 Tresigallo EMILIA ROMAGNA Ferrara 4.613 Voghiera EMILIA ROMAGNA Ferrara 3.892 Bagno di Romagna EMILIA ROMAGNA Forlì-Cesena 6.191 Bertinoro EMILIA ROMAGNA Forlì-Cesena 10.901 Borghi EMILIA ROMAGNA Forlì-Cesena 2.703 Castrocaro Terme e Terra del Sole EMILIA ROMAGNA Forlì-Cesena 6.599 Cesena EMILIA ROMAGNA Forlì-Cesena 96.171 Cesenatico EMILIA ROMAGNA Forlì-Cesena 25.375 Civitella di Romagna EMILIA ROMAGNA Forlì-Cesena 3.840 Dovadola EMILIA ROMAGNA Forlì-Cesena 1.719 Forlì EMILIA ROMAGNA Forlì-Cesena 117.550 Forlimpopoli EMILIA ROMAGNA Forlì-Cesena 12.944 Galeata EMILIA ROMAGNA Forlì-Cesena 2.507 Gambettola EMILIA ROMAGNA Forlì-Cesena 10.367 Gatteo EMILIA ROMAGNA Forlì-Cesena 8.649 Longiano EMILIA ROMAGNA Forlì-Cesena 6.862 Meldola EMILIA ROMAGNA Forlì-Cesena 10.140 Mercato Saraceno EMILIA ROMAGNA Forlì-Cesena 7.002 Modigliana EMILIA ROMAGNA Forlì-Cesena 4.814 Montiano EMILIA ROMAGNA Forlì-Cesena 1.698 Portico e San Benedetto -

Subambito Ferrara Gestione Hera
Delibera CAMB/2020/39 nelle more approvazione ARERA 1,000 0,983 teta 2020 = 1,000 teta 2021 = 0,983 GESTIONE HERA S.p.A. - SUBAMBITO FERRARA TARIFFE 2020 TARIFFE 2021 POST TICSI POST TICSI SERVIZIO ACQUEDOTTO QUOTE VARIABILI QUOTE VARIABILI QUOTE VARIABILI ACQUEDOTTO ACQUEDOTTO FASCE DI CONSUMO USO DOMESTICO RESIDENTE 3 Tariffe applicate Tariffe applicate (m /anno) UNITA' DI MISURA PROCAPITE STANDARD (fasce per 3 componenti) nell'intero bacino nell'intero bacino da mc/anno a mc/anno Tariffa Agevolata 0 84 €/m3 1,212008 1,191404 Tariffa Base 84 132 €/m3 1,515009 1,489254 Tariffa 1° eccedenza 132 180 €/m3 2,124783 2,088662 Tariffa 2° eccedenza 180 senza limiti €/m3 2,770437 2,723340 FASCE DI CONSUMO USO DOMESTICO 3 Tariffe applicate Tariffe applicate (m /anno) UNITA' DI MISURA NON RESIDENTE (per u.i.) nell'intero bacino nell'intero bacino da mc/anno a mc/anno Tariffa Base 0 132 €/m3 1,515009 1,489254 Tariffa eccedenza 132 senza limiti €/m3 2,124783 2,088662 FASCIA DI CONSUMO USO NON DOMESTICO Tariffe applicate Tariffe applicate (mc/anno) UNITA' DI MISURA INDUSTRIALE nell'intero bacino nell'intero bacino da mc/anno a mc/anno Tariffa base 0 240 €/m3 1,515009 1,489254 Tariffa eccedenza 240 senza limiti €/m3 2,124783 2,088662 Sottotipologia idroesigenti (consumi > 200.000 mc/anno) 0 senza limiti €/m3 0,682516 0,670913 FASCIA DI CONSUMO USO NON DOMESTICO Tariffe applicate Tariffe applicate (mc/anno) UNITA' DI MISURA COMMERCIALE E ARTIGIANALE nell'intero bacino nell'intero bacino da mc/anno a mc/anno Tariffa base 0 240 €/m3 1,515009 1,489254 -

GUIDA ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA Tutto Quello Che C’È Da Sapere Per Diventare Campioni Di Riciclo
GUIDA ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA Tutto quello che c’è da sapere per diventare campioni di riciclo. Nell’ottica dei princìpi dell’economia Chi è Clara spa circolare, per CLARA è importante coinvolgere attivamente cittadini, istituzioni, soci e dipendenti in un modello Oggi gestisce la raccolta dei rifiuti in 21 dei 23 Comuni di sviluppo sostenibile (socialmente CLARA è la società ed economicamente), favorendo e a totale capitale della provincia di Ferrara: Berra, Bondeno, Cento, Codigoro, Comacchio, Copparo, Fiscaglia, Formignana, promuovendo la partecipazione collettiva pubblico nata nel Goro, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Masi Torello, Mesola, verso un interesse comune e premiando i 2017 dalla fusione Ostellato, Poggio Renatico, Portomaggiore, Ro, Terre del comportamenti virtuosi. tra Area e Cmv Reno, Tresigallo, Vigarano Mainarda e Voghiera. Raccolta. Terza società per dimensioni in Emilia-Romagna, CLARA è affidataria del servizio di gestione rifiuti in un bacino d’utenza che conta 120.000 clienti domestici e 13.500 non domestici, su un territorio di quasi 2.000 chilometri I servizi di Clara spa quadrati. Impiega circa 430 dipendenti. Il sistema di raccolta prevalente è quello domiciliare, che prevede in quasi tutto il territorio servito la raccolta porta i ritiri su chiamata di a porta di cinque frazioni materiali ingombranti, grandi potature, inerti domestici, di rifiuti (indifferenziato, pneumatici, eternit umido organico, imballaggi in plastica e lattine, carta e cartone, sfalci e potature). A queste si aggiunge il servizio di raccolta del vetro, perlopiù svolto i Centri comunali o tramite campane stradali, con l’eccezione di alcuni centri storici in intercomunali di raccolta cui anche per il vetro è attivo il servizio domiciliare. -

Using the Ecosystem Services Framework for Policy Impact
sustainability Article Using the Ecosystem Services Framework for Policy Impact Analysis: An Application to the Assessment of the Common Agricultural Policy 2014–2020 in the Province of Ferrara (Italy) Parthena Chatzinikolaou 1,* ID , Davide Viaggi 1 ID and Meri Raggi 2 ID 1 Department of Agricultural and Food Sciences, University of Bologna, 40127 Bologna, Italy; [email protected] 2 Department of Statistical Sciences, University of Bologna, 40126 Bologna, Italy; [email protected] * Correspondence: [email protected]; Tel.: +39-051-2096-120 Received: 2 February 2018; Accepted: 17 March 2018; Published: 20 March 2018 Abstract: The objective of this study is to test a methodology for the classification of areas according to the provision of ecosystem services and for the evaluation of the effects of different agricultural policy scenarios. The evaluation focuses on the different categories of Ecosystem Services (ES) and applies a set of indicators available from secondary data sources. Two scenarios were compared, represented by the pre-2014 CAP and the CAP 2014–2020, based on the measures of the RDP 2014–2020 focused on enhancing ecosystems. The approach was implemented under two weighting solutions. First, we assumed that all indicators have equal weight. As a further step, the framework was integrated with a weighting procedure in order to account for the different importance of the various ES indicators. All municipalities offer a significant number of provisioning and cultural services, mainly connected to recreational opportunities. The indicators with higher importance in the area represent provisioning, supporting and regulating services, while cultural services have received less attention. -

Ferrara Ostellato
Along the Po di Volano 6 Technical notes Pomposa Ferrara Second stage - From Ostellato to Pomposa Abbey Depart: Ostellato, Piazza Repubblica Ostellato ra st Arrive: Codigoro, Abbazia di Pomposa www.ferrarainfo.com ai M i d Length: 29,910 km Ferrara: o P Difficulty level: suitable for everyone. Level Castello Estense • tel. 0532 299303 Codigoro: route mainly along cycle paths (partly on dirt F Po track). Some stretches along minor roads with Abbazia di Pomposa • tel. 0533 719110 Fium iume e P Berra Serravalle little traffic. o Connections with other routes ia Albersano Po di Venez Guarda Alberone Cologna Railways Ferrarese Ponte 5 Ferrara - Ostellato Oasi Punzetti Ferrara/Codigoro Ariano 7 Ro - Ostellato Mulino del Po BicycleFerrarese transport available. Zerbinate Please check timetables and availability. 8 OstellatoOasi - Argenta Stellata Bosco di Pilastri Info: 800 91 50 30 • www.fer.it 10 MesolaSanta - Lidi di Comacchio - Comacchio Malcantone Zocca Ro Massenzatica Giustina Contane Ponti Oasi Isola Coccanile Spagna Oasi Bonello Pepoli Oasi Bosco Ravalle Codigoro Monticelli Pineta di di Porporana Mesola S. Giustina Fossadalbero Cesta Mesola Ambrogio S. Biagio Porporana Salvatonica RuinaFrom Ostellato, the meetingPonte place S. Pietro of many journeys and an agreeable centre for a born out of the left flankDune Fossiliof the di Po di Volano, more evidence of how everything Mezzogoro Massenzatica Gavello Burana Oasi Isola Pescara Sabbioni Bianca visitCamatte to nature reserves, the route follows the Po di Volano, identified in the Etrus- in the Ferrarese lands is determined by the presence of water. The journeyP arrives Casaglia Zenzalino o d Francolino P i G Francolino Codigoro Jolanda di Savoia ItalbaPomposa Abbey o no Settepolesini can Salettaperiod with the mythical Eridano. -

Masi Torello E Voghiera.Indd
COMUNE DI COMUNE DI MASI TORELLO VOGHIERA TOC TOC! L’AMBIENTE BUSSA ALLA TUA PORTA ECOCALENDARIO Comuni di Masi Torello e Voghiera gennaio 2014 – gennaio 2015 sfalci, foglie e piccole potature umido organico carta e cartone rifiuto non riciclabile imballaggi in plastica e lattine Le Vie Tutte le vie di Masi Torello e Voghiera sono interessate dal nuovo sistema di raccolta. Masi Torello • Piazza DEL MERCATO • Via DELLA BONIFICA • Via A. RESCAZZI • Piazza DELLA LIBERTÀ • Via DELLA COSTITUZIONE • Via RISORGIMENTO • Piazza G. MATTEOTTI • Via DELLA REPUBBLICA • Via M. RIZZATI • Piazza C. TOSCHI • Via DELLA RESISTENZA • Via ROMA • Piazzale PRIMAVERA • Via DELL’INDUSTRIA • Via ROVERE • Strada VICINALE BAROTTA • Via ERIDANIA • Via SAN GIACOMO • Via 11 SETTEMBRE • Via FILALANA • Via SAN LEO • Via D. ALIGHIERI • Via G. GARIBALDI • Via SAN LEONARDO • Via ARGINONE • Via GARISENDA • Via SANT’ ANNA • Via L. ARIOSTO • Via P. GOBETTI • Via SANT’ ANTONIO • Via V. BACHELET • Via A. GRAMSCI • Via SANTA CECILIA • Via E. BAGLIONI • Via J. F. KENNEDY • Via G. SARAGAT • Via N. BIXIO • Via M. L. KING • Via SPINA • Via E. CAZZANTI • Via MALERBA • Via T. TASSO • Via COLL. S.ANNA - S. GIACOMO • Via MALVEZZA • Via TROTTE • Via CORTA • Via L. MANARINI • Via VANETICA • Via CREMONA • Via G. MAZZINI • Via ZANARDI PROSPERI • Via DEI FRUTTETI • Via DON G. MINZONI • Viale ADRIATICO • Via DEI GIOCHI • Via A. MORO • Viale EUROPA • Via DEI MASI • Via PAGANO • Vicolo NUOVO • Via DEI MESTIERI • Via G. PASCOLI • Vicolo PREVOSTURA • Via DEI PINI • Via PORTUENSE Voghiera • Piazza MONS. A. CREPALDI • Via DELLA CONCORDIA • Via PACINOTTI • Piazza DON P. CRISTOFORI • Via DELLA PACE • Via PONTIDA • Piazza L. -

Rankings Municipality of Masi Torello
9/25/2021 Maps, analysis and statistics about the resident population Demographic balance, population and familiy trends, age classes and average age, civil status and foreigners Skip Navigation Links ITALIA / Emilia-Romagna / Province of Ferrara / Masi Torello Powered by Page 1 L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Adminstat logo DEMOGRAPHY ECONOMY RANKINGS SEARCH ITALIA Municipalities Argenta Stroll up beside >> Fiscaglia Bondeno Goro Cento Jolanda di Codigoro Savoia Comacchio Lagosanto Copparo Masi Torello Ferrara Mesola Ostellato Poggio Renatico Portomaggiore Riva del Po Terre del Reno Tresignana Vigarano Mainarda Voghiera Provinces Powered by Page 2 BOLOGNA MODENA L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin AdminstatFERRARA logo PARMA DEMOGRAPHY ECONOMY RANKINGS SEARCH FORLÌ-CESENA PIACENZAITALIA RAVENNA REGGIO NELL'EMILIA RIMINI Regions Abruzzo Liguria Basilicata Lombardia Calabria Marche Campania Molise Città del Piemonte Vaticano Puglia Emilia- Repubblica di Romagna San Marino Friuli-Venezia Sardegna Giulia Sicilia Lazio Toscana Trentino-Alto Adige/Südtirol Umbria Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste Veneto Municipality of Masi torello Territorial extension of Municipality of MASI TORELLO and related population density, population per gender and number of households, average age and incidence of foreigners Powered by Page 3 L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin TERRITORY DEMOGRAPHIC DATA Adminstat logo DEMOGRAPHY ECONOMY(YEAR RANKINGS2019) SEARCH ITALIA Emilia- Region Romagna Inhabitants (N.) 2,306 Province Ferrara Families (N.) 1,047 Sign Province FE Males (%) 46.8 Hamlet of the 11 municipality Females (%) 53.2 Surface (Km2) 22.71 Foreigners (%) 6.3 Population density Average age 101.6 50.3 (Inhabitants/Kmq) (years) Average annual variation -0.45 (2014/2019) MALES, FEMALES AND DEMOGRAPHIC BALANCE FOREIGNERS INCIDENCE (YEAR 2019) (YEAR 2019) Balance of nature [1], Migrat. -
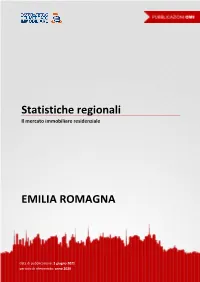
Statistiche Regionali Emilia Romagna 2021
Statistiche regionali Il mercato immobiliare residenziale EMILIA ROMAGNA data di pubblicazione: 3 giugno 2021 periodo di riferimento: anno 2020 a cura della Direzione Regionale dell’Emilia Romagna (Nerina Reggiani) in collaborazione con Direzione provinciale di Bologna – Ufficio Provinciale Territorio (Maurizio Tesini) Direzione provinciale di Ferrara – Ufficio Provinciale Territorio (Bruna Mantovani) Direzione provinciale di Forlì-Cesena – Ufficio Provinciale Territorio (Pamela Massi) Direzione provinciale di Modena – Ufficio Provinciale Territorio (Simone Tili) Direzione provinciale di Parma – Ufficio Provinciale Territorio (Gianluigi Tozzi) Direzione provinciale di Piacenza – Ufficio Provinciale Territorio (Valerio Guasconi) Direzione provinciale di Ravenna – Ufficio Provinciale Territorio (Roberto Biral) Direzione provinciale di Reggio Emilia – Ufficio Provinciale Territorio (Valter Scarpa) Direzione provinciale di Rimini – Ufficio Provinciale Territorio (Marco Nicolai) in collaborazione con Ufficio Statistiche e studi sul mercato immobiliare, DC SEOMI Direzione Centrale Servizi Estimativi e Osservatorio Mercato Immobiliare [email protected] data di pubblicazione: 3 giugno 2021 periodo di riferimento: anno 2020 Le informazioni rese nella presente nota sono di proprietà esclusiva dell’Agenzia delle Entrate. Non è consentito vendere, affittare, trasferire, cedere i dati contenuti in questa pubblicazione, o assumere alcune altre obbligazioni verso terzi. Le informazioni possono essere utilizzate, anche ai fini della loro elaborazione,