CORE View Metadata, Citation and Similar Papers at Core.Ac.Uk
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
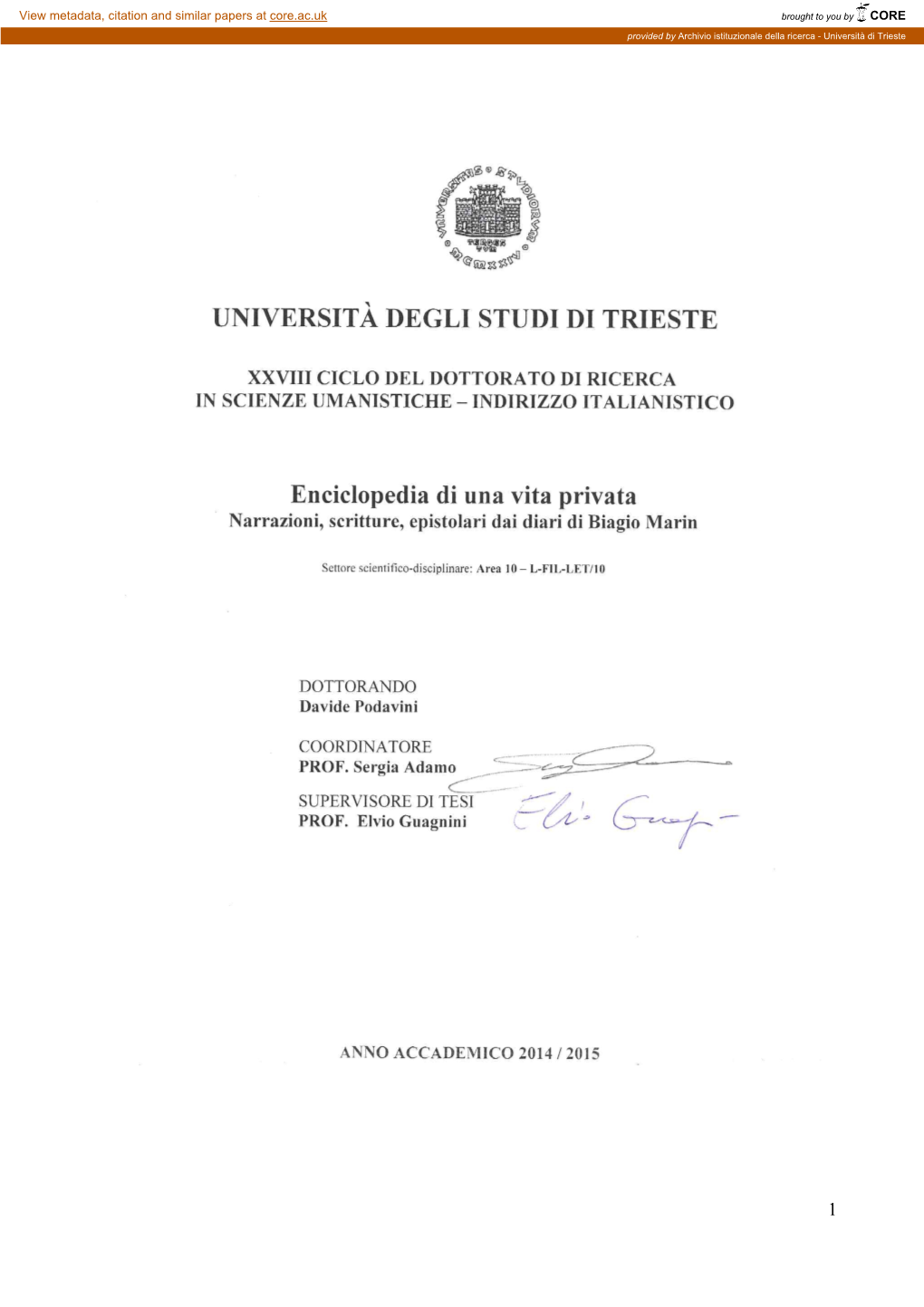
Load more
Recommended publications
-

Between the Local and the National: the Free Territory of Trieste, "Italianita," and the Politics of Identity from the Second World War to the Osimo Treaty
Graduate Theses, Dissertations, and Problem Reports 2014 Between the Local and the National: The Free Territory of Trieste, "Italianita," and the Politics of Identity from the Second World War to the Osimo Treaty Fabio Capano Follow this and additional works at: https://researchrepository.wvu.edu/etd Recommended Citation Capano, Fabio, "Between the Local and the National: The Free Territory of Trieste, "Italianita," and the Politics of Identity from the Second World War to the Osimo Treaty" (2014). Graduate Theses, Dissertations, and Problem Reports. 5312. https://researchrepository.wvu.edu/etd/5312 This Dissertation is protected by copyright and/or related rights. It has been brought to you by the The Research Repository @ WVU with permission from the rights-holder(s). You are free to use this Dissertation in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you must obtain permission from the rights-holder(s) directly, unless additional rights are indicated by a Creative Commons license in the record and/ or on the work itself. This Dissertation has been accepted for inclusion in WVU Graduate Theses, Dissertations, and Problem Reports collection by an authorized administrator of The Research Repository @ WVU. For more information, please contact [email protected]. Between the Local and the National: the Free Territory of Trieste, "Italianità," and the Politics of Identity from the Second World War to the Osimo Treaty Fabio Capano Dissertation submitted to the Eberly College of Arts and Sciences at West Virginia University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Modern Europe Joshua Arthurs, Ph.D., Co-Chair Robert Blobaum, Ph.D., Co-Chair Katherine Aaslestad, Ph.D. -

Scipio Slataper
BOLLETTINO BIO- BIBLIOGRAFICO su SCIPIO SLATAPER COMPILATO DA VERA SPANO TRIESTE 1944 BOLLETTINO BIO- BIBLIOGRAFICO su SCIPIO SLATAPER COMPIL ATO DA TRI ESTE 1944 >A lr0 7 5tATA f f/Z F ) O) BASCR • IIIV .TS iLATAPER 'F )101 DALLE ARTI GRAFICHE L. SMOLARS & NIPOTE TRIESTE l 944 N.IIN . ASII 4639 Non è scemato il consenso alle .opere di [email protected]; anzi pur in questo fermento di idee e di passioni in cui si agita .la nostra vita, noi v.ediamo i giovanissimi accostarsi a l,ui con amore ·e· atten zkme devota come ad. una schietta •.fori te; · è recentissima la nuova edizione del «Mio Carso», la ristampa:. della traduzione della Giu ditta, e sta per apparireTauspicatissima edizione dell' Ibsen, opera fondamentale per la conoscenza dél·tèatrn del gr=de norvegese, e tale da offrirci la possibilità di valutare la profonda maturità critica dello scrittore. ·SL prepara anche una raccolta degli scritti inediti, che, senza pretesa di arricchire la complessa figura dello Slataper, varranno ad illuminare molti aspetti caratteristici del suo pensiero e della sua evoluzione spirituale, completando armonicamente le opere da lui destinate a le stampe. Poichè molte interesse-mli notizie potrebbero =dare disperse e per fornire esatto materiale alle ricerche e agli studi di coloro che con tanto interesse si occupano dell'opera e del pensiero di questo nostro grande scrittore, è parso utile compilare questo opuscolo, in cui a brevi notizie di carattere biografico, seguirà il catalogo delle varie edizioni delle opere dello Slataper, e, infine l'elenco, il più esatto possibile degli studi critici a lui dedicati. -

Brochure Lignano Eng
Seaside holidays with a difference A melting pot for Latin, Germanic and Slav civilizations. Beaches of fine sand and a sea gently sloping away in Lignano and Grado, inlets embedded between white rocks in Trieste. Enchanting places, all year round. espite its limited extension, the And the allure of this area lasts well D coastline of Friuli Venezia Giulia beyond the summer months. offers many different facets of typical The fascination of Friuli Venezia Giulia Mediterranean appeal: surroundings and coast is just as intense in the spring, landscapes that astonish visitors because autumn and even winter. Mediterranean of the incredible contrasts in the space This is when the beaches are ideal for of a few miles. long romantic strolls. Grado is animated This is right where the Adriatic laps at by its centuries-old fishing tradition, with the shores of central Europe, offering delicious freshly caught fish skilfully a meeting between Latin, Germanic prepared by the local restaurants. and Slavic Mediterranean cultures. Northwards, the Trieste gulf, swept beaches From Lignano Sabbiadoro to Grado, the frequently by the impetuous north-easterly Friuli Venezia Giulia coast welcomes you Bora wind, offers a more introspective with its inviting and relaxing appeal. relationship with the sea. Here you’ll find broad sandy beaches From Duino to Sistiana and through to with their characteristic soft golden-brown Trieste itself, the coastline features a coloured sand and dunes. succession of sheer white cliffs interspersed in the heart And the sea is absolutely irresistible, with areas of dense Mediterranean vegetation. with its shallow waters and relaxing waves It’s also an ideal destination for summer that break gently on the beach. -

The Ends of an Empire: Pier Antonio Quarantotti Gambiniʼs Il Cavallo Tripoli and Joseph Rothʼs Radetzkymarsch
7KH(QGVRIDQ(PSLUH3LHU$QWRQLR4XDUDQWRWWL*DPELQLV ,OFDYDOOR7ULSROLDQG-RVHSK5RWKV5DGHW]N\PDUVFK 6DVNLD(OL]DEHWK=LRONRZVNL Comparative Literature Studies, Volume 52, Number 2, 2015, pp. 349-378 (Article) 3XEOLVKHGE\3HQQ6WDWH8QLYHUVLW\3UHVV For additional information about this article http://muse.jhu.edu/journals/cls/summary/v052/52.2.ziolkowski.html Access provided by Duke University Libraries (3 Aug 2015 12:23 GMT) the ends of an empire: pier antonio quarantotti gambini’s IL CAVALLO TRIPOLI and joseph roth’s RADETZKYMARSCH Saskia Elizabeth Ziolkowski abstract Italian Triestine literature tends to be seen as somewhat foreign to the Italian literary tradition and linguistically outside of Austrian (or Austro-Hungarian) literature. Instead of leaving it as “neither nor,” viewing it as “both and” can help shape the critical view of the Italian literary landscape, as well as add to the picture of Austro-Hungarian literature. Joseph Roth’s Radetzkymarsch (Radetzky March) and Pier Antonio Quarantotti Gambini’s novel Il cavallo Tripoli (The Horse Tripoli) depict the experience of loss brought on by the fall of the Austro-Hungarian Empire in similar ways, although they do so from different linguistic and national sides. However, the writings of the Italian author are generally categorized as representing a pro-Italian perspective and those of the Austrian as pro-Austro-Hungarian. This article argues that their novels provide a more nuanced portrayal of the world and identities than just their nationalities or political views do. Because of assumptions about the authors, the complexity of the novels’ representations of layered linguistic and cultural interactions have often been missed, especially those of Il cavallo Tripoli. -

Biagio Marin in Alcune Lettere (1952-1982) a Riccardo Maroni
MARIO ALLEGRI «SORRIDO E CONTINUO A MORIRE MEGLIO CHE POSSO» BIAGIO MARIN IN ALCUNE LETTERE (1952-1982) A RICCARDO MARONI ABSTRACT - Letters from the poet B Marin to R Maroni KEY WORDS - B Marin, R Maroni, Italian poetry in XX century, Dialectal poetry RIASSUNTO - Lettere del poeta B Marin a R Maroni PAROLE CHIAVE - B Marin, R Maroni, Poesia italiana del Novecento, Poesia dialet- tale NellArchivio Riccardo Maroni custodito presso la Biblioteca Civica «GTartarotti» di Rovereto figurano circa trecento tra lettere, cartoline e biglietti postali inviati da Biagio Marin allingegnere di Riva del Garda in oltre trentanni (1952-1985) di corrispondenza (1) Figura curiosa e inte- ressante quella di Riccardo Maroni (1896-1993), anche se inspiegabil- (1) LArchivio Maroni conserva una quantità ingente di materiali, per lo più lettere e documenti della sua attività editoriale e giornalistica, ancora non oggetto di studio Le lettere di Marin, mescolate a fotocopie, a ritagli di giornali e ad altre corrispondenze con amici e parenti del poeta, non sono ordinate cronologicamente; tutte presentano sottolineature a matita e richiami a margine, ad opera di Maroni, di passi ritenuti im- portanti e annotazioni puntuali sulle date di ricevuta e di risposta per ciascuna di esse; dal 1978 risultano dattiloscritte, con la sola firma autografa del poeta ormai quasi del tutto cieco Le lettere sono state riprodotte fedelmente (in tre casi soltanto abbiamo ritenuto di omettere qualche riga, di riferimento eccessivamente personale), rispettan- done anche la particolarissima, -

'Outside Perspective' to the Works of Kosovel by Illustrating And
K.Pizzi, 17/11/07, 12:52 [article published in Kosovelova Poetika/ Kosovel’s Poetics, special issue of Primerjalna knjizevnost 28(2005), pp. 239-249] ‘QUALE TRIESTINITA`?’: VOICES AND ECHOES FROM ITALIAN TRIESTE Abstract: In focusing on Italian Trieste and, in particular, on as large as possible a corpus of Triestine poetry contemporary to S.Kosovel, my paper provides a perspective that is peripheral and ‘outside’. Special attention is paid to the Futurist avant-garde: the Futurist leader Marinetti considered Trieste as Futurist city par excellence and the first Futurist soirees took place at Teatro Rossetti between 1909 and 1910. Futurism attracted a large group of local artists, some of whom (e.g. Carmelich and Cernigoj) were personally known by and became close to Kosovel. The poets Sanzin and Miletti espoused enthusiastically the Futurist linguistic experimentalism, as well as the movement’s national/nationalist tendencies. Poetry of national and romantic inspiration is also of fundamental importance: Slataper’s vitalist approach to the rugged Karst region, though pre-Great War, provides scope for comparative approaches. Nationalist poetry, much of which officially compromised with the Fascist regime (Cambon, Corraj, Alma Sperante), is equally integral to the Triestine cultural landscape of the 1920s and ‘30s. By shedding light on a significant portion of poetry in Italian arising from the vibrant, if largely hostile, cultural environment of Trieste, my paper invites an implicit rather than explicit assessment of Kosovel’s role and contribution to the European avant-garde. 1 K.Pizzi, 17/11/07, 12:52 ‘QUALE TRIESTINITA`?’: VOICES AND ECHOES FROM ITALIAN TRIESTE In re-evaluating as large as possible a corpus of Triestine poetry in Italian, my article intends to court the poetics and production of Šrečko Kosovel. -

Transnational Female Identity and Literary Narratives Between Italy and Eastern Europe
UNIVERSITY OF CALIFORNIA Los Angeles Cartographies of Estrangement: Transnational Female Identity and Literary Narratives between Italy and Eastern Europe A dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree Doctor of Philosophy in Italian by Renata Redford 2016 © Copyright by Renata Redford 2016 ABSTRACT OF DISSERTATION Cartographies of Estrangement: Transnational Female Identity and Literary Narratives between Italy and Eastern Europe by Renata Redford Doctor of Philosophy in Italian University of California, Los Angeles, 2016 Professor Lucia Re, Chair This dissertation investigates a vital body of women’s writing in Italian about the estranging effects of migration in order to emphasize the articulation of a literary discourse that undermines conventional depictions of the Eastern European female migrant. I provide evidence of the emergence in their work of a distinctly transnational approach to literary writing (narrative in particular), founded on a creative way of addressing questions of estrangement, the body, and memory. I consider the work of three authors, who have yet to be fully acknowledged in the Italian literary landscape: the Italophone writers Jarmila Očkayová (1955-present; Italo- Slovakian) and Ingrid Beatrice Coman (1971-present; Italo-Romanian living in Malta), and Marisa Madieri (1938-1996; Italo-Hungarian from Istria), whose native language was Italian. My analysis focuses on the stylistic, thematic, and structural elements that Očkayová, Coman and Madieri employ to engage with and -

Catalogo 1976-2020 Le Collane Delle Edizioni San Marco Dei Giustiniani in Genova
PREMIO NAZIONALE PER LA TRADUZIONE 2001 assegnato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali i an ni sti iu G ei d co a ar ov M en an G i S in on izi Ed go alo 0 at 02 C -2 76 19 Le collane delle Edizioni San Marco dei Giustiniani in Genova CATALOGO STORICO Quaderni di poesia pag. 1 Poeti della Riva Sud del Mediterraneo pag. 5 La Biblioteca ritrovata pag. 6 Quaderni del tempo pag. 9 Quaderni sbarbariani pag. 12 pag. 13 Quaderni in lettere d’azzurro i libri possibili pag. 14 I Quaderni della Fondazione pag. 14 I Cataloghi della Fondazione pag. 15 Quaderni di musica pag. 16 i Fu oric ollana pag. 16 Pietre di luna pag. 18 Altri titoli pag. 19 Il leudo pag. 20 Tras parenze (rivista) pag. 21 1 Quaderni di poesia Günter Grass Ventisette poesie (testo a fronte) tradotto e presentato da G. Cusatelli, introduzione di M. Luzi Dei volumi contrassegnati da asterisco è stata stampata anche un’edizione per bibliofili (in 65 esemplari) contenente una acqua - 1979, pp. 84, € 15,00 – * acquaforte di D. Bec forte appositamente eseguita. Franco Fortini Una obbedienza Alfonso Gatto con una prefazione di A. Zanzotto Lapide 1975 ed altre cose 1980, pp. 72, esaurito – * acquaforte di E. Morlotti con una prefazione di G. Vigorelli e uno scritto di G. Caproni 1976, pp. 44, esaurito – * acquaforte di G. Soffiantino Gyula Illyes La vela inclinata (testo a fronte) Biagio Marin tradotto e presentato da U. Albini, introduzione di G. Raboni Pan de pura farina 1980, pp. -

It529/2000-2001 Mainstream and Marginality: the Literature of Trieste
IT529/2000-2001 MAINSTREAM AND MARGINALITY: THE LITERATURE OF TRIESTE -Part II (Final Year) Course code: IT529 -1 Unit, Teaching Period I (weeks 1-12) Title: Mainstream and Marginality in Italian Literature: The Literature of Trieste Department: S.E.C.L. (Italian) Convenor and Teacher: Dr.Katia Pizzi ; email: [email protected]; office: CNW 219; ext.7909. OFFICE HOURS: Tuesday 12-13 and Thursday 4-5 Relationship to Other Courses: A sound knowledge of Italian is a prerequisite for this course. Students must be finalists. The course is not compulsory and is available as a wild course. Aims and objectives: The course is designed as an introduction to Italian literature of the late XIX and XX century in a regional perspective. The focus will be on the city of Trieste and its hinterland. Students will concentrate on the close reading of texts in Italian and will develop skills to deal with different kinds of textual material: narrative fiction, poetry in Italian and dialect, film. Handbook entry: This course focuses on possibily the most interesting region in Italy on the North-Eastern border. The interest derives from the great variety of literary influences experienced locally, the anxiety generated by the proximity of the border, and the ‘difficult’ relationship established with the culture of the motherland Italy. The emphasis will be on literature, culture and history. Though not specifically linguistic, local varieties (i.e. dialects) will also be dealt with. Students will have a chance to become acquainted with a wide range of textual material: film, poetry both in Italian and dialect and narrative fiction. -

VOLUME PRIMO Prefazione Di Gian Luigi Beccaria Xix Introduzione Di Raffaella Scarpa Xxv 1934 Difesa Della Poesia 5 1935
INDICE VOLUME PRIMO Prefazione di Gian Luigi Beccaria xix Introduzione di Raffaella Scarpa xxv 1934 Difesa della poesia 5 1935 «Confidenza» di Luigi Fallacara 11 «Inviti della memoria» 15 Poesia d'un uomo di fede 19 «Amore all'antica» 23 «II paese senza tempo» 27 1936 Arti belle in Liguria 33 Bilancio di Fiumi 41 «Nota sul Don Garzia» 45 Aldo Capasso, poeta dell'azione 49 1937 Un'antologia 55 Ravegnani 59 Note critiche. Alcuni utili luoghi comuni 63 Viaggio sentimentale in Ungheria 67 Attualità di Leopardi 71 Capasso critico 73 VI INDICE 1938 Giovanni Necco e la letteratura tedesca 79 Angiolo Silvio Novaro 83 La parola di Mussolini 85 Le poesie di Renato Mucci 87 1939 Zannerio, Alessi, Capalozza 91 La «Carta della Scuola» 95 Olimpica Mensa 99 Fontanelli, Cartella Gelardi 101 D'Agostini 103 Sotgiu 105 DeZuani 107 Trasanna, Caretti, Gattinoni 109 Magnani 113 1940 Prestinenza 117 «Quaderno Affricano» 119 Brandi, Cavicchioli, Zagarrio, Scurto, Pasini Vidali 123 Testimonianza di Ciarlantini 125 Luzi, Orecchio, Imbornone 129 In margine alle poesie di Gatto 133 De Libero, Gambetti, Lajolo 137 Zagarrio, Carta 141 1945 Lettera da Genova 145 «II libro del forestiero» 153 1946 Lavorare, lavorare, produrre . 159 Le 'borgate' confino di Roma 163 Viaggio fra gli esiliati di Roma 167 Pro e contro I 173 Pro e contro II 175 Pro e contro III 177 L'ermetismo e i più giovani 179 Bigiaretti storico d'errori 183 Scrittura prefabbricata e linguaggio 187 Erano ragazzi senza un soldo in tasca 191 PROSE CRITICHE VII 1947 «Canti civili» 197 II quadrato della verità -

Unione Italiana Sommario
Bolle ttino del Centro di Ricerche Storiche Unione Italiana Sommario Editoriale (G. Radossi) pag. 1 Settembre 1943: i "buchi" nella storia regionale (L. Giuricin) pag.2 Conservazione sul territorio della civiltà italiana (A. Borme) pag.4 Quale informazione? (M. Tremul) pag.8 Notiziario (rubrica a cura di M. Ferrara) pagg. 9-11 Laterizi bollati dell'agro vertenegliese (R. Cigui) pag. 12 l fiori dell'lstria (C. Pericin) pag. 14 L.:lstria d'oro di Biagio Marin (A. Perii) pag. 17 Buie, lapidi della memoria (D. Visintin) pag. 19 La Comunità nazionale e la nuova realtà sociale (F. SUran) pag.21 Nuovi arrivi (rubrica a cura di D. Schiozzi) pag.24 ~ La Ricerca no 16 Unione Italiana - Centro di Ricerche Storiche di Rovigno Redazione ed amministrazione Piazza Matteotti 13, Rovigno d'lstria tel. 052 (da Italia e Slovenia: 00385/52) 811-133 Fax (052) 815-786 -[!ndirizzo Internet (sperimentale): www.dsgs.univ.trieste.i!J e-mail: [email protected] Comitato di redazione Marisa Ferrara Alessio Radossi Giovanni Radossi Fulvio Suran Silvano Zilli Direttore responsabile Giovanni Radossi Redattore Alessio Radossi Coordinatore Silvano Zilli Ideazione grafica e impaginazione Alessio Radossi e Massimo Radossi Fotocomposizione Elleci srl di Claudio Luglio Stampa Litografia Ricci Trieste Stampato con il contributo dell'Università Popolare di Trieste © 1996Proprietà letteraria riservata secondo le leggi vigenti Editoriale '~tti'': un quarto di secolo Memoria storica e identità nazionale Le aree marginali in cui vivono nuclei diramati di ricerca storiografica nella nostra area, fece sorgere parec singole nazionalità richiamano sempre di più l'attenzio chie perplessità da ogni parte: noi tentammo di compren ne della storia sociale e dell'antropologia storica; queste derle, ma non di giustificarle. -

Anali Za Istrske in Mediteranske Študije Annali Di Studi Istriani E
Anali za istrske in mediteranske študije Annali di Studi istriani e mediterranei Annals for Istrian and Mediterranean Studies Series Historia et Sociologia, 30, 2020, 1 UDK 009 Annales, Ser. hist. sociol., 30, 2020, 1, pp. 1-176, Koper 2020 ISSN 1408-5348 UDK 009 ISSN 1408-5348 (Print) ISSN 2591-1775 (Online) Anali za istrske in mediteranske študije Annali di Studi istriani e mediterranei Annals for Istrian and Mediterranean Studies Series Historia et Sociologia, 30, 2020, 1 KOPER 2020 ANNALES · Ser. hist. sociol. · 30 · 2020 · 1 ISSN 1408-5348 (Tiskana izd.) UDK 009 Letnik 30, leto 2020, številka 1 ISSN 2591-1775 (Spletna izd.) UREDNIŠKI ODBOR/ Roderick Bailey (UK), Simona Bergoč, Furio Bianco (IT), COMITATO DI REDAZIONE/ Alexander Cherkasov (RUS), Lucija Čok, Lovorka Čoralić (HR), BOARD OF EDITORS: Darko Darovec, Goran Filipi (HR), Devan Jagodic (IT), Vesna Mikolič, Luciano Monzali (IT), Aleksej Kalc, Avgust Lešnik, John Martin (USA), Robert Matijašić (HR), Darja Mihelič, Edward Muir (USA), Vojislav Pavlović (SRB), Peter Pirker (AUT), Claudio Povolo (IT), Marijan Premović (ME), Andrej Rahten, Vida Rožac Darovec, Mateja Sedmak, Lenart Škof, Marta Verginella, Špela Verovšek, Tomislav Vignjević, Paolo Wulzer (IT), Salvator Žitko Glavni urednik/Redattore capo/ Editor in chief: Darko Darovec Odgovorni urednik/Redattore responsabile/Responsible Editor: Salvator Žitko Urednika/Redattori/Editors: Urška Lampe, Gorazd Bajc Prevajalci/Traduttori/Translators: Petra Berlot (it.) Oblikovalec/Progetto grafico/ Graphic design: Dušan Podgornik , Darko