Calabro-Grecismi Non Bovesi
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Mare E Monti Dell'aspromonte!
Trekking nel Parco Nazionale dell’Aspromonte Mare e Monti dell’Aspromonte! Tra il mare e i monti per vivere una meravigliosa esperienza naturalistica, culturale ed umana nel sud più profondo dell’ultimo lembo di terra ancorato allo Stivale, uno degli angoli più intatti e meno “esplorati” della Calabria ovvero il Parco Nazionale dell’Aspromonte. Un luogo davvero magico, inaspettato e capace di stupire sotto molti profili. Qui la natura è straordinaria e singolare, caratterizzata dal contrasto tra la montagna con i suoi rilievi che arrivano quasi a 2000 metri e il mare che la circonda quasi come se fosse un’isola. Il programma offre la possibilità di immergersi in questo territorio tra le sue fiumare fosforescenti nelle notti di luna piena, i suggestivi paesi fantasma ed un’isola “grecanica” che parla la lingua di Omero e che conserva usi e tradizioni millenari, tramandati di casa in casa, di focolare in focolare, senza trascurare i tanti bagni nelle limpide acque del Mare Jonio. “pis trechi glìgora de thorì tìpote” (chi va veloce non vede nulla) Durata del Trekking: 8 giorni/7 notti. Numero partecipanti: minimo 06 Viaggio: arrivo/partenza a/da Reggio Calabria Soggiorno: case dell’Ospitalità Diffusa a Bova, azienda Agrituristica ad Amendolea, casette al mare. Tipologia E: non è richiesta una preparazione escursionistica da esperti. Programma 1°giorno 18/06: Benvenuti nell’ Aspromonte Greco e nella terra del Bergamotto! Appuntamento con la guida alle ore 13 alla stazione FS Centrale di Reggio Calabria. Visita al Museo Nazionale della Magna Grecia ( Ospitante i famosi Bronzi di Riace ). Possibilità di passeggiata sul Lungomare di Reggio Calabria: il chilometro più bello d’Italia (D’Annunzio). -
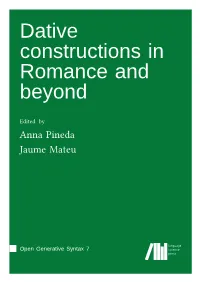
Dative Constructions in Romance and Beyond
Dative constructions in Romance and beyond Edited by Anna Pineda Jaume Mateu language Open Generative Syntax 7 science press Open Generative Syntax Editors: Elena Anagnostopoulou, Mark Baker, Roberta D’Alessandro, David Pesetsky, Susi Wurmbrand In this series: 1. Bailey, Laura R. & Michelle Sheehan (eds.). Order and structure in syntax I: Word order and syntactic structure. 2. Sheehan, Michelle & Laura R. Bailey (eds.). Order and structure in syntax II: Subjecthood and argument structure. 3. BacskaiAtkari, Julia. Deletion phenomena in comparative constructions: English comparatives in a crosslinguistic perspective. 4. Franco, Ludovico, Mihaela Marchis Moreno & Matthew Reeve (eds.). Agreement, case and locality in the nominal and verbal domains. 5. Bross, Fabian. The clausal syntax of German Sign Language: A cartographic approach. 6. Smith, Peter W., Johannes Mursell & Katharina Hartmann (eds.). Agree to Agree: Agreement in the Minimalist Programme. 7. Pineda, Anna & Jaume Mateu (eds.). Dative constructions in Romance and beyond. ISSN: 25687336 Dative constructions in Romance and beyond Edited by Anna Pineda Jaume Mateu language science press Pineda, Anna & Jaume Mateu (eds.). 2020. Dative constructions in Romance and beyond (Open Generative Syntax 7). Berlin: Language Science Press. This title can be downloaded at: http://langsci-press.org/catalog/book/258 © 2020, the authors Published under the Creative Commons Attribution 4.0 Licence (CC BY 4.0): http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ISBN: 978-3-96110-249-5 (Digital) 978-3-96110-250-1 -

Urban Form, Public Life and Social Capital - a Case Study of How the Concepts Are Related in Calabria, Italy
EXAMENSARBETE INOM SAMHÄLLSBYGGNAD, AVANCERAD NIVÅ, 30 HP STOCKHOLM, SVERIGE 2019 Urban form, public life and social capital - a case study of how the concepts are related in Calabria, Italy SOFIA HULDT KTH SKOLAN FÖR ARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNAD Abstract The aim of this thesis is to investigate the urban structure of two Italian towns based upon physical structure and social function. The towns are Bova and Bova Marina in the ancient Greek part of Calabria, Area Grecanica. This is done by answering the research questions about how the urban structures are and what preconditions there are for public life and in extension social capital. This is also compared to the discourse in research about Calabria as a region lacking behind as well as the Greek cultural heritage. The thesis was conducted during one semester spent in the area and based upon qualitative research in form of observations of the towns, mapping, textual analysis and interviews. The results showed that the urban form of the two towns differ from each other because of their history and their localisation. Bova is an ancient town in the mountains that is separated through topography, and therefore conserved with many old structures but few inhabitants, suffering from out-migration. Bova Marina is placed on the coast of the Ionic Sea, south of Bova and connected to the region by train and roads, while Bova is mainly connected to Bova Marina. Bova Marina was founded as a town in late 19th century and expanded a lot because of the railroad. It is a town with inconsistent walking network, a lot of traffic and houses in bad condition. -

Grecanica-Calabria (Italy)
PROFECY – Processes, Features and Cycles of Inner Peripheries in Europe (Inner Peripheries: National territories facing challenges of access to basic services of general interest) Applied Research Final Report Annex 13 Case Study Report Area Grecanica-Calabria (Italy) Version 07/12/2017 This report is one of the deliverables of the PROFECY project. This Applied ResearchProject is conducted within the framework of the ESPON 2020 Cooperation Programme, partly financed by the European Regional Development Fund. The ESPON EGTC is the Single Beneficiary of the ESPON 2020 Cooperation Programme. The Single Operation within the programme is implemented by the ESPON EGTC and co-financed by the European Regional Development Fund, the EU Member States and the Partner States, Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland. This delivery does not necessarily reflect the opinion of the members of the ESPON 2020 Monitoring Committee. Authors Francesco Mantino and Barbara Forcina, Council for Agricultural Research and Economics (Italy) Advisory Group Project Support Team: Barbara Acreman and Zaira Piazza (Italy), Eedi Sepp (Estonia), Zsolt Szokolai, European Commission. ESPON EGTC: Marjan van Herwijnen (Project Expert), Laurent Frideres (HoU E&O), Ilona Raugze (Director), Piera Petruzzi (Outreach), Johannes Kiersch (Financial Expert). Information on ESPON and its projects can be found on www.espon.eu. The web site provides the possibility to download and examine the most recent documents produced by finalised and ongoing ESPON projects. This delivery exists only in an electronic version. © ESPON, 2017 Printing, reproduction or quotation is authorised provided the source is acknowledged and a copy is forwarded to the ESPON EGTC in Luxembourg. Contact: [email protected] a PROFECY – Processes, Features and Cycles of Inner Peripheries in Europe ESPON 2020 i Table of contents Executive Summary .................................................................................................................. -

Architecture, Archaeology and Contemporary City
FLORE Repository istituzionale dell'Università degli Studi di Firenze Architecture, Archaeology and Contemporary City Planning - Proceedings of the Workshop Questa è la Versione finale referata (Post print/Accepted manuscript) della seguente pubblicazione: Original Citation: Architecture, Archaeology and Contemporary City Planning - Proceedings of the Workshop / Verdiani, Giorgio; Cornell Per. - ELETTRONICO. - (2014), pp. 0-199. Availability: This version is available at: 2158/1002502 since: 2015-07-09T07:37:14Z Publisher: Lulu.com Terms of use: Open Access La pubblicazione è resa disponibile sotto le norme e i termini della licenza di deposito, secondo quanto stabilito dalla Policy per l'accesso aperto dell'Università degli Studi di Firenze (https://www.sba.unifi.it/upload/policy-oa-2016-1.pdf) Publisher copyright claim: (Article begins on next page) 05 October 2021 SCHOLARS WORKSHOP: ARCHITECTURE, ARCHAEOLOGY AND CONTEMPORARY CITY PLANNING Firenze 16-18th June 2014 Firenze 16-18th June 2014 Workshop: ARCHITECTURE, ARCHAEOLOGY AND CONTEMPORARY CITY PLANNING PROCEEDINGS OF THE WORKSHOP editors: Giorgio Verdiani & Per Cornell Firenze December 2014 Firenze 16-18th June 2014 Scholars workshop: ARCHITECTURE, ARCHAEOLOGY AND CONTEMPORARY CITY PLANNING The workshop took place in Firenze, via San Niccolò, 93 at the Dipartimento di Architettura in the Aula Magna placed at the first floor of the palace. Workshop organizing committee: Giorgio Verdiani, Per Cornell, Alessandro Merlo, Gianluca Belli. The workshop has been realized in collaboration between Architecture Department of the University of Florence, Italy, the Department of Historical Studies, University of Gothenburg, Sweden and MOLA (Museum of London Archaeology, UK) Proceedings Editors: Giorgio Verdiani and Per Cornell [email protected] / [email protected] Scholars participating at the workshop: R. -

Il Greco Di Calabria: Un Esempio Di Bilinguismo Nell'europa Antica
HUMANITIES – Anno II, Numero 1, Gennaio 2013 DOI: 10.6092/2240-7715/2013.1.140-151 Anna Maria Orlando* Il greco di Calabria: un esempio di bilinguismo nell’Europa antica Il presente contributo intende fornire un esempio di come un concetto formulato in tempi relativamente recenti, nell’ambito degli studi linguistici, quale è quello del bilinguismo, possa individuare la soluzione migliore per un problema tanto antico, quanto dibattuto, quello relativo alle origini del greco di Calabria. La legge 482 del 1999 sulle minoranze linguistiche tutela la presenza, nell’estremità meridionale della Calabria, di un’isola linguistica ellenofona, conseguenza e retaggio dei continui contatti e delle ininterrotte frequentazioni tra Italia e Grecia. Attualmente, l’area nella quale si parla una forma di lingua greca, chiamata grecanico, o greco aspromontano, o bovese, è costituita da pochi comuni situati ai piedi dell’Aspromonte, lungo il versante jonico della provincia di Reggio Calabria, nell’ampia vallata della fiumara Amendolea. L’Amendolea nasce presso Montalto, a 1.956 metri s.l.m., e scende attraversando un paesaggio impervio ed impraticabile che ha fortemente condizionato, nel tempo, l’uso antropico della zona. I paesi grecanici sono posti a circa 15 km dalla costa e coprono, approssimativamente, un territorio di 233 kmq. I maggiori tra questi centri sono: Bova, Bova Marina, Condofuri, Roccaforte del Greco e Roghudi. È, però, doveroso aggiungere che oggi, nonostante i numerosi tentativi di salvaguardia, il grecanico rappresenta un codice linguistico in declino; esso, probabilmente, sarà sostituito del tutto dall’italiano nel giro di alcuni decenni. Senza soffermarci sull’atteggiamento, comprensibile ma in alcuni casi discutibile, dei fautori di una rinascita del grecanico, possiamo * Dottoranda di ricerca dell’Università degli Studi di Messina. -

3. L'isola Grecanica.Pdf (264.72
SLI SOCIETÀ DI LINGUISTICA ITALIANA I DIALETTI E LE LINGUE DELLE MINORANZE DI FRONTE ALL'ITALIANO ATTI DELL'XI CONGRESSO INTERNAZIONALE DI STUDI Cagliari, 27-30 maggio 1977 a cura di FEDERICO ALBANO LEONI BULZONI ROMA 1980 PAOLO MARTINO (Roma) L'isola grecanica dell'Aspromonte. Aspetti sociolinguistici pp. 305-341 Emì ìmmasto to Misimèri tu Misimrìu tis Italìas (Noi siamo il Mezzogiorno del Mezzogiorno d'Italia) 0. Questa comunicazione intende innanzitutto tracciare un profilo sommario della situazione sociolinguistica attuale della minoranza greca dell'Aspromonte tramite una ricognizione dei dati, assai frammentari, a disposizione e presentare quindi, ad integrazione di questi, i primi risultati di un'inchiesta condotta sul terreno tra il novembre 1976 e l'aprile 1977. Scopo precipuo dell'inchiesta è stato l'accertamento della reale consistenza della grecofonìa, della sua distribuzione geografica e sociale e dell' a t t e g g i a m e n t o dei parlanti di fronte ai tre codici in contatto effettivamente adoperati. Particolare attenzione si è rivolta ai ragazzi della fascia dell'obbligo scolastico frequentanti le tre classi della scuola media inferiore. Infatti, a causa di due fenomeni strettamente interrelati (recente incremento della scolarizzazione e regressione del greco)1, si può dire che questi ragazzi rappresentino la prima generazione effettivamente e globalmente diglotta (italiano e dialetto romanzo). L'inchiesta si è articolata nella somministrazione di un questionario nelle scuole medie inferiori di Roccaforte (alunni di Chorio di Roghudi, Chorio di Roccaforte e Roccaforte), Condofuri Superiore (alunni di Gallicianò e Condofuri), Condofuri Marina (alunni di Amendolea, Lugarà, S. Carlo), Mèlito Porto Salvo (alunni di Roghudi) e Bova Superiore. -

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE Art
STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE Art. 20 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Ripristino della sezione idraulica della Fiumara di Condofuri da ottenersi mediante asportazione del materiale inerte accumulatosi all’interno dell’alveo ordinario nel tratto che si colloca da 500 m a monte a 500 m a valle del Ponte Lapsè. Condofuri (RC) ELABORATO PER: Ditta Modaffari Giovanni, via Peripoli, 89030 Condofuri Marina (RC) PREPARATO DA: PiCal srl - Pianificazione Integrata in Calabria Sede legale: Via Salita Melissari, c/o Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria Sede operativa: Loc. Feo di Vito, c/o Dipartimento di Agraria, 89122 Reggio Calabria – Italia PEC: [email protected] email: picalspinoff @gmail.com PREPARATO DA: PiCal srl - Pianificazione Integrata in Calabria Sede legale: Via Salita Melissari, c/o Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria Sede operativa: Loc. Feo di Vito, c/o Dipartimento di Agraria, 89122 Reggio Calabria – Italia PEC: [email protected] email: picalspinoff @gmail.com Prof. Claudio Marcianò - Responsabile del progetto Gruppo di lavoro: Dott.ssa Carmen Gangale – Flora, Vegetazione e habitat Dott.ssa Geol. Federica Mancuso – Cartografia e geologia Dott. Dimitar Ouzounov – Flora e Fauna Dott. Geol. Giovanni Salerno – Inquadramento territoriale, geologia, analisi urbanistica 2 INDICE Premessa 1. DESCRIZIONE DEL PROGETTO 1.1. Quadro di riferimento normativo 1.1.1 Inquadramento normativo di riferimento 1.1.1.1 Direttive europee 1.1.1.2 Normativa nazionale 1.1.1.3 Normativa regionale 1.2. Quadro di riferimento territoriale 1.2.1 Inquadramento territoriale 1.3 Quadro di riferimento programmatico 1.3.1. Piani urbanistici 1.3.1.1. Il Quadro Territoriale Regionale/Paesaggistico della Regione Calabria 1.3.1.2. -

7Th INTREPID Report Gagliato: a Framework for Future Growth
7th INTREPID Report Gagliato: A framework for future growth By James Anderson, Emma Kingman Rob Wills With contributions from: Prue Chiles January 2018 2 Gagliato A framework for future growth James Anderson, Emma Kingman & Rob Wills January 2018 Gagliato, Calabria Giovanni Sinopoli NanoGagliato Paola Ferrari Professor Mauro Ferrari Creative Small Settlements Professor Paolo Ceccarelli Dr. Giulio Verdini University of Westminster Dr. Giulio Verdini Newcastle University Professor Prue Chiles MArch ‘Linked Research’ Students 2017 - 2018 Emma Kingman James Anderson Robert Wills With funding from Cost_Intrepid Dr. Olivia Bina Sustainable Regeneration “..development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.” 1 1- Brundtland, G. H. (1987). Brundtland Report. Our Common Future. Comissão Mundial. CONTENTS Introduction p1 1 p6 2 p36 3 p56 4 p74 5 p114 6 p118 Understanding the Gagliato: The Town NUATI1 Creative The Way Forward Reflective Bibliography context of Gagliato Towns Workshop Recommendations p7 Introducing Calabria p37 Gagliato in Context p57 Introducing the Workshop p75 Gagliato’s future focus p115 Recommendations for Gagliato p119 Bibliography p9 Mediterranean History of Calabria p39 Beauty & Opportunities at a glance p59 Activities During the Week p77 Proposals for Gagliato p123 Image References p11 A Timeline of Calabrian History p41 Plan of Gagliato Today p61 Workshop Groups p79 Topography Section through Gagliato p21 The History of the Urban Form of p43 Property -

L'unità Superiore Dell'aspromonte. Studio Geologico E Petrografico
RENDICONTI Socld4 llallana dI Mlneralagia e Petrologla, 38 (3): pp. 989-1014 Comunlea.z.lone presentata alla Riunione della SIMP ln Rende_Cetraro (Cosenza) Il 21-10-1982 L'UNITÀ SUPERIORE DELL'ASPROMONTE. STUDIO GEOLOGICO E PETROGRAFICO GINO MIROCLE CRISCI Dip. Scienze de:lla Te:rra, Uni .... della Calabria, 87030 Castiglione Cosenlino Stazione (Cosenza) GAETANA DoNATI, ANTONIA MESSINA, SELMA Russo Istituto di Mineralogia e Petrografia dell'Università di Messina, ... ia dei Verdi, 98100 MessinA VINCENZO PERRONE Istituto di Geologia e Geofisica dell'Università di Napoli, Largo San Marcdlino lO, 80138 Napoli RlAssuN'w. - L'unità superiore dell'Aspromonte, di età ercinica, la prifThj e la terza realiuatesi in definita da BoNARDI et al. (l979), affiora estesa· ambiente dinamico, la seconda e la quatta in am mente: sul versante: meridionAle e sud-<>rientale di biente statico; di queste fasi la prima ha dato alle tale massiccio. Essa si compone di un basamento melamornti i loro ca(atteri essenziali, mentre le di metamornti erciniche e: di una copertura di altre non sono state registrate o hanno avuto scarso calcari mesozoici, con alla base un paleosuolo, rap effetto in alcune aree e litotipi. presentata solo in pochi lembi nei pressi di Staiti, La successione premetalTWrnca era rappresenlata Palini e Bova Marina. da una sequenza arenaceo-pelitica, con frequenti L'unità poggia con un contatto chiaramente tet livelli ...ulcanici e ...uleanoclasdci acidi e rari li...elli tonico, la cui superncie, facilmente osservabile in di ...ulcaniti basiche, in cui sono sicuramente presenti numerose: località, ~ nettamente discordante con la livelli devonici e probabilmente silurici. scistosità di entrambe le: unilà, su gneiss di mcdio La earatteriuazione del basamento di tale: unità alto grado e graniti, riuniti dagli AA. -

Download Tour Dossier
Tour Notes Calabria Trek – From the Ionian to the Tyrrhenian Sea Tour Duration – 8 Days Tour Rating Fitness ●●●●○ | Adventure ●●●○○ | Culture ●●○○○ | History ●●●○○ | Wildlife ●●○○○ Tour Highlights Enjoy stunning scenery and wildlife amidst the isolation of Aspromonte National Park Tread the tiny cobbled streets of Calabria’s mediaeval towns, villages and borghi Trek through some of Italy’s finest mountain terrain, from the Ionian to the Tyrrhenian Sea Explore the noble ruins of Norman hill-top citadels Immerse yourself in a mix of authentic ethnic cultures in a region that time has left undisturbed Sample the delicious local gastronomy, from delicious meats and cheese to fine wines Marvel at the beautiful ecclesiastical architecture and artwork at the heart of village communities Stay in a fascinating variety of Ospitalità Diffusa’-styled locally run accommodation Tread “the most beautiful kilometre in Italy” in search of the incomparable Riace Bronzes Tour Map Calabria Trek– From the Ionian to the Tyrrhenian Sea Tour Essentials Accommodation: ‘Ospitalità Diffusa’ (‘Widespread Hotels’) and Farm-stay Included Meals: Daily breakfast (B), packed lunches (L) and dinners (D) from Day 1 dinner to Day 8 breakfast Group Size: Private Tour Start Point: Reggio Calabria End Point: Reggio Calabria Transport: Private vehicle & trekking on foot Country Visited: Italy Calabria Trek– From the Ionian to the Tyrrhenian Sea Italy is one of Europe’s most popular destinations and the jewels in its crown are traditionally the ancient and historic powerhouses of Rome, Venice, Pompeii and the stunning array of picturesque northern cities whose names trip off the tongue like an incantation of artistic and cultural devotion. -

Aspetti Naturalistici Dell'area Grecanica
Alfonso Picone Chiodo Aspetti naturalistici dell’area grecanica RIFERIMENTI FOTOGRAFICI Pag. 6: Melito di Porto Salvo, Rocca di Santa Lena. Pag. 11: Atractylis gummifera; Asfodelo montano (Asphodelus macro- carpus). Pag. 13: Viola aethnensis subsp. messanensis; Valeriana rossa (Centran- thus ruber). Pag. 14: Zafferanastro siciliano (Sternbergia sicula). Pag. 15: Cappero comune (Capparis spinosa); Narcissus tazetta. Pag. 16: Gladiolo dei campi (Gladiolus italicus); Orchis italica. Pag. 19: Scoiattolo. Pag. 20: Driomio (Dryomys nitedula), foto Andrea Ciulla. Pag. 21: Granchio di fiume. Pag. 22: Salamandra pezzata. Pag. 24: Roccaforte del Greco, u schicciu da Spana. Pag. 25: Roccaforte del Greco, cascata Puzzaràtti o Calònero; Roghudi Vecchio. Pag. 29: Condofuri, resti del castello di Amendolea Vecchia. Pag. 30: Biscia che preda una trota, foto Filippo Corrado; Montalto. Pag. 33: Roghudi, Caldaie del latte (ta vrastarucia); Rocca del Drago. Pag. 35: Tagghia, antico strumento di computo dei pastori. Copyright © 2010 Giuseppe Pontari editore by Giuseppe Pontari s.r.l. Unipersonale 51012 Pescia PT Via degli Alberghi 61 Tel./fax: 0572444987 www.pontari.it e-mail: [email protected] Tu tti i diritti di riproduzione anche parziale del testo e delle immagini sono riservati per tutti i Paesi. È vietata ogni forma di utilizzo del contenuto del volume senza l’autorizzazione dell’editore ISBN 978-88-86046-48-0 Finito di stampare nel mese di settembre Stampa: Rubbettino Industrie Grafiche ed Editoriali Indice 7 I Greci di Calabria 9 La natura 23 La vallata della fiumara Amendolea 31 Notizie utili I Greci di Calabria Nella zona più meridionale della penisola italiana vivono ancora comunità di tradizione culturale e linguistica gre- ca, conosciute oggi come Greci di Calabria o grecanici.