01 Programma-Di-Sala.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Verdi Week on Operavore Program Details
Verdi Week on Operavore Program Details Listen at WQXR.ORG/OPERAVORE Monday, October, 7, 2013 Rigoletto Duke - Luciano Pavarotti, tenor Rigoletto - Leo Nucci, baritone Gilda - June Anderson, soprano Sparafucile - Nicolai Ghiaurov, bass Maddalena – Shirley Verrett, mezzo Giovanna – Vitalba Mosca, mezzo Count of Ceprano – Natale de Carolis, baritone Count of Ceprano – Carlo de Bortoli, bass The Contessa – Anna Caterina Antonacci, mezzo Marullo – Roberto Scaltriti, baritone Borsa – Piero de Palma, tenor Usher - Orazio Mori, bass Page of the duchess – Marilena Laurenza, mezzo Bologna Community Theater Orchestra Bologna Community Theater Chorus Riccardo Chailly, conductor London 425846 Nabucco Nabucco – Tito Gobbi, baritone Ismaele – Bruno Prevedi, tenor Zaccaria – Carlo Cava, bass Abigaille – Elena Souliotis, soprano Fenena – Dora Carral, mezzo Gran Sacerdote – Giovanni Foiani, baritone Abdallo – Walter Krautler, tenor Anna – Anna d’Auria, soprano Vienna Philharmonic Orchestra Vienna State Opera Chorus Lamberto Gardelli, conductor London 001615302 Aida Aida – Leontyne Price, soprano Amneris – Grace Bumbry, mezzo Radames – Placido Domingo, tenor Amonasro – Sherrill Milnes, baritone Ramfis – Ruggero Raimondi, bass-baritone The King of Egypt – Hans Sotin, bass Messenger – Bruce Brewer, tenor High Priestess – Joyce Mathis, soprano London Symphony Orchestra The John Alldis Choir Erich Leinsdorf, conductor RCA Victor Red Seal 39498 Simon Boccanegra Simon Boccanegra – Piero Cappuccilli, baritone Jacopo Fiesco - Paul Plishka, bass Paolo Albiani – Carlos Chausson, bass-baritone Pietro – Alfonso Echevarria, bass Amelia – Anna Tomowa-Sintow, soprano Gabriele Adorno – Jaume Aragall, tenor The Maid – Maria Angels Sarroca, soprano Captain of the Crossbowmen – Antonio Comas Symphony Orchestra of the Gran Teatre del Liceu, Barcelona Chorus of the Gran Teatre del Liceu, Barcelona Uwe Mund, conductor Recorded live on May 31, 1990 Falstaff Sir John Falstaff – Bryn Terfel, baritone Pistola – Anatoli Kotscherga, bass Bardolfo – Anthony Mee, tenor Dr. -

Libretto Stagione 2008/2009 (Pdf)
Pisa Teatro Verdi Cattedrale Chiesa dei Cavalieri Aula Bianchi della Scuola Normale Anche la quarantaduesima Stagione de I Concerti della Normale, il cui pro - Venerdì sera 17 ottobre, vigilia del 198esimo anniversario di fondazione della gramma qui si presenta, ribadisce il senso e la matrice di questa iniziativa: Scuola Normale, nella cornice superba dell’adiacente chiesa dei Cavalieri, si annodare la conoscenza e la fruizione della musica, del passato e del presen - apre il programma musicale 2008-2009 con una solennità senza precedenti te, al processo di alta formazione che la Scuola procura per sua propria voca - nelle pur ricche stagioni dei Concerti della Normale. I complessi corali e stru - zione. Essendo indubitabile quanto la conoscenza musicale sia influente nella mentali barocchi di Amsterdam, sotto la direzione di Ton Koopman, con la costituzione di una cultura e di un gusto. partecipazione di quattro celebri voci soliste, interpreteranno la Messa in si Anno dopo anno i concerti della Normale hanno svolto perciò la funzione pri - minore di Bach, quella hohe Messe , definita da Carl Friedrich Zelter “il più gran - maria di avvicinare alla musica chi di questa esperienza era privo e di propor - de capolavoro musicale che il mondo abbia visto”. re, nel contempo, scelte di qualificatissimo livello – per brani e interpretazio - Anche il secondo appuntamento, il 27 ottobre al Teatro Verdi, vanta un titolo ni – a chi di musica aveva, invece, vissuta esperienza. fra i più vistosi della Storia della Musica occidentale, la Nona Sinfonia di Questa è la traccia che ispira la vitale composizione antologica dei nostri pro - Beethoven, nella trascrizione per solo pianoforte di Franz Liszt. -

TEATRO SOLVAY SPETTACOLI LIRICI Direzione Artistica Dino Lessi
TEATRO SOLVAY SPETTACOLI LIRICI Direzione Artistica Dino Lessi 1940 Rigoletto baritono Mario Basiola, soprano Lina Aimaro, tenore Carlo Merino, direttore Arturo Lucon 1941 La Traviata soprano Magda Olivero, tenore Mario Filippeschi, baritono Gino Vanelli, direttore Arturo Lucon Andrea Chenier tenore Galliano Masini, soprano Fernanda Ciani, baritono Luigi Borgonovo, direttore Arturo Lucon 1942 Il Barbiere di Siviglia baritono Carlo Galeffi, soprano Emilia Carlino, tenore Vladimiro Badiali, basso Andrea Mongelli, direttore Arturo Lucon Madama Butterfly soprano Iris Adami Corradetti, tenore Mario Del Monaco, baritono Afro Poli, direttore Antonino Votto 1943 La Sonnambula soprano Emilia Carlino, tenore Francesco Albanese, basso Italo Taio, direttore Federico Del Cupolo 1947 Tosca soprano Carla Castellani, tenore Gianni Poggi, baritono Raimondo Torres, direttore Umberto Berrettoni 1948 Un Ballo in Maschera soprano Franca Sacchi, tenore Antonio Latino, mezzo soprano Miriam Pirazzini, baritono Raimundo Torres 1949 Rigoletto baritono Aldo Protti, soprano Hilde Reggiani, tenore Giuseppe Savio, direttore Federico Del Cupolo L’Amico Fritz tenore Bruno Landi, soprano Rosetta Noli, baritono Gino Vanelli, direttore Federico del Cupolo Mefistofele basso Cesare Siepi, soprano Rosetta Noli, tenore Glauco Scarlin, direttore Umberto Berrettoni 1950 La Traviata soprano Rosetta Noli, tenore Giuseppe Campora, baritono Carlo Tagliabue, direttore Umberto Berrettoni Manon soprano Mafalda Favero, tenore Agostino Lazzari, baritono Leo Piccioli, direttore Umberto -

Comunicato Stampa
COMUNICATO STAMPA Il nuovo, visionario, monumentale allestimento di Pinuccio Sciola di Turandot, estremo capolavoro di Giacomo Puccini, impreziosisce la Stagione lirica e di balletto 2014 Venerdì 27 giugno alle 21 (turno A), per la Stagione lirica e di balletto 2014 del Teatro Lirico di Cagliari, va in scena il terzo appuntamento con l’opera: Turandot, dramma lirico in tre atti e cinque quadri su libretto di Giuseppe Adami e Renato Simoni, dalla fiaba teatrale omonima di Carlo Gozzi e musica di Giacomo Puccini (Lucca, 1858 - Bruxelles, 1924). Il nuovo allestimento del Teatro Lirico di Cagliari dell’opera è firmato, per la regia, dal fiorentino Pier Francesco Maestrini che si avvale, per l’impianto scenico, di un autorevole artista e celebre scultore sardo al suo debutto nell’opera lirica Pinuccio Sciola, mentre per i costumi di Marco Nateri e per le luci di Simon Corder. Al giovane maestro milanese Giampaolo Bisanti, tra i migliori interpreti del grande repertorio musicale che ritorna a Cagliari dopo il verdiano Otello dello scorso anno, spetta il compito di dirigere l’Orchestra, il Coro del Teatro Lirico di Cagliari e il Coro di voci bianche del Conservatorio Statale di Musica “Giovanni Pierluigi da Palestrina” di Cagliari nell’estremo capolavoro del geniale compositore toscano. Il maestro del coro è Marco Faelli, mentre il maestro del coro di voci bianche è Enrico Di Maira. Protagonisti dell’opera sono giovani ed affermati cantanti che si alternano nelle recite quali: Maria Billeri (27 giugno, 5-9-12-16-19-23 luglio, 2-13 agosto)/Annalena -
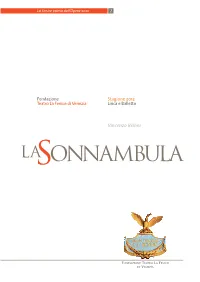
SONNAMBULA-LA-2.Pdf
2 La Fenice prima dell’Opera 2012 2 2012 Fondazione Stagione 2012 Teatro La Fenice di Venezia Lirica e Balletto Vincenzo Bellini laSonnambula a sonnambula L ellini b incenzo incenzo v FONDAZIONE TEATRO LA FENICE DI VENEZIA TEATRO LA FENICE - pagina ufficiale seguici su facebook e twitter follow us on facebook and twitter FONDAZIONE TEATRO LA FENICE DI VENEZIA Destinare il cinque per mille alla cultura è facile e non costa nulla. Quando compili la tua dichiarazione dei redditi, indica il codice fiscale della Fondazione Teatro La Fenice di Venezia: 00187480272 Aiuti la cultura, aiuti la musica. Incontro con l’opera FONDAZIONE lunedì 16 gennaio 2012 ore 18.00 AMICI DELLA FENICE SANDRO CAPPELLETTO, MARIO MESSINIS, DINO VILLATICO STAGIONE 2012 Lou Salomé sabato 4 febbraio 2012 ore 18.00 MICHELE DALL’ONGARO L’inganno felice mercoledì 8 febbraio 2012 ore 18.00 LUCA MOSCA Così fan tutte martedì 6 marzo 2012 ore 18.00 LUCA DE FUSCO, GIANNI GARRERA L’opera da tre soldi martedì 17 aprile 2012 ore 18.00 LORENZO ARRUGA La sonnambula lunedì 23 aprile 2012 ore 18.00 PIER LUIGI PIZZI, PHILIP WALSH Powder Her Face giovedì 10 maggio 2012 ore 18.00 RICCARDO RISALITI La bohème lunedì 18 giugno 2012 ore 18.00 GUIDO ZACCAGNINI Carmen giovedì 5 luglio 2012 ore 18.00 MICHELE SUOZZO L’elisir d’amore giovedì 13 settembre 2012 ore 18.00 MASSIMO CONTIERO Clavicembalo francese a due manuali copia dello Rigoletto strumento di Goermans-Taskin, costruito attorno sabato 6 ottobre 2012 ore 18.00 alla metà del XVIII secolo (originale presso la Russell PHILIP GOSSETT Collection di Edimburgo). -

Marina Serpagli - Biography
Mezzo-Soprano Jack Price Founding Partner / Managing Director Marc Parella Partner / Director of Operations Mailing Address: 520 Geary Street Suite 605 San Francisco CA 94102 Telephone: Toll-Free 1-866-PRI-RUBI (774-7824) 310-254-7149 / Los Angeles 415-504-3654 / San Francisco Email: [email protected] [email protected] Website: Contents: http://www.pricerubin.com Biography Yahoo!Messenger Resume pricerubin Reviews Repertoire Complete artist information including video, audio and interviews are available at www.pricerubin.com Marina Serpagli - Biography Marina Serpagli was born in Pavia (Italy), in a family dealing with business and trade, totally outside of the Art World. Nevertheless, when she was offered the opportunity to get a musical education, she accepted with enthusiasm and dedication. As a child she studied piano and choir singing. Some years later her music teachers encouraged her to approach Lyrical Singing. Since then she’s been constantly improving and taking care of her vocal talent, that was also incentive for her personal growth. She deeply believes in the uniqueness and fulfillment of every artistic journey, beyond common sense and standard rules. She obtained her Lyrical Singing Diploma - mezzosoprano - at the Conservatory of Music “G.Nicolini” in Piacenza. She graduated in foreign languages from the University of Pavia and obtained one Deutsch Institute Diploma and two Cambridge Certificates (PET, FCE). She speaks English, French and German, in addition to her native Italian. At the beginning of her career she sang in important philharmonic choirs: Verdi Choir in Milan, Maghini Choir and RAI National Orchestra in Turin, having the opportunity to work with R. -

Rassegna Del 06/11/2018
Rassegna del 06/11/2018 EVIDENZA 06/11/18 Corriere della Sera 11 Marc Ribot, un trio inedito per Mister Chitarra L.Ma. 2 Roma 06/11/18 Corriere della Sera 13 Roma in scena ... 3 Roma 06/11/18 Repubblica Roma 11 Ribot-Emmanuel la chitarra solista politica e virtuosa Liperi Felice 5 06/11/18 Repubblica Roma 16 Musica ... 6 06/11/18 Messaggero Cronaca di 45 Parco dell'Appia Antica la vita comincia a 30 anni Larcan Laura 7 Roma 06/11/18 Messaggero Cronaca di 46 Serata charity e viaggio gourmet tra fotografia, arte e cultura - Il Arnaldi Valeria 9 Roma viaggio gourmet tra fotografia, arte e cultura 06/11/18 Messaggero Cronaca di 49 Il concerto. Tommy Emmanuel. Sbarca all'Auditorium il genio delle Molendini Marco 11 Roma sei corde 06/11/18 Messaggero Cronaca di 49 Lirica e concerti ... 12 Roma 06/11/18 Messaggero Cronaca di 49 Intervista a Marc Ribot - 10 domande a Marc Ribot Orlando Simona 13 Roma 06/11/18 Giornale di Vicenza 54 Intervista a Patrizia Laquidara - Un cd stratificato per essere Rossi Stefano 14 creativa e vera fino in fondo 06/11/18 Il Fatto Quotidiano 6 Intervista a Philippe Van Parijs - "Il reddito è giusto, l'esempio Feltri Stefano 16 egiziano vi eviterà gli errori" - "Reddito minimo, guardate l'Egitto per evitare errori" 06/11/18 Leggo Roma 26 Manutenzione del manto stradale lavori in via Lorenzo il Magnifico ... 18 06/11/18 Metro 15 Nuova data per Elisa in tour coi Diari Aperti ... 19 06/11/18 Metro 15 Emmanuel e Douglas, sfida a suon di chitarre .. -

Ambassador Auditorium Collection ARS.0043
http://oac.cdlib.org/findaid/ark:/13030/kt3q2nf194 No online items Guide to the Ambassador Auditorium Collection ARS.0043 Finding aid prepared by Frank Ferko and Anna Hunt Graves This collection has been processed under the auspices of the Council on Library and Information Resources with generous financial support from the Andrew W. Mellon Foundation. Archive of Recorded Sound Braun Music Center 541 Lasuen Mall Stanford University Stanford, California, 94305-3076 650-723-9312 [email protected] 2011 Guide to the Ambassador Auditorium ARS.0043 1 Collection ARS.0043 Title: Ambassador Auditorium Collection Identifier/Call Number: ARS.0043 Repository: Archive of Recorded Sound, Stanford University Libraries Stanford, California 94305-3076 Physical Description: 636containers of various sizes with multiple types of print materials, photographic materials, audio and video materials, realia, posters and original art work (682.05 linear feet). Date (inclusive): 1974-1995 Abstract: The Ambassador Auditorium Collection contains the files of the various organizational departments of the Ambassador Auditorium as well as audio and video recordings. The materials cover the entire time period of April 1974 through May 1995 when the Ambassador Auditorium was fully operational as an internationally recognized concert venue. The materials in this collection cover all aspects of concert production and presentation, including documentation of the concert artists and repertoire as well as many business documents, advertising, promotion and marketing files, correspondence, inter-office memos and negotiations with booking agents. The materials are widely varied and include concert program booklets, audio and video recordings, concert season planning materials, artist publicity materials, individual event files, posters, photographs, scrapbooks and original artwork used for publicity. -

Staged Treasures
Italian opera. Staged treasures. Gaetano Donizetti, Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini and Gioacchino Rossini © HNH International Ltd CATALOGUE # COMPOSER TITLE FEATURED ARTISTS FORMAT UPC Naxos Itxaro Mentxaka, Sondra Radvanovsky, Silvia Vázquez, Soprano / 2.110270 Arturo Chacon-Cruz, Plácido Domingo, Tenor / Roberto Accurso, DVD ALFANO, Franco Carmelo Corrado Caruso, Rodney Gilfry, Baritone / Juan Jose 7 47313 52705 2 Cyrano de Bergerac (1875–1954) Navarro Bass-baritone / Javier Franco, Nahuel di Pierro, Miguel Sola, Bass / Valencia Regional Government Choir / NBD0005 Valencian Community Orchestra / Patrick Fournillier Blu-ray 7 30099 00056 7 Silvia Dalla Benetta, Soprano / Maxim Mironov, Gheorghe Vlad, Tenor / Luca Dall’Amico, Zong Shi, Bass / Vittorio Prato, Baritone / 8.660417-18 Bianca e Gernando 2 Discs Marina Viotti, Mar Campo, Mezzo-soprano / Poznan Camerata Bach 7 30099 04177 5 Choir / Virtuosi Brunensis / Antonino Fogliani 8.550605 Favourite Soprano Arias Luba Orgonášová, Soprano / Slovak RSO / Will Humburg Disc 0 730099 560528 Maria Callas, Rina Cavallari, Gina Cigna, Rosa Ponselle, Soprano / Irene Minghini-Cattaneo, Ebe Stignani, Mezzo-soprano / Marion Telva, Contralto / Giovanni Breviario, Paolo Caroli, Mario Filippeschi, Francesco Merli, Tenor / Tancredi Pasero, 8.110325-27 Norma [3 Discs] 3 Discs Ezio Pinza, Nicola Rossi-Lemeni, Bass / Italian Broadcasting Authority Chorus and Orchestra, Turin / Milan La Scala Chorus and 0 636943 132524 Orchestra / New York Metropolitan Opera Chorus and Orchestra / BELLINI, Vincenzo Vittorio -

CONCERTO VERDIANO 25 Aprile 2013 Teatro Bonci
Faenza Lirica Via Laderchi 3 - FAENZA http://faenzalirica.racine.ra.it/ CONCERTO VERDIANO 18 Luglio 2013 Faenza Soprano: Raffaella Battistini Tenore: Mauro Pagano Baritono: Marzio Giossi Mezzosoprano: Christine Knorren Basso: F. Ellero D’Artegna Pianista: Angiolina Sensale RAFFAELLA BATTISTINI soprano Nata a Cesena (FC), dopo il conseguimento della Laurea in Economia e Commercio presso l’Università di Bologna ha iniziato lo studio di canto sotto la guida del Soprano Maria Parazzini, rilevando da subito grandi potenzialità ed un vocalità dalle caratteristiche assai interessanti che gli permette di spaziare da Verdi, Puccini, Leoncavallo, Boito e Cilea con grande facilità. Si è perfezionata con il M° Luciano Pavarotti e M° Leone Magiera, attualmente con il M° Angelo Bertacchi, approfondendo principalmente lo studio di Opere di Verdi e Puccini. Il suo primo debutto avviene il 15 Giugno del 2004 a Modena al "Music Village" nella Boheme di Giacomo Puccini nel ruolo di Mimì sotto la direzione del M° Magiera e la Regia di Luciano Pavarotti. La sua carriera si amplifica dando voce a Liù, Nedda, Tosca, Leonora, Aida, Traviata, Maria di Rohan, Butterfly, Manon, Amelia, Maddalena, Margherita, Abigaille e Santuzza, nei Teatri: Bellini di Catania, Rossini di Pesaro, Comunale di Bologna, Abbazia Calamari (Frosinone), Pala Fiera di Forlì, Carisport di Cesena, Regio di Torino, Ivrea, Verdi di Pisa, Verdi di Busseto, Opera House del Cairo, Teatro Manoel Malta, Teatro di Oradea, Teatro Modena di Genova, Teatro Municipal di Bucarest, Teatro Municipale di Constanza, Salisburgo Festival, Stoccolma Festival, Carnegie Hall New York. Sotto la direzione dei Maestri: Alberto Veronesi, Damiano Binetti, Leone Magiera, Claudio Micheli, Ivan Filev, Paolo Olmi, Cristian Sandu, Hirofumi Yoshida, Massimo De Bernard, Roberto Polastri, Giampaolo Mazzoli, Maurizio Arena, Bruno Bartoletti, Laurence Gilgore e registi quali: Massimo Pezzuti, Horacio Ballinth, Paolo Bosisio, Maurizio di Mattia, Habdalla Saad, Massimiliano Scaglione, Maestrini, Beppe de Tommasi. -

CARTELLONE Mario Caroli, Daniela Bruera E Markus Werba
venerdì 16 novembre 2007 CARTELLONE Mario Caroli, Daniela Bruera e Markus Werba La Stagione concertistica 2007-2008 del Teatro Lirico di Cagliari prosegue con il terzo appuntamento, venerdì 16 alle 20.30 (turno A) e sabato 17 novembre alle 19 (turno B), con l’ Orchestra ed il Coro del Teatro Lirico , guidati dal direttore tedesco Lothar Koenigs . I ruoli solistici sono affidati al flautista Mario Caroli , al soprano Daniela Bruera e al baritono Markus Werba . Il maestro del coro è Andrea Faidutti . Il programma delle serate prevede: Fuga (Ricercata) a 6 voci dall’Offerta musicale (BWV 1079) di Johann Sebastian Bach di Anton Webern; Concerto per flauto e orchestra di Jacques Ibert; Requiem op. 48 per soprano, baritono, coro, orchestra e organo di Gabriel Fauré. Allievo di Arnold Schoenberg e raffinato esponente della dodecafonia, Anton Webern (Vienna, 1883 – Mittersill, Salisburgo, 1945) segna indelebilmente le sue creazioni musicali, attraverso un’asciuttezza compositiva ed una brevità espressiva che si possono apprezzare anche nelle elaborazioni da altri autori, come in questa Fuga a 6 voci da Bach composta nel 1934-1935. Nello stesso 1934 Jacques Ibert (Parigi, 1890 - 1962) compone il Concerto per flauto , opera di riferimento del suo percorso artistico, nel quale, diversamente da Webern, interpreta le caratteristiche della tradizione musicale francese, con un’eleganza stilistica senza pari. «Ho scritto il mio Requiem senza motivo… per il piacere di farlo, se così posso dire. […] è così che io sento la morte: come una lieta liberazione, un’aspirazione alla felicità dell’aldilà e non un doloroso trapasso». Gabriel Fauré (Pamiers, Ariège, 1845 – Parigi, 1924) non può riassumere meglio le intenzioni compositive del suo Requiem , la cui prima esecuzione lui stesso diresse nel 1893 alla Madeleine di Parigi. -

Fabio Biondi
TORINO | AUDITORIUM RAI | CONCERTI 21° MERCOLEDÌ 29 APRILE 2015 ore 20.30 GIOVEDÌ 30 APRILE 2015 ore 21.00 FABIO BIONDI | Direttore JENNIFER O’LOUGHLIN | Soprano SARA MINGARDO | Contralto GIAMPAOLO PRETTO | Flauto Pergolesi Bach MERCOLEDÌ 29 APRILE 2015 ore 20.30 GIOVEDÌ 30 APRILE 2015 21° ore 21.00 FABIO BIONDI | Direttore Giovanni Battista Pergolesi JENNIFER O’LOUGHLIN | Soprano Stabat Mater, per soprano, contralto, archi e organo (1735/36) SARA MINGARDO | Contralto 1. Duetto “Stabat Mater dolorosa” GIAMPAOLO PRETTO | Flauto 2. Aria “Cujus animam gementem” 3. Duetto “O quam tristis et afflicta” 4. Aria “Quae moerebat et dolebat” Giovanni Battista Pergolesi (1710 - 1736) (attrib.) 5. Duetto “Quis est homo” Concerto in sol maggiore per flauto, archi 6. Aria “Vidit suum dulcem natum” e basso continuo 7. Aria “Eja Mater fons amoris” Spiritoso 8. Duetto “Fac ut ardeat cor meum” Adagio 9. Duetto “Sancta Mater, istud agas” Allegro spiritoso 10. Aria “Fa cut portem Christi mortem” 11. Duetto “Inflammatus et accensus” Durata: 12’ ca. Prima esecuzione Rai a Torino. 12. Duetto “Quando corpus morietur” - “Amen” Durata: 46’ ca. Ultima esecuzione Rai a Torino: 3 aprile 1980, Michi Inoue, Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) Cecilia Fusco, Nucci Condò. Suite-Ouverture n. 2 in si minore BWV 1067 per flauto, archi e basso continuo(1718/23 o 1735) Ouverture Rondeau Sarabande Bourrée I e II Polonaise – Double Menuet Badinerie Durata: 23’ ca. Ultima esecuzione Rai a Torino: 20 febbraio 2000, Dante Milozzi (Domenica Musica). Il concerto di mercoledì 29 aprile è trasmesso in collegamento diretto su Radio3 per il programma “Radio3 Suite” e in streaming audio-video su www.osn.rai.it e su www.classica.rai.it.