Ascari. Un Mito Italiano
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Story of the Alfa Romeo Factory and Plants : Part 1 the Early Portello
Story of the Alfa Romeo factory and plants: Part 1 The early Portello Factory Patrick Italiano Special thanks go to Karl Schnelle, Indianapolis, USA, for his patient proofreading and editing of the English version of this text Over the last few years, we have had to deal with large changes in Alfa Romeo-related places and buildings, as we witnessed the destruction of the old Portello factory, step by step in the late 80s, and also the de-commissioning of the much more modern Arese plant. Sad tales and silly pictures of places and people once full of pride in manufacturing the most spirited cars in the world. As reported by historians, it has long been – and still is for few – a source of pride to belong to this “workers aristocracy” at A.L.F.A.. Places recently destroyed to make place for concrete buildings now containing commercial centres or anonymous offices, places where our beloved cars were once designed, developed and built. It’s often a mix of curiosity and thrill to have the chance to look behind the scenes and see into the sanctuary. Back in 1987, when the first part of Portello was being torn down, Ben Hendricks took us on a visit to the Portello plant in Het Klaverblaadje #40. That was, as Jos Hugense coined the title 15 years later, the “beginning of the end”. Today, one can see Alfas running on the Fiat assembly lines along with Fiat Stilos and at best Lancia Thesis. These Fiat plants are no longer the places where distinguished and passionate brains try to anticipate technical trends five years into the future, thus ensuring that the new generation of Alfas keep such high company standards, as Ing. -

The Last Road Race
The Last Road Race ‘A very human story - and a good yarn too - that comes to life with interviews with the surviving drivers’ Observer X RICHARD W ILLIAMS Richard Williams is the chief sports writer for the Guardian and the bestselling author of The Death o f Ayrton Senna and Enzo Ferrari: A Life. By Richard Williams The Last Road Race The Death of Ayrton Senna Racers Enzo Ferrari: A Life The View from the High Board THE LAST ROAD RACE THE 1957 PESCARA GRAND PRIX Richard Williams Photographs by Bernard Cahier A PHOENIX PAPERBACK First published in Great Britain in 2004 by Weidenfeld & Nicolson This paperback edition published in 2005 by Phoenix, an imprint of Orion Books Ltd, Orion House, 5 Upper St Martin's Lane, London WC2H 9EA 10 987654321 Copyright © 2004 Richard Williams The right of Richard Williams to be identified as the author of this work has been asserted by him in accordance with the Copyright, Designs and Patents Act 1988. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the copyright owner. A CIP catalogue record for this book is available from the British Library. ISBN 0 75381 851 5 Printed and bound in Great Britain by Clays Ltd, St Ives, pic www.orionbooks.co.uk Contents 1 Arriving 1 2 History 11 3 Moss 24 4 The Road 36 5 Brooks 44 6 Red 58 7 Green 75 8 Salvadori 88 9 Practice 100 10 The Race 107 11 Home 121 12 Then 131 The Entry 137 The Starting Grid 138 The Results 139 Published Sources 140 Acknowledgements 142 Index 143 'I thought it was fantastic. -

Episodio 1 AR
Contact: Miguel Ceballos FCA México: ‘Historias de Alfa Romeo’ Episodio Uno: conducción a bordo del 24 HP La historia comenzó el 24 de junio de 1910, con la fundación de la A.L.F.A. (Anonima Lombarda Fabbrica Automobili) Los 24 HP tenían un motor monobloque de 4 cilindros, 4 litros de desplazamiento y 42 caballos de fuerza El 40/60 HP nace en 1913 y fue capaz de alcanzar 139 km/h Enzo Ferrari tuvo una fuerte vinculación con Alfa Romeo en el deporte motor April 20, 2020, Ciudad de México - Historias y personajes de principios del siglo XX, centrados en el primer coche de la firma italiana: un elegante ‘cohete’ capaz de alcanzar 100 km/h. El francés de Nápoles Oficialmente nuestra historia comenzó el 24 de junio de 1910, con la fundación de la A.L.F.A. (Anonima Lombarda Fabbrica Automobili). Pero vamos a empezar unos años antes, con un personaje colorido: un francés con un bigote de manillar y un instinto sobresaliente para los negocios. Pierre Alexandre Darracq comenzó su carrera dirigiendo una fábrica de bicicletas en Burdeos, antes de enamorarse de los automóviles. Así, comenzó a producir automóviles en Francia y hacer un éxito de la misma. Luego decidió exportar la apertura de sucursales en Londres y luego Italia. En Italia comenzó sus operaciones, en abril de 1906. Pero Nápoles estaba muy lejos de Francia y el viaje era complejo y costoso. Así, en diciembre había transferido la producción a Milán, en el número 95 en el distrito de Portello. Pero junto con las dificultades logísticas se dio cuenta de que también había problemas de mercado. -

Alfa Occidentale #26 July 2019
ALFA OCCIDENTALE Issue 26, July - August 2019 Alfa Romeo Disco Volante Superleggera, by Touring On show at the Geneva Motor Show in 2013 This is the 26th edition of ALFA OCCIDENTALE – the electronic newsletter of the Alfa Romeo Owners Club of Australia (WA Division). WA Alfa Club members are invited to provide contributions to future magazine editions, C/-: [email protected] In this edition of Alfa Occidentale, you will find outlined the latest details concerning the club’s upcoming schedule for 2019, including information you need regarding its competition, social & driving events. The club is particularly grateful to Glen Phillips who has provided Alfa Occidentale with a scanned copy of an old article, from an issue of “Thoroughbred and Classsic Cars”, dated November 1982, on the Alfa team manager and racing driver Collaudatore Guidotti. This article is reproduced later in this edition of the magazine. Also in this issue, you will find a detailed photographic record of the WA Alfa club’s recent annual Alfa Romeo birthday dinner held at the Acqua Viva restaurant on the Swan River in Nedlands on Saturday 29th June. Alfa Occidentale is the electronic magazine of the 1 Alfa Romeo Owners CluB of Australia (Western Australian Division) ALFA OCCIDENTALE Issue 26, July - August 2019 2019 AROCA WA COMMITTEE Andrew Murray President [email protected] Rod Quinn Vice-President [email protected] Ivan Olsen Past President [email protected] Stuart Bunt Treasurer [email protected] Greg Smith Secretary [email protected] Ian Glover Membership Secretary [email protected] Ivan Olsen Comp. Secretary/CAMS [email protected] Vacant Club Shop [email protected] Sam Calabro Social Secretary [email protected] David Hamlyn Gen. -

ACES WILD ACES WILD the Story of the British Grand Prix the STORY of the Peter Miller
ACES WILD ACES WILD The Story of the British Grand Prix THE STORY OF THE Peter Miller Motor racing is one of the most 10. 3. BRITISH GRAND PRIX exacting and dangerous sports in the world today. And Grand Prix racing for Formula 1 single-seater cars is the RIX GREATS toughest of them all. The ultimate ambition of every racing driver since 1950, when the com petition was first introduced, has been to be crowned as 'World Cham pion'. In this, his fourth book, author Peter Miller looks into the back ground of just one of the annual qualifying rounds-the British Grand Prix-which go to make up the elusive title. Although by no means the oldest motor race on the English sporting calendar, the British Grand Prix has become recognised as an epic and invariably dramatic event, since its inception at Silverstone, Northants, on October 2nd, 1948. Since gaining World Championship status in May, 1950 — it was in fact the very first event in the Drivers' Championships of the W orld-this race has captured the interest not only of racing enthusiasts, LOONS but also of the man in the street. It has been said that the supreme test of the courage, skill and virtuosity of a Grand Prix driver is to w in the Monaco Grand Prix through the narrow streets of Monte Carlo and the German Grand Prix at the notorious Nürburgring. Both of these gruelling circuits cer tainly stretch a driver's reflexes to the limit and the winner of these classic events is assured of his rightful place in racing history. -

“Pionieri Dell'automobile LANCIA, BAZZI, FERRARI”
“Pionieri dell’automobile LANCIA, BAZZI, FERRARI”. Nunzia Manicardi tra auto e moto d’epoca. Le copertine del LIBRO Alcune straordinarie fotografie tratte dal libro. La squadra tecnica e sportiva dell’Alfa Romeo nel 1923. Da sin.: Giuseppe Campari, Luigi Bazzi, Enzo Ferrari, Antonio Ascari, Ugo Sivocci. Coppa Vanderbilt 1936. Sul Transatlantico Rex, con New York alle spalle. Da sin.: Brivio, Canestrini, Marabutto, Nuvolari e Bazzi. La squadra saluta la città americana dopo aver corso e guadagnato il successo con Tazio Nuvola Circuito di Modena. Chini sulla Ferrari i meccanici Marchetti, a sin., e Cappi. Dietro, da sin., Bazzi, Ferrari, l’ing. Carlo Chiti e Daini, direttore tecnico della Weber. Nunzia Manicardi tra auto e moto d’epoca. Omaristi d’epoca. Si diplomò perito meccanico nel 1908 Il cavalier Luigi Bazzi, che fu la fortuna di Enzo Ferrari La sua riscoperta nel libro di Nunzia Manicardi “Pionieri dell’automobile: Lancia, Bazzi, Ferrari” Tecnico‐progettista di altissimo valore, per il Drake fu il più valido dei collaboratori, poi consulente e anche amico… L’eccezionale ma quasi sconosciuta storia di un uomo di poche parole e molti fatti L’Autrice racconta gesta e storie inedite di un autentico talento dei motori È uscito nelle settimane scorse un libro in cui Nunzia Manicardi si occupa anche del novarese Luigi Bazzi, diplomatosi perito meccanico all’Istituto Omar nel lontano 1908 e già altre volte commemorato dall’Istituto stesso. Fin dal titolo del libro, “Pionieri dell’automobile: Lancia, Bazzi, Ferrari” (Edizioni Il Fiorino, Modena), si comprende come l’autrice modenese, molto nota e apprezzata nell’ambito del motorismo storico per i suoi tanti volumi, abbia voluto evidenziare l’importanza del Nostro. -
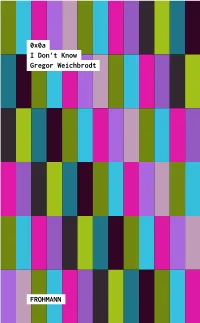
0X0a I Don't Know Gregor Weichbrodt FROHMANN
0x0a I Don’t Know Gregor Weichbrodt FROHMANN I Don’t Know Gregor Weichbrodt 0x0a Contents I Don’t Know .................................................................4 About This Book .......................................................353 Imprint ........................................................................354 I Don’t Know I’m not well-versed in Literature. Sensibility – what is that? What in God’s name is An Afterword? I haven’t the faintest idea. And concerning Book design, I am fully ignorant. What is ‘A Slipcase’ supposed to mean again, and what the heck is Boriswood? The Canons of page construction – I don’t know what that is. I haven’t got a clue. How am I supposed to make sense of Traditional Chinese bookbinding, and what the hell is an Initial? Containers are a mystery to me. And what about A Post box, and what on earth is The Hollow Nickel Case? An Ammunition box – dunno. Couldn’t tell you. I’m not well-versed in Postal systems. And I don’t know what Bulk mail is or what is supposed to be special about A Catcher pouch. I don’t know what people mean by ‘Bags’. What’s the deal with The Arhuaca mochila, and what is the mystery about A Bin bag? Am I supposed to be familiar with A Carpet bag? How should I know? Cradleboard? Come again? Never heard of it. I have no idea. A Changing bag – never heard of it. I’ve never heard of Carriages. A Dogcart – what does that mean? A Ralli car? Doesn’t ring a bell. I have absolutely no idea. And what the hell is Tandem, and what is the deal with the Mail coach? 4 I don’t know the first thing about Postal system of the United Kingdom. -

Correnti Della Storia
CORRENTI DELLA STORIA ALBERTO ASCARI (1918–1955) Last month’s essay (February, 2017), dealt with the life and work of Enzo Ferrari, who was both a race-car driver and owner/builder of high performance automobiles. He also founded and ran the racing team of Scude- ria Ferrari. This month’s essay is about one of that team’s most successful and famous drivers, Alberto Ascari. He became a very close friend of Ferrari, so much so that after his tragic death in a racing accident, Ferrari was terribly distraught and decided from then on to avoid making close personal friendships with his drivers. Alberto was the son of one of Italy’s great pre-war drivers, Antonio Ascari. He went on to become one of Formula One racing’s most dominant and best-loved champions. He was known for his careful precision and finely-judged accuracy that made him one of the safest drivers in a very dangerous era of auto racing. He was also notoriously superstitious and took great pains to avoid tempting fate. But his unexplained fatal accident—at exactly the same age as his father’s (36), on the same day of the month (the 26th) and in eerily similar circumstances—remains one of Formula One racing’s great unsolved mysteries (see below). During his short nine-year racing career, Alberto Ascari won 47 international races in 56 starts. His two Formula One World Championships attest to his ranking as one of the greatest drivers in European history. Alberto was born in Milan, Italy on July 13, 1918. -

Visit Us on the Web Site
EXE-RACINGcoverING 18•06•2008 9:27 Pagina 1 www.pirellityre.com Dealer Visit us on the web site www.pirellityre.com By clicking on Motorsports on the and racing drivers using Pirelli tyres web site www.pirellityre.com, you have taken part, it is also possible will be catapulted into the to read results and comments from exceptional world of racing where the FIA WRC World Rally Pirelli is a leading player. Each Championship, the Grand Am section of the web site offers Series (two championships for dynamic sports such as rallying, which the Milan company is the track racing and desert rally-raids. official tyre supplier) and the In addition to technical information, international FIAGT championship, press releases and photos of the all fields in which Pirelli plays a various races in which teams, cars leading role, in real time. www.pirellityre.com EXE-RACING-ING 18•06•2008 9:27 Pagina 1 1938 Rio de Janeiro Carlo Pintacuda Alfa Romeo 308 3000cc 1947 Switzerland Jean-Pierre Wimille Alfa Romeo 158 1500cc 1939 South Africa Luigi Villoresi Maserati 6CM 1500cc 1953 Argentina Alberto Ascari Ferrari 500 F2 2000cc 2005 BMS Scuderia Italia Pescatori – Cressoni Ferrari 550 Prodrive (GT1) 1940 Tripoli Giuseppe Farina Alfa Romeo 158 1500cc Holland Alberto Ascari Ferrari 500 F2 2000cc 2006 AutOrlando SPORT Lieb-Camathias Porsche 996 GT3 RSR (GT2) 1946 Nice Luigi Villoresi Maserati 4CL 1500cc Belgium Alberto Ascari Ferrari 500 F2 2000cc Nations Giuseppe Farina Alfa Romeo 158 1500cc France Mike Hawthorn Ferrari 500 F2 2000cc AMERICAN LE MANS SERIES (Geneve) -

Breve Storia Del Circuito Possiamo Facilmente
“CIRCUITO DI CREMONA” RALLY NAZIONALE – RALLY NAZ. AUTO STORICHE – REGOLARITA’ SPORT AUTO STORICHE 10-11 LUGLIO 2004 – CREMONA – COPPA ITALIA 2a ZONA Breve storia del Circuito Possiamo facilmente immaginare l'atmosfera carica d'euforia ed entusiasmo di quel 6 maggio 1923. L'evento, dopotutto, è di quelli memorabili; sta, infatti, per scattare il primo "Circuito Automobilistico di Cremona". Per l'esordio, gli organizzatori dell'Unione Sportiva Cremonese non hanno certo lesinato in quanto ad impegno. Così sono riusciti ad iscrivere alla loro gara i campioni più affermati a bordo delle auto delle squadre ufficiali. Tra le tante stelle al via la più fulgida è quella di Antonio Ascari, reduce da una prova esaltante nella Targa Florio. Inoltre le Ferrovie dello Stato hanno acconsentito a fermare i convogli nel week-end della corsa. Così il via può essere dato in Via Mantova, che appare profondamente trasformata per l’occasione: sull’area del foro boario ci sono i box per le vetture ed è stato costruito un grande tabellone per seguire le vicende della corsa, mentre all’angolo con via Ghisleri un sovrappasso in legno consente ai pedoni l’attraversamento stradale anche durante le manches. Una cronaca dell’epoca racconta dell’avvenimento e di auto che sfrecciano a forte velocità mentre lo stradale è ininterrottamente innaffiato schizzando i curiosi che impassibili tengono il loro posto mentre squadre di operai innalzano tribune che ornano di trofei e bandiere. Anche a Cremona Ascari scende in pista con l’affidabile Alfa Romeo RL, un bolide di quasi tre litri di cilindrata. Sul cofano della vettura appare, per la prima volta, il quadrifoglio verde in campo bianco che da allora accompagnerà tutti i successi sportivi delle auto milanesi. -

C70 Grand Prix Series OWNER’S HANDBOOK Time on Your Side
C70 Grand Prix Series OWNER’S HANDBOOK Time on your side... Your Christopher Ward watch has been designed and engineered by highly talented craftspeople to ensure not only accurate and precise timekeeping but also to bring a real pride of ownership that only luxury items of the highest quality can ever hope to deliver. You have made an investment, a good one, and the aim of this handbook is to help you make the most of that investment during what I hope will be a lifetime of ownership. Christopher Ward Caring for your Christopher Ward quartz watch Your C70 Grand Prix Chronograph is constructed from the finest components and materials available including one of Switzerland’s finest quartz movements. As with all watches of this quality, with just a little care, it has the potential to become an heirloom piece giving further joy to future generations. Here are a few hints to help keep your watch working perfectly over the years: • Although the battery in your watch may last longer, we recommend you have it changed every 2/3 years by a reputable watch repairer. • At the same time as having the battery changed it makes sense to have the watch repairer clean and lubricate your watch as necessary. • Make sure the crown is screwed down fully before putting the watch into water. Adhere to the water resistance ratings towards the end of the handbook to prevent water getting to the movement which could result in a very costly repair or the need for a replacement movement. • Your watch is shock resistant to minor impacts but dropping from height onto a hard surface may damage the movement. -

In the Shadow of the Big Boys De Vecchi and Other Pioneers of the Automobile in Milan
In the Shadow of the Big Boys De Vecchi and other pioneers of the automobile in Milan AISA Associazione Italiana per la Storia dell’Automobile MONOGRAFIA AISA 126 I In the Shadow of the Big Boys De Vecchi and other pioneers of the automobile in Milan AISA - Associazione Italiana per la Storia dell’Automobile 2 Foreword Lorenzo Boscarelli 3 The De Vecchi Foundation: creating a Company Archive Alberto De Vecchi 5 De Vecchi Automobili and the Milanese industry Donatella Biffignandi 15 Ecla, History of a Brand Donatella Biffignandi 16 Giuseppe Ricordi: he was the first Gianni Cancellieri 19 Register of the minor automotive manufacturers active in the Milan area from the origins to 1925 by Donatella Biffignandi and Lorenzo Boscarelli 27 The Milanese coachbuilders, from coaches to motor cars Alessandro Sannia MONOGRAFIA AISA 126 1 Foreword Lorenzo Boscarelli he final decades of the 19th century saw the comparison with any other Italian area, had a key Tdevelopment of new and very different tech- role in the process and gave life to innumerable nologies, such as electricity, the telephone and the small companies dedicated to the new product. internal combustion engine, as well as many other Milan was the starting point of the automobile’s which radically changed the quality of life for many growth in Italy, but in a few years’ time Turin took people in a very short time, particularly for the upper its place. This was mainly due to Fiat, which – led by classes. Moreover Europe, after the Franco-Prussian Giovanni Agnelli’s (and his management’s) industrial war of 1870, enjoyed a period of relative peace, so vision – put in place the technical, organisational and much so that the period came to be known as “la financial resources needed to develop rapid growth belle époque”.