Pro Patria Di Ascanio Celestini
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
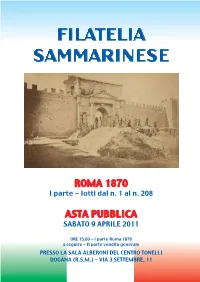
ROMA 1870 I Parte - Lotti Dal N
ROMA 1870 I parte - lotti dal n. 1 al n. 208 ASTA PUBBLICA SABATO 9 APRILE 2011 ORE 15,00 - I parte Roma 1870 a seguire - II parte vendita generale PRESSO LA SALA ALBERONI DEL CENTRO TONELLI DOGANA (R.S.M.) - VIA 3 SETTEMBRE, 11 FILATELIA SAMMARINESE ASTA PUBBLICA Roma 1870 I parte - lotti dal n. 1 al n. 208 SABATO 9 APRILE 2011 ore 15,00 - I parte Roma 1870 a seguire - II parte vendita generale presso la sala Alberoni del centro Tonelli DOGANA (R.S.M.) - Via 3 Settembre 11 FILATELIA SAMMARINESE srl Piazza Enriquez 22c - 47891 DOGANA (R.S.M.) tel. 0549.91.02.25 - internazionale 00378.91.02.25 tel/fax. 0549.90.97.42 - internazionale 00378.90.97.42 www.filsam.com - e-mail: [email protected] c/c postale n. 10247476 - Banca Agricola Comm. IBAN: SM29 S0303409800000020607306 Capitale Soc. 26,000 € - Ric. Giur. del 28.11.95 - Reg. Soc. 1103 - Cod. op. SM 05675 Posta target - Tariffa pagata - Pubblicità diretta indirizzata Autorizzazione n. 683 del 19.06.2004 della Direzione Generale PP.TT. Rep. Di San Marino TERMS OF SALE 1 - All material is deemed authentic and free of any hidden defects, otherwise it would be indicated. The lots are described with utmost accuracy and good faith. Regarding photographed lots the reproduction is determinant for margins, centring, perforation, cancellation and general aspects of lots. The numeration is in conformity with Sassone catalogue for Italy, Italian territories and Europe while Yvert is used for countries abroad, with the Filagrano catalogue for the Interi Postali. Where appropriate other catalogues will be indicated in the description. -

G155 Angell Hall · 435 S. State St. · Ann Arbor, MI 48109-1003 734-764-4311 · [email protected] · ______
G155 Angell Hall · 435 S. State St. · Ann Arbor, MI 48109-1003 734-764-4311 · [email protected] · http://www.lsa.umich.edu/cgis _____________________________ ITALIAN STUDIES IN ROME, ITALY COURSE DESCRIPTIONS SUMMER 2014 Professor Giorgio Bertellini (U-M Department of Screen Arts and Cultures/Romance Languages and Literatures) When in Rome: Italian Cinema and Its Capital Movie Set, 3 credits The history of Italian cinema has consistently drawn from the representation of Rome as Italy’s center of political power, artistic culture, and public morality—or lack thereof. The very first Italian fiction film, La presa di Roma (The Capture of Rome, 1905), told the story of the 1871 military occupation of the Papal State’s capital by the army of the newly-formed Italian state. The film’s narrative projected onto the “eternal city” two main power strands, one affiliated with the new State, the other with the timeless Vatican. In various ways, the apparent conflict and much more frequent intersections of these civic cultures (and their contrasting claims over public morality) have continued to affect Italian film culture. Films about the Vatican and the Pope abounded in the silent period, but paled in comparison with the notable historical epics (i.e., Spartacus, 1911; Quo Vadis?, 1913) that helped launching Italian cinema onto the world’s film stage before WWI and gave visual support to an incipient nationalism. After the 1922 “March on Rome,” Mussolini sought to impose the image of Rome as a state and imperial capital and downplay its previous fame as the center of the Church. -

Italian Army and Triple Alliance: an Historiographical Analysis
ISSN 2039-2117 (online) Mediterranean Journal of Social Sciences Vol 4 No 4 ISSN 2039-9340 (print) Published by MCSER-CEMAS-Sapienza University of Rome March 2013 Italian Army and Triple Alliance: An Historiographical Analysis Roberto Sciarrone Università La Sapienza di Roma Doi: 10.5901/mjss.2013.v4n4p197 Abstract During the twelve years between the taking of Rome by the conclusion of the Triple Alliance, the Italian army undergoes profound changes, as the policy of the newly unified state. These long twelve years to help us better understand the preparatory stages and the political effects that lead Italy to sign the agreements of the Triple Alliance. The politicians of taking an attitude almost detached, compared to the problems of the armed forces. In the financial crisis. The economic and social backwardness is manifested when we compare with other European countries. The problem that the Italian government has had to deal with the aftermath of Sedan, is transformation of the Italian army under the Prussian model. Keywords: Triple Alliance, Italian Army, Prussian model, Battle of Custoza, German Empire, Kingdom of Italy, Deutscher Krieg, Austro – Prussian war, Third independence war, Sedan, Prussian military system 1. Preamble Durante i dodici anni che separano la presa di Roma dalla stipulazione della Triplice alleanza, l’esercito italiano subisce profonde trasformazioni, come la politica del neo Stato unitario, ricca di colpi di scena e prodiga nel catapultarsi sul palcoscenico internazionale. Il morale dei militari italiani alla vigilia degli anni ’70 dell’800 è sfiduciato, apatia e delusione serpeggiano tra i soldati. I fallimenti del 1866 mantengono vive le polemiche sugli insuccessi di Custoza e Lissa (Scotti, 2004), destinate a riemergere, nei dibattiti in Parlamento, ogni qualvolta si discute circa i progetti di riordinamento dell’esercito (Venosta, 1866). -

Cavour E Bismarck
Dipartimento di Scienze Politiche Cattedra di Storia Contemporanea CAVOUR E BISMARCK UN PARALLELISMO STORICO TRA GLI ARTEFICI DELLE UNITA’ NAZIONALI Relatore Candidato Prof.ssa Vera Capperucci Giovanni Gallo Matricola 074592 Anno accademico 2015/2016 1 2 Introduzione ………………………………………………………………………….. 4 Capitolo primo – La gioventù Cavour 1. L’adolescenza di Cavour ……………………………………………………… 6 2. I viaggi all’estero ……………………………………………………………... 10 3. Ministro della Agricoltura ……………………………………………………. 13 Bismarck 4. Lo Junker ……………………………………………………………………... 15 5. Portavoce della sua classe………………………………………………...........17 6. Le esperienze militari …………………………………………………………..19 Capitolo secondo – Gli esordi politici Cavour 1. Il Connubio …………………………………………………………………....21 2. Il progetto del Conte ………………………………………………………….23 3. Il rapporto con Napoleone III e la Chiesa ………………………………….....26 Bismarck 4. Fautore della Realpolitik ………………………………………………….......30 5. La guerra austro-prussiana ………………………………………………….....32 6. La battaglia di Sedan ………………………………………………………….34 Capitolo terzo - Il completamento dell’opera di unificazione nazionale Cavour 1. L’ultimatum austriaco e la guerra …………………………………………... …36 2. Il rapporto tra Cavour e Garibaldi ………………………………………..…. …39 3. La proclamazione del Regno d’Italia ……………………………………..…….41 Bismarck 4. Proclamazione del II Reich ……………………………………………….…….44 5. Tensioni con il Kaiser …………………………………………………….…….46 Conclusioni ……………………………………………………………………….........47 Bibliografia ……………………………………………………………………….........53 3 INTRODUZIONE Cavour e Bismarck -

Diva: Early Film Culture and Image Theory in Italy
Dalle Vacche, Angela. Diva: Defiance and Passion in Early Italian Cinema. Austin: University of Texas Press, March 2008. Introduction. Mater Dolorosa A “diva” is the most important woman singer, the prima donna on the stage of opera, but this word can also describe an arrogant or temperamental woman. Close to the English word divine, “diva” means goddess, while the label “diva” competes for the spotlight with God, the ultimate divine maker of stars. Whereas God coincides with eternity, stars live and die. The point here is that the word diva strives for timelessness and infinity. By contrast, the word star is about someone special or exceptional or super-human (1), but not comparable to a divinity. In her best moments, the diva involves a certain kind of ineffable spirituality, ritualistic otherness, and an intuitive aura about transcendence. In short, the diva is an anomalous “star” in comparison to the Hollywood model which has defined film stardom for the rest of the world. The diva’s unusual contribution to the history of stardom stems from the cultural specificities of Italian modernity. In early Italian cinema, “diva” meant female star in a “long” feature film of at least sixty minutes, with some close- ups for the heroine and a fairly static use of the camera. The 12 point-of-view shot and the shot reverse shot, two basic features of classical American cinema, did not exist in the Italian films made between 1913 and 1918. However, the point-of-view shot begins to appear around 1919 or 1920 in diva-films. The three most famous divas of this period were Francesca Bertini (1892-1985), Lyda Borelli (1887-1959), and Pina Menichelli (1890-1984). -

Ro Ma , 20 Settembre 1870 Data Epocale Del Mondo Contempora
PIER LUIGIBARROTTA SERGEBERSTEIN ANTONELLOBIAGINI EUGENIOBIAGINI EMMABONINO NADIACIANI LÁSZLÓCSORBA JEAN YVESFRETIGNE GIUSEPPEGALASSO ANDRASGERO DAVIDHOWARTH MAURIZIOISABELLA MARCOPANNELLA ROCCOPEZZIMENTI JOHN F.POLLARD LUCYRIALL LUCATEDESCO ROBERTTOMBS VINCENTVIAENE GRAHAMWATSON Ro m a , 20 settembre 1870 Data epocale del mondo contempora n e o ? Eredità ed attualità. Atti del Colloquio organizzato dal PARTITO RADICALE NONVIOLENTO TRANSNAZIONALE TRANSPARTITO www.radicalparty.org Londra 19 e 20 settembre 2008 con il contributo del gruppo ALLEANZA DEL LIBERALI E DEI DEMOCRATICI PER L’EUROPA MARCO PANNELLA Introduzione . .5 GRAHAM WATSON Saluto . .9 LUCA TEDESCO Anticlericalismi europei e rapporto Stato-Chiesa nel congresso romano del 1904 della Federazione Internazionale del Libero Pensiero . .17 JOHN F. POLLARD Mussolini e l’abolizione del 20 settembre come festività nazionale . .27 SERGE BERSTEIN Le conseguenze degli avvenimenti nei rapporti tra Chiesa e Stato in Francia dal 1870 e la definizione di laicità alla francese. .35 MAURIZIO ISABELLA La politica inglese, la questione Romana, e gli esuli italiani, 1815-1835. .45 ANDRAS GERO Libertà ungherese ed influenza del Risorgimento. .55 EMMA BONINO Una nota di Adriano Sofri. .61 MARCO PANNELLA Introduzione alla seconda giornata. .69 GIUSEPPE GALASSO Gli avvenimenti del 1870 non costituiscono forse una svolta epocale? Eredità e attualità di quell’evento. .71 PIER LUIGI BARROTTA Saluti . .83 EUGENIO BIAGINI Libertà religiosa e processo costituzionale nel Risorgimento . .89 ROCCO PEZZIMENTI Lord Acton, Newman, Rosmini, Manzoni e la questione romana. .103 ROBERT TOMBS Ecco il nemico! Clericalismo, anti-clericalismo e la Questione Romana in Francia, 1870-1877. .117 LUCY RIALL Vittime ed eroi: l’Italia, il Papae la questione di Roma. .125 VINCENT VIAENE Mazzinismo a modo nostro. -

F-4 L'ufficio Difesa Dello Stato
STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO V Reparto Affari Generali - Ufficio Storico L’Ufficio Difesa dello Stato (1903-1915) Vita, funzioni e contraddizioni di una struttura dello Stato Maggiore del Regio Esercito a cura di Paolo FORMIGONI PREMESSA Il fine del lavoro è quello di fornire un quadro della nascita dell’l’Ufficio Difesa dello Stato, quale strumento del capo Stato Maggiore dell’Esercito il quale per la propria specialità di “organo tecnico” deputato a potenziare e coordinare la protezione del territorio metropolitano da eventuali aggressioni, riassume meglio di altri nella propria attività gli orientamenti e i timori della politica estera, e quindi di quella militare, del giovane Regno d’Italia. Si è cercato di ricostruire, attraverso una indagine bibliografica, il periodo precedente la nascita dell’Ufficio e di inquadrarlo nella situazione italiana e internazionale del periodo a cavallo fra XIX e XX secolo. Dall’analisi dei documenti si sono poi ricavate le elementi fondamentali sul funzionamento, l’evoluzione e le procedure dell’Ufficio Difesa attraverso i suoi rapporti con gli altri organi dello Stato Maggiore, i ministeri, i comandi militari, fino al momento dell’entrata in guerra, e al confluire dell’ufficio stesso nel Comando Supremo. 2 PARTE PRIMA 1. L’ITALIA “TRIPLICISTA” 1.1. L’Italia postunitaria Nel 1870 il giovane Regno d’Italia si trovò fin quasi dal giorno successivo alla presa di Roma, sia all’interno dei propri confini che nei rapporti con le altre nazioni europee, in una situazione assai delicata e con mezzi piuttosto limitati per farvi fronte. Mentre il brigantaggio meridionale assorbiva ancora le energie dell’esercito in una lunga operazione di polizia controllo del territorio non priva di aspetti particolarmente brutali, la società nazionale, già scossa dai prodromi di quella che sarà la “questione sociale”, era lacerata da una grave frattura fra la componente laica di ispirazione risorgimentale e quella cattolica, percepita non senza ragione come strumento delle rivendicazioni clericali sui territori del cessato Stato della Chiesa. -

Giovanni Botero, the Gallery of Maps in the Vatican and the Fusion of the Civitas and Urbs in Sixteenth-Century Italy
The Mastery of Space in Early Modern Political Thought Giovanni Botero, the Gallery of Maps in the Vatican and the fusion of the civitas and urbs in sixteenth-century Italy. Joshua Favaloro 2017 Dedicated to my Nonna Santa Maria Favaloro who taught herself to read and write. A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of Bachelor of Arts (Honours) in History, University of Sydney. 1 Acknowledgements This project has been a long time in the making and represents in many respects the culmination of ideas I have explored in my work over the last few years. It was in walking through the Gallery of Maps itself that this project, in its infancy, was conceived. As such, if you will allow me, I invite you to walk through this space and consider its significance for the history of political thought. Firstly, I would like to thank my supervisor Andrew Fitzmaurice for his vast intellect and undying interest in this project. It would not have been possible without his honest advice and constant support. A special mention also goes out to Nicholas Eckstein, who has been a generous and inspiring mentor over many years teaching. Over the course of countless discussions both have made this an enjoyable and enlightening journey. I would also like to thank Mark McKenna for all his steady handed support and guidance over the last year. Thank you also to Peter Hobbins, Emma Baron, Sarah Draper, Donna Draper, Leah Emmanuel, Rebecca Favaloro and Nemanja Kardum all of whom were either kind enough to read multiple drafts or provided invaluable help in other ways. -

Il Risorgimento Nel Cinema All'epoca Del Muto
Storicamente 7-2011 Rivista del Dipartimento di Discipline Storiche, Antropologiche e Geografiche - Università di Bologna - www.storicamente.org ArchetipoLibri, Bologna - www.archetipolibri.it ___________________________________________________________________________ 150° Anniversario Unità d'Italia _______________________________________________________________________________________________________________________________________ Giovanni Lasi Garibaldi e l’epopea garibaldina nel cinema muto italiano. Dalle origini alla Prima guerra mondiale Storicamente ISSN 1825-411X volume 7 - 2011, March 4th 2011, art. 16 DOI: 10.1473/stor101 http://www.storicamente.org/05_studi_ricerche/lasi_garibaldi_film.htm Author’s Address: Univ. Bologna, Dipartimento di Musica e Spettacolo (MUSPE), via Barberia 4, Bologna, I–40123, Italy, [email protected] Abstract: The first film producted by an italian studio was "La presa di Roma - 20 settembre 1870" (Albertini & Santoni, 1905) and the Italian Risorgimento will continue to be one of the most favoured subjects of italian cinematography. In the period of silent screen films, between 1905 and 1927, aproximately 60 films were produced in Italy concerning the Risorgimento, of which at least 30 were regarding Garibaldi and his epic actions. Even in the cinema, Garibaldi continued to be the most representative and emblematic figure of the Risorgimento, and his popularity is often exploited in misleading ways by the figures of power during the first decades of the twentieth century to ideologize the figure of Garibaldi, still through cinema. Keywords: Italian Cinema; Italian Risorgimento; Garibaldi; 19th-20th Century 1 Giovanni Lasi Garibaldi e l’epopea garibaldina nel cinema muto italiano. Dalle origini alla Prima guerra mondiale «Oggi ho visto il volto di Garibaldi; e ora tutta la devozione dei suoi amici mi appare chiara come la luce del giorno. -

Garibaldi Garibaldi
Commiissiione Italliiana Storiia Miilliitare MIInIIStero della dIIfeSa GGiiuusseeppppee GGaarriibbaallddii l’uomo,, il condottiero.. il Generale Acta del Convegno Nazionale di Storia Militare Roma , P alazzo Salviati 10 ottobRe 2007 nel bicentenario della nascita PROPRIETÀ LETTERARIA tutti i diritti riservati: Vietata anche la riproduzione parziale senza autorizzazione © 2008 • Ministero della Difesa CISM - Commissione Italiana di Storia Militare Salita S. Nicola da Tolentino, 1/B - Roma [email protected] PRESENTAZIONE Convegno Nazionale di Storia Militare organizzato a Roma nell‘ottobre 2007 dalla Commissione Italiana di Storia Militare sulla figura di “Giu- seppe Garibaldi, l’uomo, il condottiero, il generale” ha rappresentato un Ilmomento significativo degli studi su Garibaldi. La centralità della figura di Garibaldi nel processo risorgimentale italiano ed europeo è ben nota e non è su questo aspetto, del resto estensivamente trattato ne- gli atti del Convegno raccolti in questo tomo, che intendo soffermarmi. Ciò che più affascina del personaggio Garibaldi è l’essere assurto a “moderno archetipo” della lotta dell’uomo per la libertà, contro la tirannia del potere, ovunque essa si manifesti”. In breve, Garibaldi, come personaggio globale in un mondo, quello del secolo diciannovesimo, non globalizzato. Il mito di Garibaldi dall’Europa alle Americhe ha assunto quindi una valenza universale, ha rappresentato e rappresenta l’aspirazione dei popoli alla libertà ed al diritto di scegliere il proprio futuro e a scrivere la propria storia. Un anelito alla libertà e alla democrazia che oggi, in un mondo globalizzato ancora esposto in molte aree geografiche, dall’Africa all’Asia, a forme di gover- no — sarebbe meglio dire di non governo — tiranniche/dittatoriali, chiama tutti noi all’obbligo di impegnarci per un mondo migliore, più libero, più democrati- co, più giusto. -

Vital Subjects: Race and Biopolitics in Italy, 1860…1920
Vital Subjects Race and Biopolitics in Italy, 1860–1920 Transnational Italian Cultures 1 Transnational Italian Cultures Series editors: Dr Emma Bond, University of St Andrews Professor Derek Duncan, University of St Andrews Transnational Italian Cultures will publish the best research in the expanding ield of postcolonial, global and transnational Italian studies and aim to set a new agenda for academic research on what constitutes Italian culture today. As such, it will move beyond the physical borders of the peninsula as well as identifying existing or evolving transnational presences within the nation in order to relect the vibrant and complex make-up of today’s global Italy. Privileging a cultural studies perspective with an emphasis on the analysis of textual production, the series focuses primarily on the contemporary context but will also include work on earlier periods informed by current postcolonial/transnational methodology. Vital Subjects Race and Biopolitics in Italy, 1860–1920 Rhiannon Noel Welch Vital Subjects LIVERPOOL UNIVERSITY PRESS First published 2016 by Liverpool University Press 4 Cambridge Street Liverpool L69 7ZU Copyright © 2016 Rhiannon Noel Welch he right of Rhiannon Noel Welch to be identiied as the author of this book has been asserted by her in accordance with the Copyright, Design and Patents Act 1988. All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmited, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior writen permission of the publisher. British Library Cataloguing-in-Publication data A British Library CIP record is available print ISBN 978-1-78138-286-8 cased epdf ISBN 978-1-78138-455-8 Typeset by Carnegie Book Production, Lancaster Printed and bound in Poland by BooksFactory.co.uk List of illustrations Contents Fig. -

The Historical Vignettes in the Vatican Galleria Delle Carte Geografiche
The Historical Vignettes in the Vatican Galleria delle Carte Geografiche Candidate Number: R2201 Word Count: 14,984 Supervisor: Dr Paul Taylor MA Art History, Curatorship, and Renaissance Culture CONTENTS List of Illustrations …………………………………………………………………… ii The Historical Vignettes in the Vatican Galleria delle Carte Geografiche Review of Secondary Literature ……………………………………………………… 3 Sources for the Gallery’s Design …………………………………………………… 9 Purpose of the Historical Vignettes …………………………………………………… 16 Restorations of the Gallery …………………………………………………………… 21 The Historical Vignettes …………………………………………………………… 24 Literature on Military Art from Ancient Rome to Italy in the Sixteenth century …… 25 The Artistic Styles of the Vignettes …………………………………………………… 27 Who Painted the Vignettes …………………………………………………………… 31 The Vignettes’ Attitude towards History …………………………………………… 35 Conclusions …………………………………………………………………………… 48 Appendix One …………………………………………………………………………. 53 Appendix Two ……………………………………………………………………. 55 Bibliography …………………………………………………………………………. 56 i LIST OF ILLUSTRATIONS Figure 1: The Gallery of Maps, Vatican City. Image Credit: Franco Cosimo Panini. Figure 2: S. Leo Pont. Max. Attilam furentem reprimit, Gallery of Maps, Vatican City. Image Credit: Franco Cosimo Panini. Figure 3: Matthijs Bril, Pope Leo I halts the army of Attila, map of Mantuae Ducatus, Gallery of Maps, Vatican City. Image Credit: Franco Cosimo Panini. Figure 4: Inscription over the north door, Gallery of Maps, Vatican City. Image Credit: Franco Cosimo Panini. Figure 5: Cartouche for the map of Avenionensis Ditio et Venaisinus Comitatus, Gallery of Maps, Vatican City. Image Credit: Franco Cosimo Panini. Figure 6: Detail of scroll on the map of Sallentina Hydrunti Terra, Gallery of Maps, Vatican City. Image Credit: Franco Cosimo Panini. Figure 7: Inscription over the south door, Gallery of Maps, Vatican City. Image Credit: Franco Cosimo Panini. Figure 8: Detail of scroll on the map of Flaminia, Gallery of Maps, Vatican City.