L'età Dell'oro
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Contemporary Romanian Music for Unaccompanied
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by KU ScholarWorks CONTEMPORARY ROMANIAN MUSIC FOR UNACCOMPANIED CLARINET BY 2009 Cosmin Teodor Hărşian Submitted to the graduate program in the Department of Music and Dance and the Graduate Faculty of the University of Kansas in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Musical Arts. ________________________ Chairperson Committee Members ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ Date defended 04. 21. 2009 The Document Committee for Cosmin Teodor Hărşian certifies that this is the approved version of the following dissertation: CONTEMPORARY ROMANIAN MUSIC FOR UNACCOMPANIED CLARINET Committee: ________________________ Chairperson ________________________ Advisor Date approved 04. 21. 2009 ii ABSTRACT Hărșian, Cosmin Teodor, Contemporary Romanian Music for Unaccompanied Clarinet. Doctor of Musical Arts (Performance), May 2009. Romanian music during the second half of the twentieth century was influenced by the socio-politic environment. During the Communist era, composers struggled among the official ideology, synchronizing with Western compositional trends of the time, and following their own natural style. With the appearance of great instrumentalists like clarinetist Aurelian Octav Popa, composers began writing valuable works that increased the quality and the quantity of the repertoire for this instrument. Works written for clarinet during the second half of the twentieth century represent a wide variety of styles, mixing elements from Western traditions with local elements of concert and folk music. While the four works discussed in this document are demanding upon one’s interpretative abilities and technically challenging, they are also musically rewarding. iii I wish to thank Ioana Hărșian, Voicu Hărșian, Roxana Oberșterescu, Ilie Oberșterescu and Michele Abbott for their patience and support. -
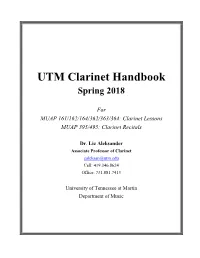
UTM Clarinet Handbook Spring 2018
UTM Clarinet Handbook Spring 2018 For MUAP 161/162/164/362/363/364: Clarinet Lessons MUAP 395/495: Clarinet Recitals Dr. Liz Aleksander Associate Professor of Clarinet [email protected] Cell: 419.346.8624 Office: 731.881.7413 University of Tennessee at Martin Department of Music Table of Contents Table of Contents Welcome ....................................................................................................................................................... 4 General Information ................................................................................................................................. 6 Faculty Contact Information ......................................................................................................................... 6 Communication Policy.................................................................................................................................... 6 Required Equipment & Maintenance ......................................................................................................... 6 Required & Suggested Texts ......................................................................................................................... 7 Borrowed Items ................................................................................................................................................. 8 Ensemble Auditions ......................................................................................................................................... 8 Auxiliary -

L'arte Dell'interpretazione Attraverso Il Racconto Degli Autori Della Fotografia AIC AIC
AIC L'Immagin' ae RecitazionCinematografice a L'arte dell'interpretazione attraverso il racconto degli autori della fotografia AIC AIC » Pier Paolo Pasolini e Maria Callas. J II direttore della fotografia, in un film, dà qualcosa di suo, una qualità ineffabile, che non si riesce a descrive- re a parole, ma che fa riconoscere agli occhi dell'esper- to, lo stile e la qualità della prestazione. Per esempio, Tonino Delli Colli, ha un suo modo tutto particolare di riprendere gli occhi e i lineamenti del volto umano e cer- tamente io mi servo di questa sua straordinaria abilità per ricavare, dal mio punto di vista, tutta l'espressività psicologica dei personaggi. Pier Paolo Pasolini, 1971 AIC AIC ASSOCIAZIONE ITALIANA AUTORI DELLA FOTOGRAFICINEMATOGRAFICAA AIC AIC ASSOCIAZIONE ITALIANA AUTORI DELLA FOTOGRAFIA CINEMATOGRAFICA AIC Associazione Italiana Autori della Fotografia IMAGO Membro "Federazione Europea degli Autori della Fotografia Cinematografica" IMAGO AIC costituita il 13 maggio 1950 AIC Presidente Collegio Sindacale Franco Di Giacomo Sergio Salvati Sebastiano Celeste Sergio D'Offizi Angelo Filippini Alessandro Feirachios Vicepresidenti Mario Vulpiani Paolo Ferrari Alessio Gelsini Torresi Angelo Filippini Giuseppe Lanci Soci effettivi Roberto Forges Davanzati Marcello Montarsi Cesare Accetta Giovanni Galasso Maxime Alexandre Marcello Gatti Segretario generale Manfredo Archinto Alessio Gelsini Torresi Giuseppe Berardini Adolfo Bartoli Roberto Girometti Gianlorenzo Battaglia Giuliano Giustini Consiglieri Tarek Ben Abdallah Antonio Grambone -

Viva Presenza a Siena Dei Compositori Italiani
**p*r*f*M.r '«unii mnl.n, t^ai «Wii'ia '-«-.•*.-_. *#*.~«--4.»« W . » • •---*fr <<r< » » fc #- »•• *Jk «-H ir».** ••• * v»—..*^ !>• »-—,"• • «» i'»«*-• « 4 >lv .1. .<%*4.«Vi -.4 ìli il ! l'Unita / mereoledì 31 agosto 1977 PAG. 7 / spettacol i - a rie \ » < ^ ur Grande successo alla > Basilica di Massenzio I fatti e i problemi della musica » \ Rai $ •. * .n i * >i In progetto oggi vedremo Viva presenza a Siena *' i s i de, H popolo è lontano, ma i ad Arezzo Incontro con problemi non tanto. Sulla Rete due, dopo la i Taviani nuova puntata del telefilm Al posto del consueto Mer della serie Colombo, alle 22 coledì sport stasera, c'è un va in onda un programma dei compositori italiani un Centro film: e cosi, questa settima anch'esso direttamente lega na, poco manca che ci of to al mondo del cinema. Ful frano un film a sera. Non vio Acciallnl e Lucia Coluc- Eseguite opere di Petrassi, Zafred, Encinar e Berio - Manifesta ce ne lamenteremo troppo, celli, della Cooperativa Cine di studi dal momento che le alterna ma Democratico, parlano del zioni commemorative di Bucchi e Frazzi - Accanto ad interpreti tive, assai spesso, non sono fratelli Taviani, della loro ' già affermati si sono fatti apprezzare i giovani allievi dei corsi entusiasmanti. opera, della loro tematica, del Il film di questa sera, Il loro mezzi espressivi, del lo corali ritorno di Harry Collings (ti ro « messaggi ». tolo originale: The Hired - ' Nel servizio c'è un'ampia Del nostro inviato e l'altro hanno avuto in buo dosi, corrano il rischio di per selezione del film di questi na sorte lo 6tato di grazia di dere tanto fervore. -

Faro Film E Rai Cinema
Compagnia Italiana Faro Film Rai Cinema presentano un film di MAURIZIO SCAPARRO con MASSIMO RANIERI L’ULTIMO PULCINELLA ADRIANA ASTI JEAN SOREL VALERIA CAVALLI DOMENICO BALSAMO CARLA FERRARO MARGOT DUFRENE e con GEORGES CORRAFACE con la partecipazione straordinaria di ANTONIO CASAGRANDE Soggetto e Sceneggiatura Rafael Azcona, Diego De Silva, Maurizio Scaparro Musiche Mauro Pagani Distribuzione Bolero Film Distribuzione Internazionale Rai Trade Con il contributo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali Direzione Generale per il Cinema Progetti Speciali 2007 Durata: 89’ Uscita nelle sale: venerdi 13 marzo 2009 Crediti non contrattuali CAST TECNICO Regia Maurizio Scaparro Soggetto e Sceneggiatura Rafael Azcona, Diego De Silva, Maurizio Scaparro. Scenografia Giantito Burchiellaro Arredo Stefania Maggio Costumi Gianni Addante Aiuti Regia Ferdinando Ceriani, Luca Pedrini Suono Mario Iaquone Fotografia Roberto Meddi (A.I.C. Imago) Montaggio Luca Gianfrancesco Musiche Mauro Pagani Edizioni Musicali MACU’ Organizzatore Generale Antonella Viscardi Prodotto da Maria Bellini e Giorgio Magliulo Una Produzione Compagnia Italiana - Faro Film - Rai Cinema Distribuzione Bolero Film Distribuzione Internazionale Rai Trade CAST ARTISTICO Michelangelo Massimo Ranieri Marie Adriana Asti Jean Paul Jean Sorel Paola Valeria Cavalli Francesco Domenico Balsamo Cecilia Carla Ferraro Faiza Margot Dufrene Commissario di Polizia Georges Corraface Proprietario teatro Antonio Casagrande I materiali stampa sono disponibili sul sito: http://www.saverioferragina.com/lultimopulcinella.htm -

International Viola Congress
CONNECTING CULTURES AND GENERATIONS rd 43 International Viola Congress concerts workshops| masterclasses | lectures | viola orchestra Cremona, October 4 - 8, 2016 Calendar of Events Tuesday October 4 8:30 am Competition Registration, Sala Mercanti 4:00 pm Tymendorf-Zamarra Recital, Sala Maffei 9:30 am-12:30 pm Competition Semifinal,Teatro Filo 4:00 pm Stanisławska, Guzowska, Maliszewski 10:00 am Congress Registration, Sala Mercanti Recital, Auditorium 12:30 pm Openinig Ceremony, Auditorium 5:10 pm Bruno Giuranna Lecture-Recital, Auditorium 1:00 pm Russo Rossi Opening Recital, Auditorium 6:10 pm Ettore Causa Recital, Sala Maffei 2:00 pm-5:00 pm Competition Semifinal,Teatro Filo 8:30 pm Competition Final, S.Agostino Church 2:00 pm Dalton Lecture, Sala Maffei Post-concert Café Viola, Locanda il Bissone 3:00 pm AIV General Meeting, Sala Mercanti 5:10 pm Tabea Zimmermann Master Class, Sala Maffei Friday October 7 6:10 pm Alfonso Ghedin Discuss Viola Set-Up, Sala Maffei 9:00 am ESMAE, Sala Maffei 8:30 pm Opening Concert, Auditorium 9:00 am Shore Workshop, Auditorium Post-concert Café Viola, Locanda il Bissone 10:00 am Giallombardo, Kipelainen Recital, Auditorium Wednesday October 5 11:10 am Palmizio Recital, Sala Maffei 12:10 pm Eckert Recital, Sala Maffei 9:00 am Kosmala Workshop, Sala Maffei 9:00 am Cuneo Workshop, Auditorium 12:10 pm Rotterdam/The Hague Recital, Auditorium 10:00 am Alvarez, Richman, Gerling Recital, Sala Maffei 1:00 pm Street Concerts, Various Locations 11:10 am Tabea Zimmermann Recital, Museo del Violino 2:00 pm Viola Orchestra -

Il Recupero Dell'antico Nell'opera Di Ottorino
SCUOLA DI DOTTORATO IN STORIA E CRITICA DEI BENI ARTISTICI , MUSICALI E DELLO SPETTACOLO XXII CICLO IL RECUPERO DELL’ANTICO NELL’OPERA DI OTTORINO RESPIGHI E L’ARCHIVIO DOCUMENTARIO ALLA FONDAZIONE “GIORGIO CINI” DI VENEZIA Coordinatore: prof. ALESSANDRO BALLARIN Supervisore: prof. ANTONIO LOVATO Dottoranda: MARTINA BURAN DATA CONSEGNA TESI 30 giugno 2010 2 A Riccardo e Veronica 3 4 INDICE PREMESSA ………………………………………..…………………………..……. p. 9 I. IL FONDO “OTTORINO RESPIGHI ” ………………………………………… » 13 1. Configurazione originaria del fondo ………………………………………… » 14 2. Interventi di riordino …………………………………………………………. » 16 3. Descrizione del contenuto ……………………………………………………. » 20 II. RITRATTO DI OTTORINO RESPIGHI ……………………………..……..... » 31 1. L’infanzia e le prime opere …………………………………………………... » 32 2. I primi passi verso il recupero dell’antico …………………………………… » 35 3. L’incontro con Elsa …………………………………………………………... » 38 4. Le trascrizioni di musiche antiche e Casa Ricordi …………………………... » 40 5. Il “periodo gregoriano” ……………………………………………………... » 42 6. L’incontro con Claudio Guastalla …………………………………………… » 44 7. Le opere ispirate al gregoriano ……………………………………………… » 46 8. La nomina all’Accademia d’Italia e il Manifesto…………………………….. » 48 9. La fiamma e l’elaborazione dell’Orfeo ………………………………………. » 53 10. Lucrezia ……………………………………………………………………... » 58 III. IL CONTESTO ………………………………………..………………...……… » 63 1. Il recupero dell’antico ………………………………………………………... » 63 1.1 La rinascita del gregoriano …………………………………………. » 64 1.2 Angelo De Santi, Giovanni Tebaldini e Lorenzo Perosi ……………. -

Centro Internazionale Per Le Arti Dello Spettacolo
CENTRO INTERNAZIONALE PER LE ARTI DELLO SPETTACOLO BIOGRAFIE Gianni Letta: Presidente Onorario della Fondazione Franco Zeffirelli Onlus Avezzano (L’Aquila) 15/04/1935. Residente a Roma. Giornalista – Laureato in giurisprudenza. Dopo aver esercitato per alcuni anni la professione forense, nello studio legale del padre, passò al giornalismo militante, una professione nella quale aveva mosso i primi passi già negli anni del Liceo e dell’Università come Corrispondente di Provincia, da Avezzano prima e da L’Aquila poi, dove fu Corrispondente di alcuni quotidiani nazionali, della Rai e dell’Ansa. Nel 1958 si trasferì a Roma come Redattore del quotidiano Il Tempo dove ha fatto esperienza in tutti i Servizi ed in particolare al Servizio Esteri, prima di assumere la responsabilità della Redazione Province e della Segreteria di Redazione quale Redattore Capo. Nel 1971 fu chiamato dalla fiducia di Renato Angiolillo alla Direzione Amministrativa de Il Tempo e successivamente, cooptato nel Consiglio di Amministrazione, assunse la responsabilità di Amministratore Delegato della S.E.R. Società Editoriale Romana e della TI.CO. Tipografica Colonna, rispettivamente editrice e stampatrice del quotidiano romano. Il 16 agosto 1973, alla morte del Senatore Angiolillo, assunse anche la Direzione de Il Tempo che ha tenuto per quasi 15 anni, fino alla fine del 1987. Dal 1973 al 1987 è stato così Amministratore e Direttore del giornale romano che ha poi lasciato per assumere responsabilità manageriali e giornalistiche nel Gruppo Fininvest e nel Consiglio di Amministrazione della Mondadori. Come Vicepresidente di Fininvest Comunicazioni ha rappresentato il Gruppo a Roma, con la responsabilità e la direzione dell’ufficio romano. -

Catalogo Catalogue 2019.Pdf
IN UN MONDO CHE CAMBIA, PUOI AMARE IL CINEMA FESTA DEL CINEMA DI ROMA DA UN’ALTRA PROSPETTIVA. 17-27 Ottobre 2019 PRODOTTO DA MAIN PARTNER Promosso da Partner Istituzionali Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. WE LOVE CINEMA In collaborazione con BNL Main Partner della Festa del Cinema di Roma, dal 17 al 27 ottobre. Seguila da un altro punto di vista, su welovecinema.it e con la nostra app. by BNL - BNP PARIBAS welovecinema.it Sponsor Uffi ciali Auto Uffi ciale La banca per un mondo che cambia Partner Partner Tecnico Main Media Partner TV Uffi ciale Media Partner Sponsor FOOD PROMOTION & EVENTS MANAGEMENT Sponsor Tecnici PRODUZIONI E ALLESTIMENTI L'APP DELLA REGIONE LAZIO CON SCONTI E PROMOZIONI PER I GIOVANI DAI 14 AI 29 ANNI su cinema, eventi, libri, concerti, teatro, sport, turismo, pub e ristoranti SCARICA L’APP DAGLI STORE SCOPRI DI PIÙ NELLO SPAZIO DELLA REGIONE LAZIO ALLA FESTA AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA VIVILE STAGIONI DELLE ARTI CONCERTI FESTIVAL RASSEGNE VIALE PIETRO DE COUBERTIN • 00196 ROMA INFO: 06 8024 1281 • BIGLIETTERIA: 892 101 (SERVIZIO A PAGAMENTO) PROGRAMMAZIONE E BIGLIETTI SU AUDITORIUM.COM Siamo con il CINEMA ITALIANO ovunque voglia arrivare. cinecittaluce.it festadelcinema_165 X240 .indd 1 18/09/19 09:20 esecutivo-pagina-cinema.pdf 1 17/09/2019 09:47:37 C M Y CM MY CY CMY K Lavoriamo ogni giorno per valorizzare il set più bello del mondo. Mazda CX-30 Cat FestaCinema 165x240.indd 1 01/10/19 10:13 SIAE_per_FestaCinemaRoma_2019_165x240.pdf 1 10/09/19 11:47 SOGNI IDEE ARTE EeMOZIONI 14A EDIZIONE | 14TH EDITION -

Descrizione Churchill Disse No All'egemonia Di
10/12/2019 ISTITUTO TECNICO ECONOMICO LICEO LINGUISTICO – LICEO SCIENTIFICO Fachoberschule für Wirtschaft Sprachengymnasium - Realgymnasium “FALCONE E BORSELLINO” “DANTE ALIGHIERI” INFO • Elenco dei DVD posseduti dalla biblioteca scolastica dell’Istituto, in ordine alfabetico secondo il titolo italiano •Alcuni dei dvd presenti non sono prestabili N.B.: tutte le informazioni sono tratte dal sito www.ibs.it 3 0 0 (D159) 117 min. Paese, Anno Stati Uniti, 2007 Regia Zack Snyder Principali interpreti Gerard Butler; Lena Headey; David Wenham; Dominic West; Michael Fassbender; Vincent Regan Descrizione • Genere Storico Il travolgente racconto dell'antica battaglia delle • Produzione Warner Home Termopili, lo scontro titanico nel quale re Leonida e Video, 2007 trecento spartani combatterono fino alla morte contro • Singola faccia, doppio strato (Formato schermo Serse e il suo imponente esercito persiano, pur di 2,40:1) PAL Area 2 ritardarne l'avanzata. Un'avventura epica che parla della • Lingua audio italiano, - passione, del coraggio, della libertà e dello spirito di inglese, sacrificio dei guerrieri spartani, che combatterono una • Lingua sottotitoli inglese - delle più cruente battaglie della storia dell'umanità. Dalla inglese per non udenti - graphic novel di Frank Miller, che combina azione dal italiano - italiano per non udenti vivo con sfondi virtuali. • Contenuticommenti tecnici Premi e riconoscimenti 2007 - Miglior Combattimento MTV Movie Awards 1960 (D272 ) 75 min. Paese, Anno Italia, 2010 Regia Gabriele Salvatores Principali interpreti Giuseppe Cederna Descrizione • Numero dischi 1 Estate 1959. La voce di un adulto rievoca i giorni in cui era • Genere Documentari un bambino del sud che non conosceva nulla. Il ricordo di • Produzione Rai Cinema - quell'estate è ancora vivo nella sua memoria: l'ultima 01 Distribution, 2010 trascorsa con il fratello Rosario, prima di trasferirsi a Milano. -

Il Critico Con La Macchina Da Presa
IL CRITICO CON LA MACCHINA DA PRESA di Massimo GIRALDI e di Gabriele BIGONZONI Leonardo AUTERA * Vincenzo BASSOLI * Francesco BOLZONI * Edoardo BRUNO * Giambattista CAVALLARO * Luigi CHIARINI * Fernaldo DI GIAMMATTEO * Ernesto G. LAURA * Vinicio MARINUCCI * Renato MAY * Domenico MECCOLI * Lino MICCICHE’ * Riccardo NAPOLITANO * Renzo RENZI * Gian Luigi RONDI * Nazareno TADDEI * Paolo di VALMARANA * Mario VERDONE * Gino VISENTINI Associazione Culturale Cineteca Lucana con il sostegno del Ministero Beni e Attività Culturali – Direzione Generale Cinema IL CRITICO CON LA MACCHINA DA PRESA di Massimo GIRALDI e di Gabriele BIGONZONI Associazione Culturale Cineteca Lucana con il sostegno del Ministero Beni e Attività Culturali – Direzione Generale Cinema avvertenze I dati tecnici, artistici e le descrizioni dei soggetti delle filmografie sono ricavati dalla banca dati della Revisione Cinematografica del MiBAC – Direzione Generale Cinema e si riferiscono alle pellicole realizzate per le sale cinematografiche. Dalle filmografie sono esclusi titoli delle riduzioni e dei dialoghi dei film doppiati (particolarmente attivi in questo settore Vinicio Marinucci e Gian Luigi Rondi). Tra parentesi quadra i nomi dubbi o provenienti da altre fonti. Tra parentesi tonda i nomi veri, fatta eccezione per Renato May e per Lino Micciché. SOMMARIO Introduzione e profili: Massimo Giraldi 1 Filmografia: Gabriele Bigonzoni 9 Leonardo AUTERA 10 Vincenzo BASSOLI 18 Francesco BOLZONI 21 Edoardo BRUNO 24 Giambattista CAVALLARO 28 Luigi CHIARINI 31 Fernaldo DI GIAMMATTEO -

PREMIO VALENTINO BUCCHI Parole E Musica Per L'unità Dei Popoli PROGRAMMA: Il Violino Nel 20° E 21°Secolo Prova Eliminator
PREMIO VALENTINO BUCCHI Parole e Musica per l’Unità dei Popoli PROGRAMMA: Il violino nel 20° e 21°secolo Prova eliminatoria I candidati dovranno presentare due pezzi, di autori diversi, di cui uno a scelta dal Gruppo A; Il pezzo obbligatorio - V. Bucchi, Concerto lirico per violino e archi, riduzione per violino e pianoforte (edizione Premio Valentino Bucchi 1993, Via Ubaldino Peruzzi 20, 00139 Roma); - un pezzo a scelta per violino solo, composto e pubblicato nel 20° o nel 21° secolo, di un musicista della stessa nazionalità del candidato. Di questa composizione i candidati dovranno inviare tre copie insieme alla domanda d’iscrizione al concorso. Gruppo A: C. Debussy, Sonate pour violon et piano (Durand, Paris o Peters, London); P. Hindemith, Sonate für Violine allein, Op. 31 n. 1 o n. 2 (Schott’s Söhne, Mainz); E. A. Ysaye, Sonate pour violon seul, Op. 27, n. 3 o n. 6 (Schott Frères, Bruxelles). N.B. - I concorrenti dovranno eseguire le composizioni sopra citate, integralmente o in parte, ad insindacabile giudizio della giuria. Prova semifinale I candidati dovranno presentare tre pezzi di diverso autore scelti rispettivamente: uno dal gruppo A, un secondo dal gruppo B e un terzo dal gruppo C. Gruppo A: B. Bartók, Sonate pour violon et piano n. 1 o n. 2 (Universal, Wien); B. Britten, Three pieces for Violin and Piano, dalla Suite Op. 6 (Boosey & Hawkes, London); L. Dallapiccola, Due studi per violino e pianoforte (Suvini Zerboni, Milano); F. Martin, Sonate, violon et piano, 1931/32 (Universal,Wien); B. Martinu, Sonate pour violon et piano (Salabert, Paris); O.