Storie E Itinerari Dell'industria Ligure
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
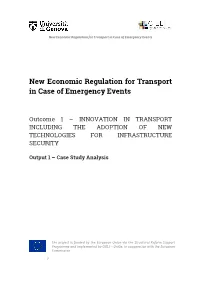
New Economic Regulation for Transport in Case of Emergency Events
New Economic Regulation for Transport in Case of Emergency Events New Economic Regulation for Transport in Case of Emergency Events Outcome 1 – INNOVATION IN TRANSPORT INCLUDING THE ADOPTION OF NEW TECHNOLOGIES FOR INFRASTRUCTURE SECURITY Output 1 – Case Study Analysis The project is funded by the European Union via the Structural Reform Support Programme and implemented by CIELI – UniGe, in cooperation with the European Commission 1 New Economic Regulation for Transport in Case of Emergency Events This deliverable has been produced under a contract with the Union and the opinions expressed are those of CIELI-UniGe and do not represent the official position of the European Commission The project is funded by the European Union via the Structural Reform Support Programme and implemented by CIELI – UniGe, in cooperation with the European Commission 2 New Economic Regulation for Transport in Case of Emergency Events 1 - Introduction On 14 November 2019, the Directorate General for Structural Reform Support of the European Commission (DG REFORM) and Università degli Studi di Genova (UNIGE) - Centro Italiano di Eccellenza sulla Logistica i Trasporti e le Infrastrutture (CIELI) signed a Grant Agreement for an Action under the Structural Reform Support Programme, on “New Economic Regulation For Transport In Case Of Emergency Events”. The action runs for 26 months, starting on 1 February 2020. Briefly, the scope of the Project is to identify a set of actions and procedures to be implemented in case of emergency events that shall deeply affect the transport system. The direct Beneficiary of the Action is the Municipality of Genoa while the “Centro Italiano di Eccellenza sulla Logistica I Trasporti e le Infrastrutture (CIELI)”, University of Genoa, has been identified as the actor who conducts the activities of the Project and manages the dedicated funds. -

La Metro E I Genovesi La Metro E I Genovesi
metrogenova.commagazine G r a t u i t a n˚ 01 | autunno 2006 Rivista indipendente sulla metropolitana di Genova Interviste a: numero Mario Margini (ass.(ass. infrastruttureinfrastrutture ComuneComune didi Genova)Genova) Gianfranco Medri 1 (project(project managermanager AnsaldoAnsaldo TSF)TSF) LaLa metrometro ee ii genovesigenovesi Il difficile rapporto di Genova con la sua metropolitana con l’opinione di Leopoldo Montanari (esperto(esperto didi mobilitàmobilità urbana)urbana) LavoriLavori inin corsocorso GliGli sviluppisviluppi delladella linealinea ComeCome eravamoeravamo LaLa nuovanuova trattatratta LaLa metrometro aa RivaroloRivarolo 1990:1990: lala trattatratta DeDe Ferrari–BrignoleFerrari–Brignole MarassiMarassi ee S.S. Martino?Martino? Brin–DinegroBrin–Dinegro Inoltre Sondaggio le opinioni degli utenti sul metrò | le ultime notizie 02 | edito Un sostegno al progetto della metropolitana gni volta che intraprendo una nuova avventura provo indubbiamente una forte emozione ed il varo di questa Orivista non sfugge a questa regola. La necessità di realizzare questa pubblicazio- ne (circa quattro volte all’anno) sta nel fatto di ampliare l’offerta del nostro sito web, nella spe- ranza di poter diffondere ancora meglio tutto ciò che riguarda la metropolitana genovese. La nostra redazione sta lavorando per regalare a metrogenova.com magazine un futuro radioso e prestigioso; questo non può che essere sinto- matico di un gruppo di lavoro competente, che possiede un inesauribile serbatoio di idee, pron- te a tramutarsi in progetti importanti. Questa rivista si propone di esaminare il problema del trasporto pubblico a 360°, ovviamente con un occhio privilegiato alla metropolitana, trattando anche in modo approfondito le grandi temati- che della mobilità urbana di Genova e della Li- guria; per fare questo, una viva attenzione sarà dedicata anche al sistema ferroviario cittadino e regionale, nonché ad altri sistemi alternativi, come ad esempio le funicolari. -

3Rd Announcement CONTENT
47th EDTNA/ERCA International Conference September 15th-18th, 2018 Genoa, Italy Conference Theme Global Approach to Renal Care Innovation – Balancing Compassion and Health Technologies 3rd Announcement CONTENT Welcome Message from the President 3 Committees 4 Key Dates to Remember 4 Contact Information 5 General Information 6 Scientific Programme Highlights 7 Programme at a Glance 8 International Conference 2018 will include 9 Registration 11 Hotel Accommodation 14 Hotel Locations 16 Exhibition & Sponsorship 17 Corporate Membership 18 Enrich your Life – Become an EDTNA/ERCA Member 19 Publications of EDTNA/ERCA 20 Good to Know about Genoa 21 2 WELCOME MESSAGE FROM THE PRESIDENT Dear Colleagues, It is with great pleasure and pride that we invite you to join us in Genoa where our 47th EDTNA/ERCA International Conference will take place. The theme of our Conference is – ‘Global Approach to Renal Care Innovation – Balancing Compassion and Health Technologies’. The Conference has an important role of educating, exchanging knowledge, information and experience, utilizing the expertise of health care professionals, service leaders, academics, researchers, care givers, persons with renal disease and Industry Partners. Delegates are from around 70 countries, who come together to share experience, innovations and knowledge. The Conference is a showcase for the latest technology and innovation in the treatment of Chronic Kidney Disease. I also would like to take the opportunity to inform you about one of the improvements we have for our Conference this year. We have developed a Conference App and we will include the Scientific Programme, Evaluations of the Sessions and the Conference. You will be able to create your personal programme, look at the Posters and much more. -

Depliant Grande.Qxp
in giro con la metro, per scoprire tutte le risorse culturali e turistiche nel cuore di Genova. Benvenuto nella metropolitana di Genova. Abbiamo pensato a questa Sali su uno dei nostri treni che Per andare a lavorare, Sette stazioni affacciate sulla mappa per guidarti alla scoper- viaggiano nel cuore di Genova: per fare shopping, nostra città ti offrono un servi- ta di Genova con la metropolita- potrai muoverti velocemente, per muoverti e studiare, zio comodo e puntuale. na e per invitarti a conoscere arrivare nei luoghi più per metterci meno tempo, Tecnologia e arte, colori l’ultima stazione aperta caratteristici, dal Porto Antico scegli la metro e saremo felici e architettura, viaggi veloci in piazza Sarzano. a piazza De Ferrari, scoprendo di portarti con noi. e nessuna coda in mezzo itinerari e suggestioni ogni volta al traffico: questa è la metro diverse. di Genova. la metro tra arte e architettura amt.genova.it Cartina © Corigraf - Foto Paliaga - - Paliaga Foto - Corigraf © Cartina Comune di Genova di Comune lunedì / venerdì 8.15 -15.45 8.15 venerdì / lunedì lunedì / venerdì 8.15 - 16.30 - 8.15 venerdì / lunedì Via Bobbio, 250 r 250 Bobbio, Via lunedì / venerdì 8.15 - 15.45 - 8.15 venerdì / lunedì 800-085311 Via Avio, 9 r 9 Avio, Via [email protected] Via Bobbio, 252 r 252 Bobbio, Via Servizio Clienti Numero Verde Numero Clienti Servizio Via D’Annunzio, 8 r 8 D’Annunzio, Via www.amt.genova.it Ufficio Servizio Clienti Clienti Servizio Ufficio Biglietterie contattarci Per Siti di interesse storico e turistico adiacenti alle -
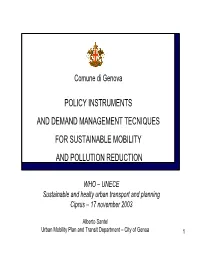
Policy Instruments and Demand Management Tecniques for Sustainable Mobility and Pollution Reduction
Comune di Genova POLICY INSTRUMENTS AND DEMAND MANAGEMENT TECNIQUES FOR SUSTAINABLE MOBILITY AND POLLUTION REDUCTION WHO – UNECE Sustainable and healty urban transport and planning Ciprus – 17 november 2003 Alberto Santel Urban Mobility Plan and Transit Department – City of Genoa 1 GENOA TRANSPORT SITUATION (per day) * DOWNTOWN : 276.278 INHABITANTS - 28 km2 * URBAN AREA : 603.896 INHABITANTS - 239 km2 * 1402 km ROADS LENGHT 300.418 CARS MOTORWAYS : 250.058.628 20.490 LORRIES VEHICLES TO/FROM GENOA 91.256 MOTORVEHICLES MODAL SPLIT ON PEAK HOURS ( 6,30 - 9,30) : 869 TAXIS MOTOS 15,1 % 904 BUS CARS 38,4 % (153 millions of passengers per year) METRO - TRAINS 4,1 % BUSSES 42,4 % Alberto Santel Urban Mobility Plan and Transit Department – City of Genoa 2 Total annual emissions per sector (Genoa Urban area) [ton/year] CO COV NOx Power plant 0.37% 3.69% 39.25% Combustion-Service industry and 1.41% 0.80% 4.60% agriculture Combustion - Industry 30.11% 0.45% 14.05% Production process 0.00% 0.88% 1.28% Mining and distrib. 0.00% 7.33% 0.00% Fossil Comb. Solvent use 0.00% 16.59% 0.00% Road transport 60.12% 59.12% 29.01% Other mobile sources 7.43% 8.11% 11.81% Waste Treatment and 0.00% 2.31% 0.00% removal Agriculture 0.00% 0.33% 0.00% Nature 0.55% 0.39% 0.00% Alberto Santel Urban Mobility Plan and Transit Department – City of Genoa 3 Vehicles on roads 2001 Mopeds 11,6% Motorbikes 20,4% Gasoline cars Bus 55,7% 0,2% HDV 0,7% LDV diesel 2,7% LDV gasoline Diesel cars 1,0% 7,7% Alberto Santel Urban Mobility Plan and Transit Department – City of Genoa 4 -

SEZIONE 2 a Metro Stazioni
AMT S.p.A. - Servizi pulizia Stazioni Metropolitana – specifiche tecniche AMT SpA – Azienda Mobilità e Trasporti – Via L. Montaldo, 2 - Genova Affidamento servizi di pulizia autobus e manovra, pulizia rimesse, metropolitana, Ferrovia Genova Casella, impianti di risalita AMT Specifiche Tecniche SEZIONE 2 METROPOLITANA Sottosezione A) - Pulizia Stazioni Metropolitana 1 di 25 Per Presa visione ed Accettazione, Timbro e Firma di un Legale Rappresentante …………………………………………………………………………….. AMT S.p.A. - Servizi pulizia Stazioni Metropolitana – specifiche tecniche SERVIZIO DI PULIZIA STAZIONI IMPIANTI LOCALI E UFFICI METROPOLITANA DI GENOVA Indice 1 AREE E LOCALI OGGETTO DELLE PRESTAZIONI ......................................................... 3 1.1 Aree aperte al pubblico .............................................................................................................. 3 1.2 Aree non accessibili al pubblico ................................................................................................ 3 1.3 Definizione Aree Prospicienti .................................................................................................... 4 1.4 Aree verdi ................................................................................................................................... 5 1.5 Pulizia Aree difficili ................................................................................................................... 6 1.6 Schema di riferimento ............................................................................................................... -

Sport/Vela: Primazona NEWS N. 44 Di Giovedì 4 Giugno 2020 FIV, Confindustria Nautica, Salone Di Genova E Barcolana: Il Tempo De
Sport/vela: Primazona NEWS n. 44 di giovedì 4 giugno 2020 FIV, Confindustria Nautica, Salone di Genova e Barcolana: il tempo delle sinergie Vela e regate in Liguria Vecchie vele: brigantino a palo ZIO BATTISTA Altura e monotipi: Conclusa la Dragon Summer E-Cup si pensa a scendere in acqua … e oltre: Vecchie vele: gli ultimi velieri oceanici italiani a quattro e cinque alberi Su facebook I Zona FIV: In anteprima le notizie e le foto della vela in Liguria Su www primazona org: Compro & vendo Cerco & offro imbarco per regate, diporto o lavoro Cerco & offro impiego (per istruttori FIV) ….................................. FIV, CONFINDUSTRIA NAUTICA, SALONE DI GENOVA E BARCOLANA: IL TEMPO DELLE SINERGIE 3 giugno - La FIV unisce in un incontro Confindustria Nautica, Salone Nautico e Barcolana per rilanciare la collaborazione tra Genova e Trieste: condiviso un progetto di sinergia e di collaborazione per un "grande ottobre della vela" Insieme per dare visibilità alla nautica italiana nel mondo. Federazione Italiana Vela, Barcolana e Salone Nautico di Genova stanno lavorando in sinergia in vista di un eccezionale ottobre per la nautica e la vela italiana. Nella prima parte di ottobre, infatti, Salone Nautico e Barcolana porteranno l’attenzione degli appassionati su Genova e Trieste, in un ideale passaggio di testimone tra le due manifestazioni, che grazie alla FIV - che ha promosso nei giorni scorsi un incontro tra i vertici dei due eventi – rilanciano la propria, ormai storica partnership, e, in questo anno particolare, propongono una nuova strategia per una comune promozione internazionale dell’economia del mare “made in Italy”. Promuovere assieme, al di fuori dell’Italia, due eccellenze italiane è infatti il fulcro dell’accordo, che consentirà di mantenere alta l’attenzione sul settore e sviluppare un’immagine sinergica tra i due grandi eventi che rappresentano l’Italia del mare nel mondo. -

Cantieri Navali Odero. Storia Roberto Tolaini
Cantieri Navali Odero. Storia Roberto Tolaini 2010 Testo per Storiaindustria.it 1 Ad esclusivo uso didattico. Gli altri diritti riservati. Cantieri Navali Odero. Storia Le origini dei Cantieri Navali Odero risalgono all’alba del processo di industrializzazione genovese quando nel 1846 i fratelli Westermann ottennero in concessione dall’allora comune di Sestri Ponente circa 6 000 m² di arenile per potervi installare un “locale ad uso di fonderia e fabbricazione di macchine d’ogni genere”. Come numerosi altri britannici che si insediarono in Italia in quei decenni, i Westermann erano detentori di conoscenze meccaniche avanzate rispetto alle realtà della penisola, così il loro stabilimento diventò uno dei primi centri di formazione di operai e tecnici specializzati del genovesato. L’officina meccanica si inserì nel tessuto di piccole e medie iniziative locali, ma soprattutto fu orientata a rispondere alla domanda di prodotti in ferro dell’industria delle costruzioni navali sestrese, una delle più importanti realtà dell’Italia pre-unitaria. Non è chiaro quando i Westermann iniziarono loro stessi a costruire grandi navi: in ogni caso nel 1865 l’impianto era considerato “unico nel suo genere in Italia, perché è al tempo stesso un grande cantiere per le costruzioni navali in ferro e con motori a vapore, ed altresì un colossale opificio d’industrie meccaniche”. L’impulso dato dai Westermann alla formazione di una base di esperienze moderne di metalmeccanica fu di indubbio rilievo ed è comprovato anche dalla forza lavoro impiegata che passò da 130 addetti del 1858 ai 300 del 1861. Il successo di questa iniziativa era legato alla capacità di costruire navi dallo scafo composito (ossatura metallica con fasciamento in legno) e di abbinare la classica velatura a sistemi di propulsione a vapore. -

4 Project Committee Meeting
4th Project Committee Meeting Genoa, Italy June 17 – 19, 2015 AGENDA © 2015 PEARL This project has received funding from the European Union´s Seventh Framework Programme for Research, Technological Development and Demonstration under Grant Agreement No 603663 for the research project PEARL (Preparing for Extreme And Rare events in coastal regions). All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a database or retrieval system, or published, in any form or in any way, electronically, mechanically, by print, photoprint, microfilm or any other means without prior written permission from the publisher. The deliverable reflects only the author’s views and the European Union is not liable for any use that may be made of the information contained 4th Project Committee Meeting Genoa, Italy June 17 – 19, 2015 This report is: Dissemination level (select one): PU = Public Contents Contents 1 1 Day 1, Wednesday 17 June 2015 2 2 Day 2, Thursday 18 June 2015 4 3 Day 3, Friday 19 June 2015 5 4 Groups per WP 7 5 CNR Conference Facilities 9 6 About Genoa and Site Visit 10 7 How to get to Genoa and to the Venue 12 8 Suggested Accommodation 18 Agenda – 4th Project Committee Meeting Genoa © PEARL - 1 - 2 – 4 July 2014 1 Day 1, Wednesday 17 June 2015 CNR Office in Genoa, Torre di Francia, via de marini 6, 16149 Genova. 11th floor Meeting Room: Sala Colombo Time schedule: 09:00 – 18.00 Time Item Partner Part 1: Welcome and Introduction Plenary (Moderation by Giorgio Saio and Zoran Vojinovic) 09:00 – Introduction GISIG 09:10 Giorgio Saio -

Lettere Edite Ed Inedite Di Camillo Cavour
1 PURCHASED POR THE UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY FROM THE HUMANITIES RESEARCH COUNCIL SPECIAL GRANE POR ITALIAN STUDIES GENERALI anautici ed alfabetici DELLE LETTERE EDITE ED INEDITE DI CAMILLO CAVOUR raccolte in sei Voltm^i da L\iigi OHiala Compilazione di C. ISAIA EDITORI Tj. HOXJX h: C. - T R I N O N V I- O L l INDICI GENERALI ANALITICI ED ALFABETICI DELLE LETTERE EDITE ED INEDITE DI CAMILLO CAVOUR raccolte in sei Volu.nai da Lxxie-i Ghiaia Cv.lJ Compilazione di C. ISAIA 1887 L. EOUX E C. — Editori Torino-Napoli D6 TROPEIETA LETTERARIA \)'ì AVVERTENZA Quando stavamo per mandare in pubUìco il VI ed idtimo volume delle Lettere edite ed inedite di Ca-r milio Cavour raccolte ed illustrate da L. Ghiaia, ci parve che un'opera così importante per gli studi storici, politici e sociali e così bene accolta da tutti, italiani e stranieri, non potesse dirsi veramente compiida senza un Indice Cleuerale che abhrevìasse e registrasse in un certo ordine analitico e alfabetico tutte le materie con- tenute ne' sei grossi volumi. Persuasi di ciò abbiamo affidato Vincarico di compi- lare questo indice generale alVegregio avv. Cesare Isaia, il quale vi adoperò tanta diligenza e tanto amore da fare in poco tempo un lavoro senza pari per esattezza e per importanza. L'indice generale si triplicò. Bei primi due indici alfabetici (delle persone alle quali sono indirizzate le lettere scritte da C. Cavour e delle persone dalle quali sono scritte le lettere indirizzate a C. Cavour) poco è a dire; essi costituiscono puramente un lavoro, come suol dirsi, di ordine. -

Telesia Metro Anche a Genova Grazie Alla Partnership Con
COMUNICATO STAMPA Più informazioni, notizie e aggiornamenti alle stazioni metro Al via la collaborazione con Telesia Genova, 7 febbraio 2020 L’attesa del treno della metropolitana a Genova diventerà un’occasione per aggiornarsi sui principali fatti del mondo, leggendo notizie di attualità, ed essere sempre al corrente sulle novità dei servizi AMT ma sarà anche un momento piacevole per ascoltare musica e seguire diversi contenuti di intrattenimento. Si tratta del progetto integrato di video informazione realizzato grazie alla partnership tra AMT e Telesia, la media tech company del gruppo Class Editori leader del segmento GO TV, che da oltre 30 anni realizza soluzioni integrate per la video comunicazione in ambienti ad alta frequentazione, come aeroporti e metropolitane. I contenuti visibili sui monitor presenti in banchina nelle stazioni della metropolitana, in tutto 32 schermi divisi tra le stazioni di Brignole, De Ferrari, Sarzano/Sant’Agostino, San Giorgio, Darsena, Dinegro, e Brin, saranno diversificati e si alterneranno in modo da garantire sempre una varietà di argomenti: un vero e proprio palinsesto tv. Saranno ovviamente presenti, e quindi valorizzate dall’efficacia del canale comunicativo, anche tutte le informazioni relative ad AMT con notizie sull’azienda e aggiornamenti in tempo reale sul servizio. Spazio anche per le campagne dedicati ai clienti AMT. Tutti questi contenuti si alterneranno sugli schermi mentre resterà sempre visibile l’indicazione dei tempi di arrivo del treno. La realizzazione del progetto ha richiesto interventi sulle tecnologie di comunicazione portati avanti con investimenti congiunti dalle due aziende. “AMT prosegue nel percorso di innovazione e miglioramento del servizio. La nostra metropolitana è sempre più un asse di forza del trasporto pubblico, usato e apprezzato dai genovesi. -

Presentation Genova Travel Deeplearn 2018
DeepLearn 2018 23-27 July GENOA Genoa is a city that offers a lot in terms of conference facilities and hotel accommodations, which makes it perfect to host congresses & events. Its airport is well connected with the major European cities and the city itself is easily reachable from other airports or transport hubs. Genoa is a living city, where elegant shops, historic shops, lively open-air markets offer continual surprises to the most demanding tourist. Experience Genova is also discover the several souls that compose it. The nineteeth century neighborhood, the fishermen and vacation villages in the East and in the West part, with houses and picturesque glimpses, and the ones in the hinterland, with their untouched traditions. The stage images and the views, appreciated also as film set, are the frame for an intense cultural life: unique museums, great theatrical and musical tradition, important exhibitions and great international shows, such as Euroflora and International Boat Show. The city of Aquarium offers a lot of activities to the people who love the sea: equipped beaches, water sports. PORTO ANTICO CONGRESS CENTER Magazzini del Cotone - Genova PORTO ANTICO CONGRESS CENTER Magazzini del Cotone - Genova Thirteen different sized rooms, 8500 sq. m of space to fit varied arrangements; outdoor space along the Molo Vecchio quai. What is more, the facility is close to airport, train stations, highways, and hotels. Last but not least, at a short walking distance, the Rolli Palaces, UNESCO World Heritage Site. A location justly ranked amongst Italy’s chief conference destinations. PORTO ANTICO CONGRESS CENTER Magazzini del Cotone - Genova HOW TO REACH IT Airport: Genoa’s airport “Cristoforo Colombo” is at 7 Km, 15-minute taxi ride.